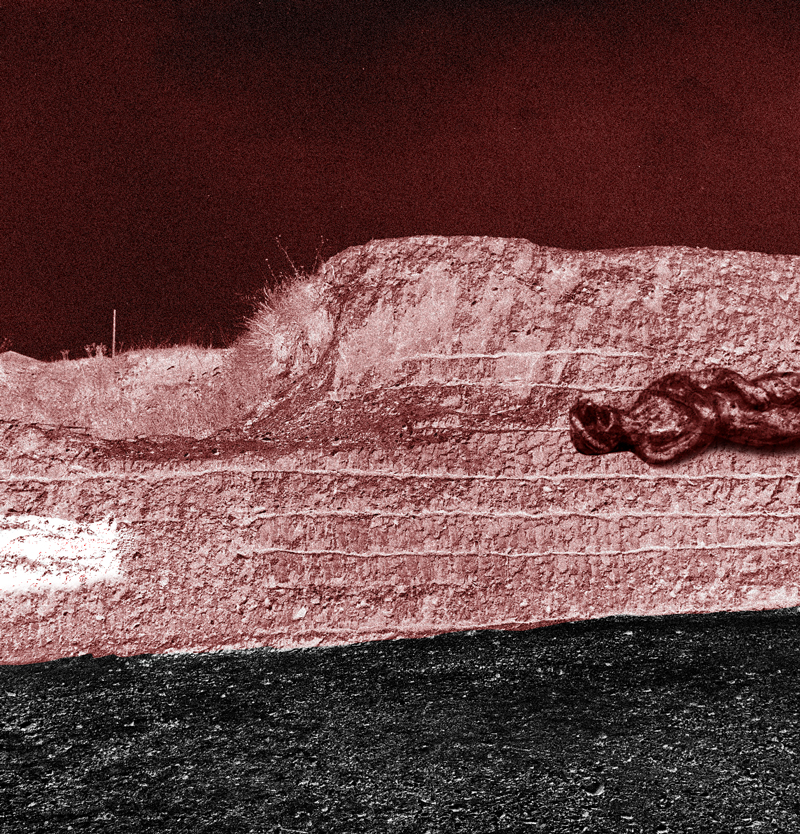
“Tutta la natura è fatta a pezzi, e venduta, mentre noi sogniamo la felicità universale, e la Terra, sotto i nostri piedi, scricchiola”, scrive Anna Maria Ortese in Corpo celeste. Così scricchiola il terreno nel film La chimera di Alice Rohrwacher, sotto i colpi di vanga dei tombaroli che al buio scavano voraci e profanano antiche tombe etrusche. Di fronte a una statua rimasta intatta nelle vestigia di un santuario, i tombaroli non esitano a farla a pezzi, l’unico modo per portarla fuori dal passaggio che si sono scavati, per poi ricomporla e venderla a qualche ricettatore locale.
Lo sguardo della regista segue i loro traffici senza giudizio, il film è un racconto aperto, quasi uno scavo archeologico come quelli che hanno portato alla luce l’arte etrusca. Le parti si lasciano scorgere a loro piacimento, si offrono come pagine di un quaderno strappato. Arthur (interpretato da Josh O’Connor), un archeologo inglese appena uscito dal carcere, torna alla sua casa-baracca cadente col tetto di lamiera. È una creatura di confine, dal destino ibrido, prigioniero della sua vita quanto l’Accattone di Pasolini. Flora (interpretata da Isabella Rossellini), una vecchia signora, madre della donna che Arthur amava, accoglie il giovane nella sua grande villa affrescata, ma cadente anche questa. Italia, allieva di canto di Flora, è intenta a fare a pezzi una sedia per ricavarne legna da ardere (la ritroveremo alla fine del film con martello e chiodi a riparare una sedia nella stazione dove andrà ad abitare con altre donne). Gli amici di Arthur si preparano alla parata per la festa dell’epifania, un rito collettivo per il paese, con tanto di parrucche, banda, musica e falò (che a qualcuno fa venire in mente la Candelora a Montevergine, a qualcun altro il fuoco mancato in nome del decoro al carnevale sociale di Napoli). Ma dopo la festa, col buio tornano le faccende della banda, scavare e trafugare corredi funebri, guidati dal dono di Arthur di trovare cose nascoste.
SE L’ANIMA SCENDE DAL SUO GRADINO
Perché proprio negli anni Ottanta diventa diritto legittimo mercanteggiare e corrompere ciò che fino a quel momento era stato intoccabile? Perché da un certo momento in poi le persone rubano e vendono manufatti e gioielli dalle tombe accanto a cui i loro padri sono cresciuti senza mai violarle? Perché i vasi e le statue smettono di essere cose sacre e diventano solo cose vecchie? Per spiegare di cosa vivono, i tombaroli dicono “aprimo le tombe”, un’occupazione come un’altra. Per loro, semplicemente, l’invisibile non esiste. La cultura dell’avere ha preso il posto di quella dell’essere e ha promesso il paradiso del benessere e del progresso in cambio della distruzione del passato e della tradizione. Ancora in Corpo celeste si legge: “C’è un mondo vecchio, fondato sullo sfruttamento della natura madre, sul disordine della natura umana, sulla certezza che di sacro non vi sia nulla. Io rispondo che tutto è divino e intoccabile […]. E l’uomo non può trasformare questo splendore in scatolame e merce”. Corpo celeste è anche il titolo del film d’esordio di Alice, il percorso di una ragazza al catechismo in un paese della Calabria. Anche La chimera, come il primo film, ragiona di cose nascoste e anima smarrita. Quando le cose smettono di essere animate, diventano merce, e oggi non sorprendono le aste di oggetti di personaggi famosi morti. Ma “se l’anima scende dal suo gradino, la terra muore” (un verso di Mariangela Gualtieri e il titolo di un dialogo tra la poetessa e Alice Rohrwacher per Ciò che ci rende umani 2021 del Teatro Valdoca). La materia diventa più importante della sua storia e solo decenni più tardi torniamo a restituire le storie alle cose, torniamo a chiederci da dove vengano i prodotti, generando intorno a questa tracciabilità l’ennesimo business: bio, made in Italy, chilometro zero. Però qualcuno non ci sta, non ci stanno i Villani: per Totò Fundarò di Alcamo “questa qua è una cosa per ricchi, per pochi, il popolo non se lo può permettere, è una cosa falsa, ‘na minchiata, non esiste. Perché mio nonno o le altre persone hanno abbandonato la terra perché i prodotti buoni glieli pagavano senza soldi, non mi vengano a raccontare che oggi dopo dieci anni le cose buone si devono pagare un sacco di soldi”.
A guardare bene, i tombaroli coi loro traffici stanno solo facendo un favore ai moderni, li alleggeriscono dal peso di un passato da rimuovere. Traffici paralleli impegnano le figlie di Flora, che si affannano a convincere la madre a trasferirsi in una “clinica bellissima immersa nel verde” per poter vendere tutto e liberarsi dal peso degli oggetti vecchi. Guardare Flora mi ha riportato alla prima pagina di Passaggio in ombra di Mariateresa Di Lascia: “Nella casa dove sono rimasta, dopo che tutti se ne sono andati e finalmente si è fatto silenzio, mi trascino pigra e impolverata con i miei vecchi vestiti addosso”. Ogni volta che le figlie vanno a trovare Flora portano via qualcosa, un lume, dei vestiti, profanano la casa della madre camuffando i loro gesti da premure. Leggo sempre su quella pagina: “avranno un gran da fare per svuotare tutto il ciarpame che è stato la mia vita”.
CHI LAVORA FA LA GOBBA
La banda di tombaroli scopre una necropoli etrusca vicino al mare, mare anch’esso profanato dagli impianti di una centrale a carbone. Iniziano a fare a pezzi la statua di una divinità, ma le sirene della polizia li costringono a scappare e riescono a portare via solo la testa. Le guardie sono in realtà la banda rivale, che riesce così a trafugare il resto del corredo funebre e il corpo della dea. La statua senza testa è la protagonista di un’asta per funzionari di musei e galleristi, che ha luogo su una nave di lusso, con pianoforte di sottofondo e champagne a profusione. Arthur e i suoi amici si infiltrano sulla nave per vendere al ricettatore Spartaco anche la testa della statua, e qui uno scambio rapido di battute ci mostra la banda di delinquenti per quello che sono davvero, miseri ingranaggi di un sistema che li sovrasta. Finora apparivano come ribelli più furbi degli altri, in grado di fare soldi sfuggendo alla dialettica schiavi-padroni: “chi lavora fa la gobba, chi non lavora fa la roba”, dice uno di loro quando festeggiano dopo essersi spartiti il compenso per le loro incursioni. Eppure Spartaco (interpretato da Alba Rohrwacher) li disprezza, “si sentono trafficanti d’arte, predatori, ma sono solo piccoli ingranaggi nella ruota al nostro servizio, un giorno la ruggine li divorerà”. Alle sue parole “tiny cogs in the wheel”, laceranti rumori meccanici e immagini di ruote dentate e pistoni in movimento (che mi hanno fatto pensare a un altro film) assestano doppiamente il colpo delle parole.
Se qualsiasi mossa è una stretta al cappio che ci soffoca, allora azione è non agire, disertare, rivendicare un margine di libertà, “la forza del tirarsi indietro, la forza d’ogni rinunciante”, nei versi di Mariangela Gualtieri. Arthur esercita questa forza del non e, un attimo prima di cedere la testa della statua a Spartaco, la lancia in mare, segna una biforcazione, uno scarto a ciò che sembrava già deciso. Scrive Didi-Huberman a proposito del De rerum natura di Lucrezio che “gli atomi ‘declinano’ ininterrottamente ma […] è sufficiente che un atomo compia una leggera deviazione dalla propria traiettoria parallela perché entri in collisione con gli altri, dando origine a un mondo”.
L’ESPULSIONE DELL’ALTRO
Non mi dà tregua l’idea che da un punto in poi l’invisibile, l’anima, la morte diventino idee da folli, siano cacciate fuori dal reale, espulse dalla vita. Vengo da una terra dove il funerale era un pezzo di vita collettivo della comunità, con canti, riti, gesti, codici precisi. Invece oggi fare i conti con la morte è confinato all’individualità, qualcosa da reprimere presto per tornare all’efficienza e al rendimento. In questa comunicazione senza comunità non sappiamo lasciar morire, ma solo mettere in vetrina frammenti commestibili di morte: esporre nelle teche dei musei i manufatti delle tombe etrusche e sulle pagine delle guide turistiche i borghi abbandonati. Civita di Bagnoregio, nello stesso territorio dov’è girato La chimera, è vittima del marchio del “paese che muore”, stretto nei tentacoli del turismo, del fascino per un’apocalisse tascabile da immortalare nel proprio cellulare. A Civita i cortei funebri pedonali sono stati vietati perché ostacolerebbero il flusso di turisti e questo, oltre alla rimozione del rito, dice tanto di quanto il pubblico sia schiacciato dal privato.
Sulla soglia di una stazione abbandonata con i binari ricoperti dall’erba, vediamo Italia esitare sentendo che quel posto “non è di nessuno, è pubblico, è di tutti”. Con la sua aria da funambolo, Italia è la sola capace di non restare schiacciata dal passato, ma di trasformarlo. Se la stazione è proprietà privata, di cosa è privata? Quello che manca lo costruisce insieme alle donne con cui occupa la stazione, dove la ritroviamo a riparare la sedia e a comunicare con Arthur con i gesti, deviando l’ostacolo di una lingua, l’italiano, straniera per entrambi.
La chimera è un affaccio, non è una vicenda in cui immedesimarsi (identificarsi con il protagonista sembra d’obbligo oggi nei film e nelle serie, l’uncino per agganciare lo spettatore). Non essere quei personaggi, ma guardare le persone, lasciarle libere nelle loro faccende senza proiettare la nostra interiorità. Il film chiede allo spettatore di guardare la terra dalla luna, di stare di fronte al materialismo che ha corroso l’anima delle cose e allo squallore che l’uomo ha costruito riducendo il resto a proprio sfondo. Di fronte a una civiltà, quella etrusca, che la bellezza l’ha nascosta sottoterra, una civiltà che ha lavorato per qualcosa di invisibile, ci troviamo schiavi della visibilità, piegati a mostrare una torta, un viaggio, una festa, guardare ed essere guardati (mentre l’unica torta da mostrare davvero la tingiamo di green). La chimera non è un film che consola, che suscita sensazioni di pancia, né un film che fa uscire dalla sala indignati ma tacitamente compiaciuti per il proprio senso civico e critico.
Vedo La chimera in una sala piccola e semivuota a Bolsena, nella stessa Tuscia protagonista dei film di Alice. Poco lontano da me si siede una coppia anziana, che si muove impacciata negli spazi del cinema e attende in silenzio l’inizio della proiezione stropicciandosi gli occhi dalla stanchezza. Non tardo ad accorgermi che ho già visto quei volti, troppo iconici per confonderli anche nella moltitudine: sono nel cortometraggio Omelia contadina, azione cinematografica di Alice Rohrwacher e JR contro le monoculture intensive, un funerale per la civiltà contadina. Tornando a casa, provo a immaginare l’eco che La chimera avrà nelle giornate di quei due anziani contadini, loro che la campagna la vivono quotidianamente da decenni e con fatica, e non saranno impressionati da panorami bucolici a fare da sfondo alle scene. Provo a convincermi che sì, l’anima è scesa dal suo gradino, ma la terra non muore se resta qualcuno a lavorarla, a tracciare solchi e piantare semi. Una chimera. (chiara romano)
Io temo tanto la parola degli uomini.
Dicono tutto sempre così chiaro:
questo si chiama cane e quello casa,
e qui è l’inizio e là è la fine.
[…]
Vorrei ammonirli, fermarli: state lontani.
A me piace sentire le cose cantare.
Voi le toccate: diventano rigide e mute.
Voi mi uccidete le cose.
(Rainer Maria Rilke)





Leave a Reply