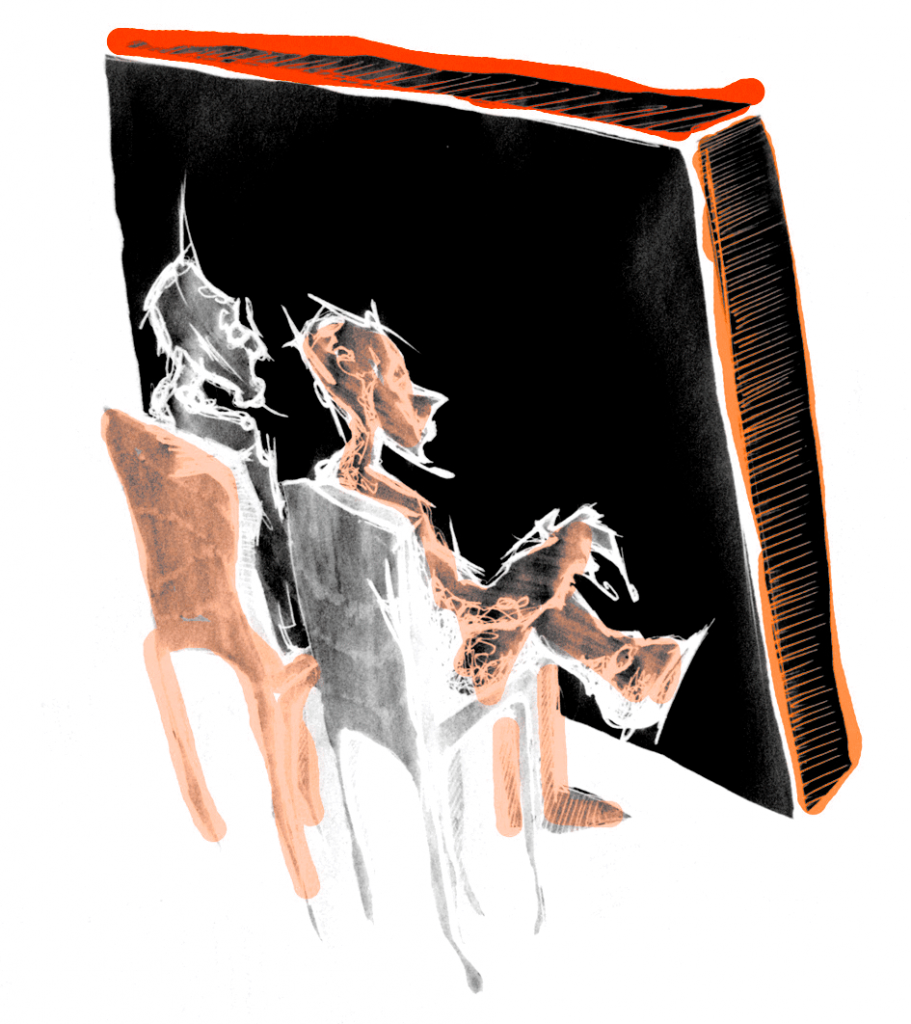
«Può sembrare una battuta cinica ma è la verità: la parabola di Cucchi in quella settimana purtroppo – e sottolineo purtroppo – è una sceneggiatura perfetta». Alessio Cremonini durante la conferenza stampa di presentazione del film Sulla mia pelle alla Biennale del cinema di Venezia.
“L’istante in cui ci si sottrae al verosimile è sempre un istante di verità”. (Christian Metz, “Il dire e il detto al cinema: verso il declino di un verosimile?”, 1989).
Spero mi perdoniate se per cominciare ricorro a un’altra citazione. Questa volta presa dalla stessa testata che mi ospita: “Stefano Cucchi, tossicodipendente, ‘ultimo’ non per nascita ma per biografia, è stato ucciso per il sentimento di impunità che grandi e piccoli poteri di questo paese non perdono occasione di ostentare, quotidianamente. Se anche il film potrà essere un contributo a far conoscere la sua storia, e a far sì che altre delle tante vicende che gli assomigliano non si verifichino ancora, alla verità dei fatti questa pellicola non rende giustizia” (Riccardo Rosa, “Sulla mia pelle. Il film sul caso Cucchi e una denuncia a metà”, 19 settembre 2018).
Il punto di vista sulle cose e l’opinione sul film che le “tratta” non sono separabili, o almeno non dovrebbero. E quindi viene bene cominciare da questa affermazione per tentare una critica tanto agli abiti comuni del pensiero e dell’azione anti-repressivi quanto a una delle opere che in qualche modo li esprimono e sono a essi più o meno organiche. Ma prima della critica l’onestà: ho detestato il film Sulla mia pelle e, pur riconoscendogli delle intenzioni buone, quanto sbagliate, sinceramente lo “disprezzo”. Le virgolette non sono per eufemismo ma perché il termine specifico nella situazione specifica è preso a prestito da gente più grande di me, scrivente e filmante decenni prima di me. E tuttavia lo disprezzo almeno quanto sono in disaccordo e credo ingiuste, ma soprattutto fuori centro, le critiche che all’opera muove Riccardo Rosa. Credo piuttosto che la critica come atto mancato, nella fallace argomentazione di Rosa, si traduca in un’apologia di fatto di quelle intenzioni, buone e sbagliate, coerentemente espresse dal film.
Quali intenzioni? “Far conoscere”. E: “Far sì che non si verifichi più”. Cosa è conoscere? Qual è il rapporto tra questo “conoscere” cui si riferisce Rosa e ciò che accade o non accade nella cosiddetta società dell’informazione? Rosa e Cremonini condividono in realtà le stesse intenzioni, buone e al contempo sbagliate. Di quelle adatte a condurre anche i migliori santi all’inferno. Rosa addebita a Cremonini il fatto di non averle perseguite a sufficienza. In particolare, lamenta precise scene del film che “un po’ per esigenze di sintesi, un po’ per scelta, finiscono per avallare la ‘legge della mela marcia’, accentuando le responsabilità di pochi e diluendo quelle di tutti gli altri, nel caso specifico dell’intero sistema poliziesco, carcerario e giudiziario”.
Falso. Ma non ci agitiamo, nessuno vuole la rissa qua. Il falso ha molte forme, la menzogna non sempre è consapevole, e di sicuro in questo caso non lo è. Rosa scrive libri. Non so se gira anche film, ma nel suo pezzo cita, a giusto diritto, solo libri come termini di paragone per giudicare l’opera; un solo film, l’orribile Diaz di Vicari, per analogia di difetto, appunto sulla legge della mela marcia. Rosa si pone i problemi sbagliati, perché considera un film come si considera un libro. Nel film di Cremonini, se un procedimento si può rinvenire come coerente e rigoroso, nell’impianto di costruzione, è proprio il dispositivo della messa in scena delle varie situazioni successive, che rende bene come sia difficile stabilire la soglia tra la responsabilità personale e il meccanismo microfisico di funzionamento dell’apparato. Foucault, giusto per liberare questo convitato di pietra, le chiamava “piccole astuzie dotate di grande potere di diffusione, disposizioni sottili, d’apparenza innocente, ma profondamente insinuanti, dispositivi che rispondono a inconfessabili economie o perseguono coercizioni senza grandezza: sono esse tuttavia ad aver generato la mutazione del regime punitivo, alle soglie dell’epoca contemporanea” (da Sorvegliare e punire, 1993).
Sembra proprio che Cremonini abbia svolto uno studio foucaultiano in forma filmica, insinuandosi “sotto gli aspetti più modesti” per “cercare non un senso, ma una precauzione, inserirli non solo nella mutua dipendenza da un funzionamento, ma nella coerenza di una tattica” (ibidem). A questo punto direte: ma a che gioco giochiamo qua? Uno attacca il film per difenderlo, l’altro lo difende per attaccarlo… Sì, nei fatti è proprio così. Intanto perché questa coerenza non mostra la capacità minima di sondare il profondo, nelle forme che lo specifico filmico consente e che non sono date una volta per tutte, ma sono sempre sperimentabili e vanno giudicate non “ideologicamente” ma in base all’esito concreto. In questo caso, il pensiero va ad almeno due capitoli della pentalogia filmica di Miklos Janksò, I disperati di Sandor e L’armata a cavallo, non come norma ma come esempio di un cinema in cui sviluppo poetico e capacità del combinato disposto di messinscena e movimento di camera è veramente elettrizzante. Niente a che vedere con la rozzezza para-televisiva delle scene di Sulla mia pelle. Un film a cui si può riconoscere l’asciuttezza tanto decantata, ma solo sul piano dello stile di cinematografare, in cui una pretesa austerità formale, comunque contraddetta in più punti, scade nella sciatteria inespressiva per la presunzione di restituire così più fedelmente una realtà. Un film che dietro questa falsa fedeltà ai “fatti” dissimula, male, un ricatto emotivo sotteso a tutta la ricostruzione della vicenda. Un ricatto che, al fondo, è il vero contenuto del film.
Christian Metz, semiologo del cinema, contesta la distinzione volgare tra forma e contenuto per introdurre una distinzione tra forma e sostanza, tanto del contenuto come dell’espressione. Sintetizzando in due equazioni: i fatti (stanno) alla costruzione poetico-narrativa = la sostanza (sta) alla forma del contenuto; la pellicola o il nastro o il bit (stanno) a in-quadrature, movimenti di camera, ecc. = la sostanza (sta) alla forma dell’espressione. La critica formale è una critica, volente o no, anche politica che riguarda tanto il contenuto come l’espressione. Il cuore della critica formale, quindi politica, che si può e si deve muovere a Sulla mia pelle, tanto sul piano del contenuto come su quello dell’espressione, trova esemplificazione del proprio oggetto nella citazione, dallo stesso Cremonini, posta a premessa di questo intervento; ha un nucleo rovente che si chiama, o meglio è stato chiamato, da Metz tra gli altri, Verosimile, nello specifico Verosimile cinematografico. Nella definizione più sintetica che ne dà, Metz scrive che il Verosimile è “il contrario del Vero”. O ancora “ciò che assomiglia al Vero senza essere tale”. Scrive ancora che l’opera verosimile “vive la sua convenzione – e al limite la sua natura stessa di finzione – con la cattiva coscienza: essa tenta di convincere se stessa, e il pubblico, che le convenzioni che le fanno limitare i possibili non sono leggi del discorso o regole di scrittura – anzi non sono affatto delle convenzioni –, e che il loro effetto, rilevabile nel contenuto dell’opera, è in realtà dovuto alla natura delle cose e attiene ai caratteri intrinseci del soggetto rappresentato, l’opera verosimile vuole essere direttamente traducibile in termini di realtà, e vuole che la si creda tale” (“Il dire e il detto al cinema: verso il declino di un verosimile?”, in Per una nuova critica, 1989).
Poiché non è fedeltà alla realtà, ma ai canoni acquisiti della sua rappresentazione, il verosimile opera la più insidiosa delle censure cinematografiche, quella stilistica, che restringe le possibilità del dicibile filmico. Non crederete davvero che il modo di immaginare, di “vedere” la realtà non sia condizionato dalla storia delle sue rappresentazioni ben più che dalla realtà medesima? I libri e la pittura, poi il cinema, poi la televisione, ora il web: è questo lo “sciame”, per dirla con Byung-Chul Han, in cui si definiscono le coordinate del nostro percepire il mondo, starci dentro e agirci. È a ciò che il verosimile aggancia la propria fedeltà e quella delle nostre percezioni e codifiche personali. Fuori dallo sciame nessuna realtà. È questa la condanna censoria del verosimile ed è su questo fronte che l’opera sperimentale pone la propria sfida. Volta a scoprire infinitamente il mondo anziché ridurlo agli elementi del canone rappresentativo convenzionale che definisce i contorni sociali ed epocali del verosimile, mai come oggi confuso col vero.
Sulla mia pelle è un’opera che nella messinscena, nella scrittura dei dialoghi, nelle scelte stilistiche e nella drammatica (ovvero come si decide che debbano recitare gli attori) persegue il verosimile contro il vero, tanto più secondo una “fedeltà” che richiama più spesso i codici della fiction televisiva che non quelli del cinema. Ecco dunque che il verosimile, cifra fondamentale del film, quale sintesi di elementi riconoscibili, realizza una banalizzazione del reale buona ad alimentare una delle varianti del conformismo, nella fattispecie quello “di sinistra”, come ebbe a ben dire Pasolini. In un contesto storico nel quale le peggiori derive autoritarie e repressive si valgono del consenso delle maggioranze, almeno secondo quanto elettoralmente certificato, Cremonini reagisce a questo consenso non stimolando la critica ma cercando un contro-consenso, rispondendo al senso comune più retrivo col tentativo di diffondere un contro-senso comune, collocando la propria opera in un patetico gioco delle parti mediatico che riproduce il sistema della democrazia da talk show anziché metterlo in crisi. Peccato mortale, per chi scrive, che tuttavia ci porta a condannare l’opera ma non l’autore, se è vero come è vero che nello stesso senso debolezze anche peggiori hanno espresso autori importanti e fecondi, come l’Abel Ferrara di Pasolini (sic!), la cui autorevolezza pone però al riparo dai colpi di certa critica mal engagé. Non è il caso di Cremonini, con cui molto più serenamente ce la si può prendere… o forse no? No. Perché, nel caso specifico, dove viene meno l’autorevolezza sopperisce il ricatto morale del tema, il caso Cucchi, a porre l’autore al riparo da una qualsivoglia critica rigorosa che non venga dalla parte della brutalità di Stato.
“Ed è qui che casca l’asino!”, direbbe Totò. È proprio in questo punto che la critica all’opera diventa disprezzo, sempre per l’opera e mai per l’autore. Poiché non siamo tanto formalisti da pensare che i temi siano equivalenti, e quindi un tema grave come l’omicidio di Stato di Stefano Cucchi impone responsabilità maggiormente gravi. Non certo per bigottismo oscurantista. Come scriveva Bazìn: “Il cinema può dire tutto ma non mostrare tutto. Non ci sono situazioni sessuali, morali o no, scandalose o banali, normali o patologiche, la cui espressione sia proibita a priori sullo schermo, ma a condizione di ricorrere alle possibilità d’astrazione del linguaggio cinematografico in maniera tale che l’immagine non possa mai assumere valore documentario” (“In margine a L’erotismo al cinema”, in Che cosa è il cinema?, 1999).
Il verosimile applicato alla vicenda narrata, nel film Sulla mia pelle, attribuisce valore pseudo-documentario, che Pasolini definirebbe pornografico, a quel mostrare il corpo di Stefano, la tristezza disperata degli ultimi momenti d’agonia, il dolore dei suoi familiari. Ciò che conduce l’operazione a una “abiezione” ben peggiore di quella che Rivette contestava al carrello finale del Kapò di Gillo Pontecorvo. E, sia detto a chiare lettere, suonano decisamente come un’ammissione di colpa eventuali appelli rivendicatori al realismo, cui rispondiamo con le parole dello stesso Rivette: “Per molteplici ragioni, facili da capire, il realismo assoluto, o quello che può aver luogo al cinema, è in questo caso impossibile; ogni tentativo in tale direzione è necessariamente incompleto (quindi immorale)” (Jacques Rivette, “De l’abjection”, Cahiers du cinéma, n. 120, 1961). È chiaro che qui si prendono in prestito le parole di Rivette non per riferirsi al Realismo tout court ma bensì a quello che si realizza nel Verosimile.
La medietas – anch’essa in più punti contraddetta – del film di Cremonini, che tanti scambiano per sobrietà, e probabilmente tale sarebbe nelle intenzioni, viene proprio dallo stare in mezzo, né trasfigurazione irrealistica né crudeltà scioccante, bensì crudezza sostenibile, tant’è che nessuno lamenta l’inguardabilità del film, come invece accadeva ieri per il Salò di Pasolini (e sfido a un sondaggio per verificare quanti l’abbiano visto per intero e quanti l’abbiano rivisto anche solo una seconda volta) e oggi per il Redacted di Brian De Palma. Niente di tutto ciò nel film di Cremonini, che si ferma entro i confini della sopportabilità e in ciò non sfugge, al di là di ogni superficiale apparenza, a quello che Ivelise Perniola definisce “eufemismo” dell’immagine cinematografica, che in questo caso rende sopportabile, ancorché disturbante, ciò che nella realtà sopportabile non è, o non dovrebbe essere.
Qual è il prezzo della sopportabilità spettacolare cinematografica del dolore? La banalizzazione, in vari gradi e forme. In un articolo che riprende a trent’anni di distanza l’intervento di Rivette, Serge Daney chiama in causa il film sui campi di sterminio nazisti di Resnais, Notte e nebbia, descrivendo come “fui coinvolto, piuttosto paralizzato da questa scoperta, nel partito della colpa di tutti… La necrofilia era dunque il prezzo di questo “ritardo” e insieme il contrappasso di questo sguardo “giusto”, quello dell’Europa colpevole, come di Resnais: e di conseguenza, mio”. (“Le travellin de Kapo”, Traffic n. 4, 1992).
Al contrario della rappresentazione disturbante eppur sopportabile, verosimile, di Cremonini, che consola lo spettatore nella convinzione di essere dalla parte giusta per il solo fatto di andare a vedere il film (con la benedizione della Lucky Red e di Netflix: in cinque giorni un incasso di 244.479 euro, nonostante il boicottaggio autodifensivo di molte sale, nonché l’imperialistica copertura web in centonovanta paesi), al contrario, dicevamo, Resnais, Pasolini, De Palma ci lasciano sgomenti, oltre e contro ogni possibile convinzione che “nella visione si esaurisca il potere della conoscenza” (Ivelise Perniola, “Cinema e biopolitica: iconoclastia, eufemismo e falsa coscienza umanitaria”, in Bianco e Nero, n. 565, 2009).
E qui torniamo al punto di partenza. La convinzione di Riccardo Rosa, che il “far conoscere” nei termini di cui sopra possa “far sì che non succeda più” è la più nefasta delle illusioni proprie alla società dell’informazione e della simulazione, quella temperie in cui, per dirla con Baudrillard, “è un principio di simulazione quello che ormai ci governa al posto dell’antico principio di realtà” (“Lo scambio simbolico e la morte”, 2015). Nella fattispecie, lo scandalo è la simulazione che copre la realtà delle cose. Poiché è uno scandalo simulato.
La microfisica del potere, della disciplina, del controllo sociale, del comando biopolitico non risponde, o almeno non in termini assoluti, agli sviluppi legislativi che ne definiscono solo il quadro generale astratto e formale, realizzandosi piuttosto concretamente come “un’anatomia politica del dettaglio” (Foucault). In questa dimensione, l’impunità non è mai davvero presunta ma solo calcolo relativamente aleatorio dei carnefici organizzati, sostenibile in base all’economia del rapporto tra i costi e i benefici dell’organizzazione carnefice in cui sono inquadrati, secondo l’adagio romanesco per cui “a chi tocca nun se ‘ngrugna”. Questa conclusione è d’altronde confermata dall’andamento delle cose anche in relazione al caso Cucchi, se si pensa alle conseguenze subite, a opera dell’apparato statale e di corpo, dal carabiniere che con la sua testimonianza ha fatto riaprire il processo, alle reazioni al film dei vari sindacati e associazioni di categoria di polizia e carabinieri, alla stessa successione degli episodi, noti o sconosciuti, che dai prodromi delle manifestazioni di Napoli e Genova 2001 procedono, in costanza di relativi processi e condanne, fino agli “abusi” diffusi dei casi più recenti (oltre quello di Stefano sarebbe lunghissimo l’elenco dei soli noti), secondo lo svolgimento progressivo di un’inesorabile fenomenologia del monopolio della violenza in capo allo Stato, nella congiuntura dell’attuale crisi epocale che sembra prefigurare nuove forme di totalitarismo capitalista dagli echi nazisti.
Quello che resta negli occhi e nelle orecchie di chi scrive, dopo questa sconfortante disanima, è il ricordo confortante della rivelazione non riconciliabile espressa una volta per tutte per le vie di Torpignattara, il quartiere di Stefano, nel 2009, quando “l’assurdità di questa morte non ha impedito un massiccio dispiegamento delle forze dell’ordine all’interno del quartiere. Una presenza provocatoria verso la quale si è espressa con forza l’indignazione dei manifestanti, attraverso i blocchi stradali e la resistenza alle cariche della polizia e al lancio di lacrimogeni” (Globalproject/info, 7 novembre 2009). (arturo lavorato)





Leave a Reply