
Il 20 settembre scorso il film Io Capitano è stato scelto dal comitato che si occupa della selezione per il film italiano da designare agli Oscar per rappresentare il paese alla novantaseiesima edizione degli Academy Awards (categoria: International Feature Film Award). Il film di Garrone racconta il viaggio di due ragazzi senegalesi dalla città natale alle coste italiane.
In queste settimane il dibattito sul film è acceso e riguarda diversi aspetti: la rielaborazione delle testimonianze di chi viaggia, la dimensione etica dei personaggi, le tecniche della rappresentazione, la mancata analisi tanto delle responsabilità del mondo occidentale nelle torture che i viaggiatori subiscono sul continente africano, quanto delle forme di oppressione e confinamento che attendono in Europa chi viaggia senza documenti.
Pubblichiamo a seguire una storia orale raccolta da Manuela Cencetti e contenuta nel numero 10 de Lo stato delle città. Questo racconto presenta analogie e differenze con l’opera di Garrone e può arricchire il dibattito.
* * *
«Sono vissuto in Mali fino a quindici anni. Ho fatto per otto anni la scuola dell’obbligo nella mia città. Sono andato via perché le persone della mia famiglia sono povere, ho cominciato a cercare dei modi per fare dei soldi e aiutare. Poi sono andato in un’altra regione del Mali che si chiama Gao, sono partito per cercare lavoro perché in quel momento lavoravo solo per strada. Andavo in giro tutto il giorno per cercare qualcuno che avesse bisogno di aggiustare le scarpe o uno zaino, giravo dal mattino alla sera. Poi ho sentito che tanti amici andavano in Algeria per arrivare in Spagna o in Italia. Allora ho chiesto informazioni e ho capito che per fare la strada che porta in Algeria dovevo andare nella capitale. Tanti mi dicevano che lavorare in Algeria è un po’ meglio del Mali. In Algeria si trova lavoro come muratore, in campagna, ci sono tanti lavori da fare, come i traslochi di una casa, sempre per gli algerini. Dalla capitale del Mali fino alla regione nord di Kidal sono quasi quattro giorni di viaggio. Più di duemila chilometri.
«Una volta arrivati in Algeria si cerca un posto dove dormire, lì c’è come un foyer, non lo so come si dice in italiano, è una casa normale. Ogni mese devi pagare al proprietario un affitto, allora uno che sta lì da tanto tempo prende una casa completa per affittare ad altra gente. Quando arrivano altri vanno a dormire lì e devono pagare un tanto al mese per il loro posto. Ho lavorato anche in Algeria, dormivo con un paesano che mi faceva tagliare le pietre con la macchinetta per strada, le pietre per una casa, lavoravamo per un algerino ricco. Dato che c’era una persona del mio stesso paese che dormiva lì, io sono andato a dormire da loro. In Algeria uscivo la mattina presto e andavo alla rotonda per cercare lavoro. Alla rotonda è come la piazza qui, tutte le mattine c’è gente che cerca lavoro. Vengono gli algerini con la macchina, qualcuno cerca dei muratori, qualcuno vuole uno che tagli l’erba, ti dicono: “Amico, vieni qua. Io voglio una persona per lavorare una giornata”. Se io voglio andare gli chiedo: “Quanto mi dai?”, e lui: “Trenta dinari, o quaranta, cinquanta, dipende”. Pochi, va bene. Allora tu sali in macchina con lui, ti porta al campo, tu lavori, alla sera ti riporta di nuovo nella piazza. «Oppure non lo sai, e il tipo magari è un poliziotto in borghese. Loro della polizia non sanno dove dormiamo, non conoscono la casa dove stiamo. Alcuni a volte ti prendono per lavorare, poi alla sera ti portano a casa, ma solo per capire dove abiti. Poi si organizzano per attaccare quel palazzo. Vengono e prendono tutta la gente africana e la mettono in galera, hai capito? Tutti gli stranieri che abitano in quel palazzo, capito? A me è capitato a Ghardaïa. Io ho fatto la prigione in Algeria. In quel momento tra il Mali e l’Algeria esiste una Visa per studenti, per turisti, con quella non puoi lavorare. Quando mi hanno messo in galera è perché mi hanno trovato in un posto dove non potevo dormire. Io dovevo dormire in un hotel, o in centro città, in una casa normale. Perché avevo scritto sulla carta d’identità che ero uno studente. Ma mi hanno trovato in campagna, dormivo lì. Mi hanno messo tre giorni in prigione lì a Ghardaïa e poi mi hanno mandato in un’altra prigione di un’altra città che si chiama In Salah e poi ho fatto due o tre giorni fino alla frontiera con il Mali, la frontiera si chiama Tamanrasset. Ho fatto tre galere in tutti quei posti lì. Poi c’è l’ultima città, lì non c’è acqua ma solo deserto, c’è solo un muro come frontiera.
«In carcere tutti i prigionieri sono chiusi in una camera grande, devi dormire lì, dormi sopra i cartoni, solo sulla terra, non c’è il letto. Il mangiare non va bene. Ti fanno un riso mal cucinato, lo danno ai prigionieri. In quelle prigioni puoi morire. Non è che si muore perché ti trattano male, si può morire così, e la vita è finita. Una morte naturale, hai capito? Per esempio, possono metterti nella cella qualcuno che non sta male, che sta bene, e muore lo stesso. Oppure arrivano alcuni che sono stati picchiati prima di arrivare in prigione e allora muoiono male, capita anche quello. Alcuni stanno male, per esempio hanno il mal di testa o la febbre e muoiono di malattia lì in prigione. Tanti muoiono perché vengono trattati male. Ti picchiano dentro la prigione. Fuori ti possono aggredire, ti possono accoltellare.
VERSO LAMPEDUSA
«In Libia ho lavorato in una fabbrica di succhi di frutta, a Tripoli. Avevo sedici anni. Facevo i turni, lavoravo una settimana di notte, una settimana di mattina presto, una settimana di sera. Per andare in Europa devi per forza attraversare la Libia. L’Algeria è una strada per passare. Chi ha già dei soldi non deve fermarsi in Algeria, può pagare il viaggio fino in Libia, o fino in Marocco. Poi da lì deve cercare un gruppo, una nave, per attraversare il mare e poter entrare in Spagna o partire dalla Libia ed entrare in Italia. In quei paesi sono i colonnelli che possono organizzare i viaggi. Per esempio, in Libia sono i colonnelli libici che fanno questo business, capito? Devi avere il contatto con un africano che lavora con loro. Allora lui è responsabile, lui sa in quale giorno il gruppo del colonnello controlla il mare, capito? Perché il mare è sotto il controllo del governo. Io sono partito dalla Libia con una barca che era sotto il controllo di un colonnello libico. Non ricordo il suo nome. È un colonnello dell’esercito libico. Lui ha fiducia in un africano camerunese che cerca i clienti per lui, per fare il viaggio, allora il ragazzo del Camerun deve organizzare più di cento, duecento persone. Il giorno in cui il gruppo dei militari del colonnello controlla il mare allora la nave può partire per l’Italia, così nessuno la ferma. Loro lo sanno che quella è la sua nave ed è lui che ha organizzato il viaggio, capito? Lui fa il business e lavora anche per il governo, per l’esercito.
«Quelli che guidano le barche non sono dell’esercito. Tra noi viaggiatori qualcuno deve guidare, magari è un marocchino o un algerino o un africano che sa guidare la barca, magari è uno che viene da un paese di navigatori come i senegalesi. Qualsiasi persona può saper guidare la barca, può essere un africano, un marocchino, può essere anche un paesano, anche un libico ma deve essere vestito da civile, come uno che vuole entrare in Europa, non può venire con l’uniforme, come uno del governo. Non so di chi sono le barche, quello che so è che devi cercare il gruppo per venire qua, devi cercare un business, devi cercare un capo nero che forma un gruppo e dirgli che vuoi andare in Europa. Poi loro ti dicono: “Ok Moussa, questo mese o questo giorno noi abbiamo un gruppo da mandare in Europa, se tu vuoi partecipare paga questi soldi”. Dice: “Paga mille euro, ottocento dollari”, dipende. Se pago, allora viene un giorno nel posto dove dormo e mi dice: “Moussa, quel giorno vengo a prenderti”, allora viene a prenderci con un furgone chiuso, mette dentro la gente, mette venti, trenta persone chiuse come animali, poi guida fino a fuori, nella campagna libica, vicino al mare. Loro hanno una casa in campagna, ci mettono lì fino al giorno in cui si deve partire. Devi stare lì un po’ di giorni. Allora può succedere che alcuni fanno i furbi e dicono alla polizia che in quella casa c’è gente che dorme, gente che vuole andare in Europa. Nella notte arriva la polizia e prende tutti, porta tutti indietro e i tuoi soldi sono persi. Devi cominciare di nuovo da zero, capito? Fanno così.
«Tu da quella casa senti il rumore del mare. Quando siamo arrivati lì c’erano altre venti persone: nigeriani, maschi e femmine. C’erano anche altri della Somalia. E anche dell’Etiopia, loro vengono dal Sudan. Il giorno della partenza ci hanno detto: “Oggi a mezzanotte andiamo vicino alla nave”. Sulla barca quella notte hanno caricato più di duecento persone. Non è una nave grande, è una nave dove si può stare sopra e sotto, come una casa. Noi siamo arrivati a Lampedusa. Mi ricordo il giorno esatto in cui sono arrivato lì. Mi ricordo anche la prima foto che mi hanno fatto. La prima volta che sono tornato in Mali in vacanza ho lasciato quella foto a mia mamma.
DA ROSARNO A FOGGIA
«Quando siamo arrivati da qualche parte vicino a Lampedusa era pomeriggio e come prima cosa un elicottero ci è arrivato sopra. Poi è arrivata una nave piccola dei dottori, era come un’ambulanza, dopo è arrivata una nave molto grande. Ci hanno buttato la corda da legare per avvicinare la nave e poi ci hanno preso uno per uno, per scaricarci sulla barca degli italiani. Chi stava male è stato caricato sulla piccola nave ambulanza, quella è più veloce. Due donne vomitavano, altri due ragazzi li hanno caricati lì, ma gli altri sono saliti sulla nave grande. Fino a Lampedusa. Quando ci siamo allontanati con la nave italiana abbiamo visto che hanno bruciato la nostra barca. Noi stiamo guardando e vediamo che gli danno fuoco nel mare. Quando arrivi all’isola chiedono sempre: “Chi ha guidato la barca?”. Ma non si può dire. Anche se ti chiedono: “Tu sai chi ha guidato?”, io non lo so. Non si dice. Quello della nostra barca era bianco, se non era egiziano era tunisino.
«Quando siamo arrivati nel porto di Lampedusa ci hanno diviso. Noi maliani e altri paesani ci hanno messo da una parte, gli egiziani da un’altra. Mentre eravamo ancora in Africa abbiamo sentito che c’è stato un casino a Lampedusa, che hanno dato fuoco al campo. Quando arrivi a Lampedusa le autorità decidono: gli immigrati che vanno a Crotone devono prendere un aereo. Poi c’è chi va in Sicilia, chi va a Roma. Quando arriviamo a Crotone ci portano al campo Sant’Anna. Poi quelli del campo mi hanno detto: “Tu devi uscire dal campo”, ma io ho risposto che sono minorenne, ho detto: “Dove vado? Non conosco nessuno in Italia”. Dovevo uscire a basta. Ho sentito un amico e lui mi ha detto: “Vieni a Rosarno, tanto Rosarno non è lontano da Crotone”. Al campo mi hanno dato un biglietto del treno per andare a Rosarno, senza soldi ho preso il treno.
«A Rosarno dormivamo su una collina, c’era una casa abbandonata, una casa di campagna. La collina è un po’ lontana dal centro, quasi due chilometri. È una casa grande. Quando arrivi devi cercarti un letto, un materasso vecchio, devi cercare in giro se hanno buttato qualcosa. Oppure cerchi delle pietre, metti delle assi di legno sopra le pietre, lì è un po’ meglio, dormi un po’ meglio. A Rosarno ho cominciato a raccogliere le arance. Nei campi tutti parlano la nostra lingua. Ho iniziato a lavorare con quelli che stavano già lì. A Rosarno non c’è troppo il capo nero [il caporale], io vado con la bicicletta, cerco un padrone, poi il padrone del campo viene a prenderci con il trattore per portarci a raccogliere i mandarini. Ho fatto qualche lavoro lì, ho guadagnato qualche soldo. Non mi hanno trattato male, ero molto piccolo in quel momento. Ma c’è un problema grosso lì, non fa parte del lavoro. Io sono scappato da tante macchine che volevano investirmi. Se tu sei in bici e loro sono in macchina non ti rispettano, se non stai attento cercano subito di ammazzarti. Mentre tu sei in bici quelli del paese ti vengono dietro con la macchina, abbassano il finestrino, tirano fuori un bastone di legno e ti prendono a bastonate sulla schiena, sulla testa, ti danno un colpo con un bastone grande e scappano, a me è capitato. Ti colpiscono o ti investono con la macchina e ti lasciano a terra. Lo fanno perché sono razzisti ma anche per maleducazione, capisci?
«Il 7 gennaio 2010 ho sentito che hanno sparato a un africano per strada. È successo che c’erano degli africani che camminavano per strada e dei mafiosi hanno sparato contro di loro, per strada con la pistola. È successo appena fuori città, poi tutti hanno iniziato a parlare con tutti, tutti gli stranieri che stavano lì si parlavano, marocchini, algerini, tutti gli stranieri che vivevano a Rosarno. Tutti quelli che vivono lì hanno parlato tra loro e hanno detto che ci sarà una manifestazione. Noi siamo nuovi, non capiamo niente. Siamo usciti il giorno 8 per andare a manifestare nel centro di Rosarno. E così l’8 gennaio volevamo andare dal sindaco di Rosarno per fare la manifestazione, ma prima di arrivare lì, mamma mia! Mentre camminiamo per la strada, se troviamo una macchina di italiani la spacchiamo. A un certo punto ho trovato un italiano vecchio davanti a me, era dentro la macchina, l’abbiamo fermato, lui è uscito dalla macchina con una pistola piccolina così, una vera pistola, ti giuro! E lui diceva che se qualcuno gli toccava la macchina ci sparava! Abbiamo avuto paura e siamo andati via, anche lui è andato via. Lui ha visto che avevamo spaccato tante macchine dei bianchi, perché quando incontriamo le macchine dei neri non le tocchiamo, ma quando vediamo le macchine dei bianchi le fermiamo, apriamo la macchina, diciamo: “Esci fuori”, e rompiamo i vetri della macchina. Io ho spaccato quattro macchine prima di incontrare quel vecchietto lì, andavamo avanti tutti insieme.
«Quelle persone a cui avevano sparato, io le conosco, loro non hanno fatto nulla, conosco un ragazzo a cui hanno sparato, è della Guinea. Quando abbiamo fatto la manifestazione, quando siamo arrivati in città, abbiamo buttato per strada tutta la poubelle [la spazzatura]. Siamo arrivati in città con il nervoso, eravamo molto arrabbiati! Eravamo tanti, non so quanti. Mamma mia! C’erano anche alcuni italiani con noi, c’erano anche tanti antirazzisti insieme a noi. Per tutta la giornata, il giorno 8, abbiamo fatto la manifestazione, fino a mezzanotte. Il giorno 9 la gente di Rosarno non voleva più vedere gli africani e allora sono arrivati i carabinieri, sono venuti a prenderci lì dove dormivamo sulla collina, ci hanno accompagnato ai pullman, c’erano tanti pullman. Prendevano le persone che vivono in campagna e le portavano al campo di Crotone, altre a Reggio Calabria, altre a Gioia Tauro, ma io ero piccolo e allora mi hanno portato a Bari, troppo lontano. Bari, vicino a Foggia.
«Il problema è che se tu riesci a trovare lavoro con un padrone, il padrone non ti paga, i padroni non ci rispettano, capito? Quello è un problema. Nel 2010, quando è successa la rivolta, c’erano tante persone che stavano lavorando e nessuno era stato pagato. Perché a Rosarno tu vai a lavorare per gli italiani e loro ti dicono: “Ti pago tra una settimana, ti pago tra un mese”. Alla fine del mese, quando il lavoro è finito, non ti danno nessun soldo. Se protesti loro ti fanno vedere la pistola, se protesti ti sparano. È successo ai miei amici. Lì avevo trovato il padrone di una fabbrica dove trattano i mandarini. Ti portano in campagna a raccogliere i mandarini, poi li porti alla fabbrica, loro li buttano in una macchina, la parte buona va da una parte, la parte brutta dall’altra. Quelli della fabbrica erano davvero incazzati. Ci trattavano male. Non solo me, ma anche i miei amici. Ti portavano al campo per lavorare, ogni cassetta che facevi ti pagavano un euro. A volte abbiamo raccolto duecento cassette di mandarini. Se il padrone ha la macchina che funziona [la macchina per selezionare la frutta], lui frega noi lavoratori. Dice: “Avete fatto duecento cassette ma solo cento sono buone, io vi pago solo cento cassette”. Io ho cercato di lavorare per lui un mese, due mesi, ma non ha mai pagato.
«Dopo la rivolta di Rosarno, dopo avermi portato nel centro accoglienza di Bari, mi hanno liberato e sono andato a Foggia. I miei amici che sono arrivati prima di me mi dicevano: “Scappa e vai a Foggia”. Sono arrivato a Foggia il giorno in cui è cominciata la Coppa d’Africa in Angola, il 10 gennaio 2010. Ho lasciato il campo di Bari, ho preso il mio zaino e sono andato a vivere lì con i miei amici. Si chiama Gran Ghetto. Ogni tre mesi dovevo andare a Crotone per rinnovare il permesso di soggiorno. A Foggia lavoravo in campagna e dormivo nel Gran Ghetto, nelle baracche. Piantavo pomodori, toglievo l’erba. In quel momento ho solo piantato, non si raccoglie in quel momento, si raccoglie dopo, a luglio. Al Gran Ghetto stiamo tra di noi, non c’è il problema che c’è a Rosarno, c’è solo il problema di dormire, non c’è la luce. C’è la libertà nel Gran Ghetto, tu vai a lavorare, poi vai a dormire nella tua tenda, non c’è problema. Non c’è casino. Fai la chabola, la baracca, costruisci una casa e ci metti la plastica sopra, solo quello. Come ho fatto dopo nel campo di Saluzzo che noi braccianti abbiamo chiamato Guantanamò. Un giorno ho sentito un mio amico che viveva a Saluzzo che mi ha detto: “Vieni qui a Saluzzo per cercare lavoro in campagna”. Io sono partito e grazie ai miei amici ho trovato un posto e ho dormito per qualche mese a Lingotto, all’Ex-Moi di Torino. Poi sono andato in campagna a Saluzzo per lavorare.
IN PIEMONTE
«Quando sono arrivato a Torino sono andato a dormire all’Ex-Moi [le palazzine occupate nel 2013]. Nel 2013 faceva molto freddo e l’Italia aveva chiuso tutti i centri di accoglienza aperti dopo i bombardamenti in Libia del 2011, dopo “l’emergenza Nord Africa”. A Torino faceva freddo e hanno mandato la gente fuori dai centri, si vedevano tantissime persone che dormivano in strada. Ad alcuni avevano dato dei soldi, molti non hanno avuto nulla. In quel momento un gruppo di persone ha occupato le palazzine dell’Ex-Moi, quelli senza casa sono entrati lì. Hanno spaccato e sono entrati! Io andavo all’Ex-Moi per dormire e da lì poi sono andato a Saluzzo per cercare lavoro e raccogliere la frutta. Ho visto che anche a Saluzzo le cose non andavano bene perché non c’è un posto per dormire e devi andare a cercare il lavoro nel pomeriggio. La gente lì è così: alcuni ti mandano via, alcuni neanche ti rispondono, oppure ti dicono: “No, non ho bisogno di nessuna persona”.
«In quel momento al Foro Boario di Saluzzo, il campo di Guantanamò, non c’era l’acqua. C’era un’associazione che ha portato qualche tubo, così noi potevamo prendere l’acqua lì senza andare fino alle fontanelle. Quando il comune di Saluzzo ha visto che qualcuno ci aveva aiutato e aveva sistemato un tubo per farci prendere l’acqua, lo ha tolto subito. C’è stato un po’ di casino, alla fine abbiamo litigato con il comune, siamo andati dai sindacati. Abbiamo fatto una grande manifestazione e abbiamo bloccato il traffico in città. L’associazione che ha messo il tubo al Foro Boario ha detto al comune che doveva lasciarlo lì. Alcuni nostri amici, per esempio, andavano a lavorare alle cinque del mattino, tornavano alle sei di sera, altri anche più tardi, alle venti, dipende da dove trovi lavoro. Quando tornavano al campo, se volevano prendere l’acqua, dovevano andare fino alle fontanelle nel centro di Saluzzo: è lontano. Invece per chi arrivava alla sera, anche se era stanco, grazie al tubo poteva trovare l’acqua, fare le sue cose, lavarsi. Ma il sindaco ha ordinato di togliere l’acqua, ha tolto proprio tutto, diceva che non doveva esserci quel tubo al Foro Boario. È stato difficile quel momento lì. Nessuno ci affittava la casa, né il comune né niente di niente, ci siamo sistemati con i cartoni per terra, ognuno sistemava il cartone e dormiva, poi ti svegliavi al mattino e andavi a raccogliere la frutta. Nessuno ci dava da dormire, nessuno! Quando i padroni hanno visto che i braccianti avevano fatto casino contro il comune di Saluzzo è iniziato un periodo difficile per tanti amici. Alcuni padroni, dopo aver visto la manifestazione, hanno licenziato tanta gente.
«Quando dovevo fare dei documenti o per qualsiasi cosa venivo a Torino e dormivo all’Ex-Moi a Lingotto, dai miei amici. Un giorno è arrivato il progetto della Compagnia San Paolo, il progetto di sgombero, e hanno iniziato a separare le persone nei palazzi. Procedevano per gruppi di persone, prendevano i nomi delle persone e li mettevano nel progetto di sgombero. Alcuni sono stati mandati ad Asti, anche se avevano dei lavori qui a Torino o facevano il servizio civile. Dovevano andare ad Asti e basta, e alcuni hanno perso il lavoro. Conosco tante persone che prima dormivano a Lingotto: loro non hanno i documenti, sono senza permesso, ora è pieno di gente che dorme in giro. Era importante per loro dormire all’Ex-Moi perché avevano un posto dove stare anche se erano senza documenti; potevano dormire lì e andare a cercare con la bici delle cose che poi andavano a vendere al Balon. Loro andavano al Balon per vendere e per guadagnare un po’ di soldi per mangiare. Quando c’è stato lo sgombero all’Ex-Moi dove sono finiti? Non hanno più un posto per dormire. Anche se vanno a cercare la roba, dove possono conservarla? Non hanno più un posto dove mettere le cose, tutti hanno avuto tante difficoltà con lo sgombero.
«C’è tanta gente che dorme al parco del Valentino, vicino al fiume, c’è tanta gente che dorme lì. Uh! Ancora adesso in tanti dormono lì. E poi anche a Borgo Dora dormivano, anche al Balon, tanti dormono in quel punto lì, dove c’era il pallone grande nel cielo. In quel giardinetto [il giardino Pellegrino]. Anche in via Cigna, anche vicino alla stazione Rebaudengo. Anche dove c’è un giardino in largo Bottesini e in largo Ghedini, lì c’è anche un dormitorio ma le persone dormono fuori, capito? Quando dicono che hanno sgomberato l’Ex-Moi al Lingotto e hanno dato un lavoro a chi viveva lì è una bugia, non è vero. Prima, quando dormivamo a Lingotto, le persone magari avevano un lavoro, non guadagnavano tanto, ma mentre stai dormendo all’Ex-Moi puoi fare un po’ di economia, riesci ad aiutare la famiglia, ma se loro tolgono quel posto come si fa a pagare cinquecento euro al mese per una casa? Come fai a fare economia? È difficile. È impossibile. Quella è la difficoltà.
«A Lingotto arrivavano persone che non avevano niente, non avevano il permesso di soggiorno, non avevano vestiti, niente. Ci sono delle associazioni. Ogni settimana portavano delle cose da dare a chi ha bisogno e poi ti insegnavano come muoverti nella città, dove c’è un posto per cercare lavoro, o fare il corso della patente, tutti quanti ci aiutavano. Ma quando ci hanno sgomberato hanno chiuso tutto e ci siamo trovati in difficoltà. Sia chi ha il lavoro, sia chi non ha il lavoro, siamo sulla stessa barca. Quelli che gestivano il progetto di sgombero non hanno aiutato a trovare una casa, noi abbiamo provato a cercare ma è difficile e anche loro del progetto hanno detto che trovare una casa è difficile. Molte volte ospitiamo le persone che dormono fuori, che sono state sgomberate, a volte arriviamo a essere sette persone in casa, alcuni ci chiedono di dormire per due o tre giorni ma poi si fermano di più, ma è troppo piccola la casa, non si può vivere bene. Puoi ospitare qualche notte, ma non per tante notti. Poi è difficile dire alle persone che devono andare via, si arrabbiano con noi, a volte dormono lì fino a dieci persone, non va bene! Qualcuno dorme anche per terra in cucina, non va bene. È tutta colpa di San Paolo! [la Compagnia di San Paolo, che insieme alla Città di Torino ha coordinato il progetto di sgombero terminato nel 2019]. Colpa di San Paolo, ti dico».


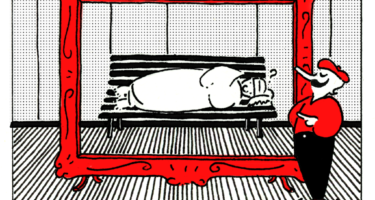


Leave a Reply