
Sarà proiettato questa sera, lunedì 21 gennaio (ore 22,30), al cinema Modernissimo (via Cisterna dell’olio, 49), Napolizm, vol. 2. ‘O film, prodotto e diretto da Alberto Polo Cretara.
Pubblichiamo a seguire il testo “Nel solco del ritmo” (di cyop&kaf), introduzione al volume Vai Mo. Storie di rap a Napoli e dintorni, scritto da Antonio Bove e pubblicato dalle edizioni Monitor nel settembre 2016.
* * *
Per fare rap, almeno quello spontaneo, il freestyle, non servono disponibilità economiche: ci si raduna, in cerchio – attorno a un fuoco che è sì immaginario, ma non per questo meno caloroso – scandendo, con le mani a mo’ di cassa armonica, un boom e un cha che hanno il loro epicentro nel pieno dei polmoni, o giù di lì, in quel diaframma che ci consente di decidere da quanta luce vogliamo essere illuminati. È su questa batteria umana che si improvvisano rime, lasciandosi parlare, permettendo ai suoni di disporsi come meglio credono, oppure, col tempo e gli allenamenti, iniziando a governarli, a governarsi. È così che il balbettìo si fa parola, e la parola discorso: le liriche all’inizio caotiche vanno componendo un mosaico via via più chiaro, l’orale cede il posto allo scritto – giusto il tempo di una levigatura – per poi ritornare, battito sul battito, a farsi soffio, vitale e narrativo. Da questo tipo di improvvisazioni sono nate migliaia di strofe, poi brani, album. Ma da dove nasce questa pratica? Da che ambito proviene il rap? E ancora, come è arrivato a Napoli?
In Elogio delle vagabonde un piccolo libro a suo modo esemplare, Gilles Clément, ci narra la storia di tutte quelle piante fiori semi, che, trasportati dal vento, dagli animali, dalle suole delle scarpe, viaggiano e sedimentano di luogo in luogo, fregandosene di muri, filo spinato, confini. Ora, se proviamo a immaginare le rotte che ha percorso il seme dell’Hip hop (cultura di cui il rap è una tra le discipline) prima di giungere a Napoli, è bene non trascurare almeno due o tre possibilità, tutte a loro modo necessarie (e interconnesse) a far sì che questa cultura attecchisse pienamente nell’humus partenopeo, già di per sé fertile e stratificato da secoli di cunti, fronne, ritmo e parole.
Molte delle interviste che leggerete in questo volume ci dicono che fu la televisione a consentire lo sbarco in Italia di una cultura che a New York si era già strutturata da almeno una dozzina d’anni. Certo, fa tristezza pensare che un movimento intero sia giunto a noi nell’esatto momento in cui l’industria dello spettacolo lo stava – come si dice – recuperando, e viene da chiedersi se siamo o no di fronte al solito colonialismo culturale che lentamente, e a fatica, raggiunge la periferia dell’impero. A guardare la bassa qualità di alcuni tra questi filmetti (beat street, flashdance) si direbbe di sì. Eppure queste pellicole (nate già per la tv) aprivano uno squarcio. È vero, provavano a edulcorare un movimento nato in seno all’America degli oppressi, e proprio per permettere agli afroamericani, ma anche ai caraibici in fuga dalla povertà, di prendere un microfono e far sentire la propria voce. Ma nonostante questo tentativo, coloro che da quelle immagini furono colpiti non si arrestarono a quel facile racconto. Spinti dalla curiosità hanno iniziato a indagare, i più fortunati a viaggiare, anche solo verso Parigi dove l’hip hop già da qualche hanno aveva messo radici; e pian piano, a ritroso, sono risaliti alle motivazioni, ai conflitti che quel movimento avevano generato. Cercando poi di reinventarlo, facendo propria la lezione di questi ragazzi che in un Bronx devastato – anni luce distante dalle future speculazioni immobiliari – dimostravano al mondo intero che con rabbia e determinazione potevano scrollarsi di dosso etichette preconfezionate e, in una sfida continua, migliorarsi secondo parametri, stavolta, non imposti da nessuna autorità. A colpi di danza, graffiti, rime, musica.
Oggi sembra farsi strada una nuova consapevolezza però: non ci fu solo la tv. Le cose, senza sapere che strada avrebbero preso, si muovevano caoticamente e senza sosta. Con un facile senno di poi sembrerebbe che qualcuno stesse, magari involontariamente, preparando il terreno alla futura scena rap campana.
Proviamo dunque, con un po’ di spregiudicatezza, a ripercorrere la traiettoria del rap contromano e risalire fino a quando agli inizi del Novecento, orde di meridionali emigrati negli Stati Uniti – anche in quella New Orleans che diede luce al jazz – apportarono un prezioso contributo all’evoluzione di quel neonato genere: se i neri misero il folk e il ritmo, gli italiani, forti di una tradizione bandistica terrona e paesana, portarono nel jazz i loro strumenti a fiato, tanto che il primo disco inciso della storia del genere (1917) è di Nick La Rocca, figlio di un ciabattino siciliano. Dal jazz al funk il passo è breve, e, senza correre troppo, proviamo solo a immaginare come possano viaggiare caoticamente i semi. È l’inizio del secolo, Libero Bovio, Ernesto Murolo, E.A. Mario, Ferdinando Russo, Salvatore di Giacomo con i loro testi danno vita alla stagione d’oro della musica napoletana. Le liriche di quegli anni molto spesso narrano di amore e paradisi perduti (l’unificazione è ancora fresca), ma anche di emigrazione (lacrime napulitane), vita di strada (guapparia, carcere), tutti temi che in questo libro, vedrete, ritorneranno spesso.
Siamo nel bel mezzo del terreno fertile sul quale si poseranno i già citati semi del rap, sicuramente per quanto riguarda la parte delle liriche che, dall’inglese degli albori (il colonialismo residuale) slitterà, quanto più la presa di coscienza sarà marcata, verso un napoletano crudo, talvolta violento, necessario.
E la musica? Carosone, durante l’arco di cinque anni, dal ’39 al ’46, suona per lunghi periodi nelle colonie italiane in Africa orientale. Quando Addis Abeba viene occupata dalle truppe britanniche sostituisce il suo repertorio con la musica da ballo statunitense, quella delle orchestre, certo, ma probabilmente anche con il jazz (che qui ritorna ancora una volta), e senza contare che qualcosa di etiope magari gli è pure capitata di ascoltarla. A lui, quando poi rientrerà in Italia, si affiancherà il batterista eccentrico Gegè Di Giacomo, nipote del già citato Salvatore: la melodia continua a intersecarsi col ritmo. Gli alleati sono già sbarcati e resteranno per un pezzo a Napoli, tanto che dopo qualche tammuriata nera, ci ritroveremo James Senese, il nero a metà. Dunque i Napoli Centrale (dal jazz eccoci al funk), Pino Daniele (il blues e tutto il Neapolitan Power), fino ad arrivare a Enzo Avitabile, che nel 1988, mentre la scena hip hop era appena al suo stato embrionale, pubblica un singolo e un video (girato tra Napoli e New York), Street happiness, duettando con il padre del movimento americano, Afrika Bambaataa. È proprio Avitabile a ricordarci in questo volume, oltre al suo folgorante incontro con James Brown (da quando la musica si “campiona” è stato lui il più saccheggiato) la stretta relazione tra il freestyle del rap e l’improvvisazione sulla tammurriata, forse la medesima affiliazione che intercorre tra i griot africani e il rap statunitense. La voce che si fa ritmo, più battente dello stesso tamburo. Nella cultura contadina campana è un rito ancestrale e – forse qui siamo al nocciolo – ha funzionato da protettrice della specie, come ogni poesia che si rispetti. È per questo che lo stile, ogni volta rinnovato a seconda delle nuove necessità, in ogni ambito culturale, s’è posto sempre al servizio della mnemotecnica. Se la metrica, dalla notte dei tempi, non si fosse fatta memoria, forse oggi, tutti noi, non saremmo qui.
Resta da ricordare ancora un altro fondamentale filone, strettamente legato alla cultura contadina di cui si diceva, ma nel preciso momento in cui si accinge a scontrarsi con quella urbana; pensiamo solamente allo scontro di valori di un brano come ‘O Zappatore, che cristallizza in un’amara fotografia l’allora ancor attualissimo conflitto campagna-città.
Per chiarirci tocca fare un passo indietro a quando, Tony Iglio, musicista dalla formazione jazzistica, si presta a quella che viene comunemente definita “canzone di giacca” o spregiativamente “canzone di malavita”. Sono gli anni Settanta e la sceneggiata resisterà ancora (per poco), nonostante la modernizzazione avanzi impietosa e la musica colta e antagonista abbia preso il sopravvento, ma soprattutto perché molte delle questioni che le appartenevano (pensate anche alle coltellate per tradimento, il delitto d’onore ecc.) erano oramai sorpassate da una società in iperaccelerazione sulla via dell’omologazione totale.
Ebbene, gran parte dei dischi di Mario Merola, Pino Mauro, Mario Abbate e tanti altri, sono suonati da orchestre dirette da questo sassofonista. Non sarà l’unico, certo, ma il suo è un suono riconoscibile, che rimanda a tanto cinema dell’epoca, tra western e blaxpoitation, fusi alla musica tradizionale napoletana. Da questi vinili, reperibili su tante bancarelle cittadine – sicuramente più di quelli funk dai quali attingono i produttori di beat americani –, verranno fuori gran parte dei fiati, giri di basso, casse e rullanti di molti producer partenopei.
Questo pescare sia dalla musica alta che da quella bassa, sembra essere, magari senza volerlo, un punto di cucitura tra le due città e, non è un caso che il rap degli esordi è fatto dai figli di quanti – finalmente – godevano di un benessere quantomeno materiale, grazie a un sistema di garanzie conquistato con le lotte di più di mezzo secolo. Un giovane “proletariato medio” (non ricchi, non poveri insomma, nella città dove nobiltà e miseria spesso coincidono) nutrito con i palinsesti televisivi più che con la politica culturale, certo, ma che in qualche modo si era vista garantita un’istruzione più elevata della generazione precedente e che, di fatto, gli aveva spianato un orizzonte fino ad allora ristretto al buio, non solo metaforico, del proprio vicolo. Questa nuova generazione, grazie a una lingua tutta plasmata a partire dalle sue specifiche esigenze, riusciva a parlare contemporaneamente sia alla (piccola) borghesia che al sottoproletariato metropolitano. Alla prima per il fascino (spesso banalmente esterofilo) che questa subisce dalla novità-rap (con il carico estetico che si porta dietro dagli States), ai secondi per i contenuti che andavano narrando di esperienze comuni: luoghi, fatti e personaggi nei quali identificarsi.
Quest’amalgama, senza farsi ancora livellamento, ha fatto sì che una piccola comunità iniziasse innanzitutto a vivere, insieme, e prima di ogni proclama burocratico, la “città metropolitana”. Le jam, feste multidisciplinari dove si andava a ballare, rappare, dipingere, suonare, si tenevano nei più disparati angoli della metropoli. Non tanto nei locali, ma proprio vicino a muri dove dipingere, sui lungolinea, molto spesso posti occupati, oppure piazze dove si radunavano gli skaters. Erano piccoli appuntamenti per piccoli pubblici, ma era importante esserci. Quello che più contava non era tanto esibirsi, quanto sentirsi parte di una comunità, diffonderne il verbo, ampliarla. Le acrobazie verbali degli Mc’s e quelle fisiche dei breakers tenevano assieme persone di ogni classe sociale, lo abbiamo già detto, ma anche di differenti nazionalità: capoverdiani, domenicani, filippini (da non molto arrivati in città), senza timori né pregiudizi, il tutto mentre il paese era governato dalla peggiore destra catodica, xenofoba, razzista.
È in questo modo che centinaia di ragazzi cominciano in qualche modo a ragionare sulle parole, sul loro suono, sul ritmo, avvicinando – è pur sempre un gioco – anche quelli che magari a scuola risultano essere i più svogliati e conflittuali. Sembra di essere di fronte a una specie di miracolo. Lo scambio è fertile, si impara da quelli che hanno esperienza (che spesso hanno solo pochi anni in più) ma senza il peso dell’obbligo e dell’autorità. Ci si muove, da soli ma più spesso in piccoli gruppi, le crew, e ogni occasione è buona per continuare la sfida, passare al livello successivo, migliorarsi come singoli e come comunità. È l’eco lunga della Zulu Nation fondata da Afrika Bambaataa nella New York dei primi anni Settanta per placare gli scontri tra gang, al grido di “Peace, unity, love and havin’ fun!”.
Da questo lungo periodo di gestazione sono venuti fuori (non molti) dischi importanti, che hanno raccontato la città e i suoi abitanti con una lingua e delle sfumature (anche musicali) fino ad allora inedite. La linea evolutiva del primo quarto di secolo di album sembra delinearsi molto chiaramente: si è partiti dalle Posse, il rap legato alle ondate di occupazione a cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, caratterizzato da una lingua ancora vincolata, per ideologia e contenuti ai movimenti di contestazione degli anni Sessanta e Settanta. Scintilla necessaria ma conflittualità risolta per slogan, rappresentata.
Negli anni Novanta abbiamo avuto i primi veri dischi rap, alcuni interamente in lingua napoletana, veri capisaldi di un genere sia per ambientazioni sonore che dal punto di vista delle liriche, molto vicine ai wild style dei writers, intrecciate al punto da far girare la testa. Nei Duemila hanno visto la luce album che trovavano una sintesi importante tra forma e contenuto, stile al servizio della narrazione in presa diretta di quanto la città sta vivendo in quegli anni. I primi veri dischi politici, conflitti vissuti.
E poi gli ultimi anni, in cui il fenomeno esplode, si perde il conto degli album, non solo grazie alle puntate a San Remo. Esperimenti (talvolta riusciti, talvolta no) di fusione con la musica melodica, italiana e napoletana. Più video che canzoni: il rap finalmente si ve(n)de. Ma non si è venduto, è che dopo venti anni di vita sotterranea e un lento propagarsi col passaparola (termine quanto mai appropriato), è il pubblico a essere pronto a ricevere quanto prima andava denigrando con un superficiale tu vuo’ fa l’americano!.
Si sarebbe potuto ottenere di più? Chi lo sa. È inutile però prendersela con l’industria discografica (di fatto inesistente a Mezzogiorno), che non può e non deve farsi carico delle sorti di un intero movimento, ma occuparsi delle sue migliori individualità. Ora, con quali criteri queste individualità vengono selezionate? A quale intervento automutilante si sottopongono i rapper per attirarsi i fari della ribalta? Non saranno queste luci ad accecarli definitivamente?
Il potere – di questo si tratta – utilizza i linguaggi che in qualche modo gli si oppongono non tanto per tener a bada fantomatiche sovversioni, e neppure per stemperare la voglia di comunità che, sempre, la sperimentazione di nuove sintassi, grammatiche, punteggiature può generare. No, niente di tutto questo. Fuor di complotto, l’industria prende il prendibile, e, per sua natura, cerca di far in modo che un prodotto frutti più denaro possibile.
È lo stesso atteggiamento che il mercato ha con il resto del pianeta: quando l’accaparramento di risorse è un genocidio di indigeni si procede comunque, ecco tutto. Ce lo ricorda Bateson nel suo Mente e natura che ogni sostanza, denaro incluso, oltre una certa soglia inquina. Quindi se l’industria discografica, per vendere, deve tramutare una comunità in massa, la polifonia in cantilena, la complessità in spot pubblicitario, ebbene, lo fa, punto e basta. Quando il movimento hip hop muoveva i suoi primi passi era come una ramificazione di piccole arterie vitali che penetravano di luogo in luogo, muovendosi caoticamente. Oggi per far sì che i più noti si esibiscano servono palazzetti, luoghi controllati, transenne, buttafuori, e tutto ciò anche se i rapper in questione hanno indubbie qualità. Si tratta di effetti collaterali. Se una voce ci sta dicendo qualcosa di importante, che dovremmo veramente sapere, come immaginate che si comporti il potere? Mica la zittisce censurando, figuriamoci, evoluti sono, democratici; ed ecco che gli fa il coro attorno, ricacciandola in un rumore di fondo che rende indistinguibile ogni prezioso significato.
Ma come sottrarsi a tutto questo? Restando piccoli forse? Non è neanche detto, visto che talvolta, sovrastati da una macchina mediatica pervasiva e ipertrofica, si diventa celebrità anche controvoglia. E allora? Non resta che il silenzio? Sia chiaro, qui non si chiede al rap nostrano di restare in ambito regionalista (la vecchia diatriba tra rap in napoletano e rap in italiano lascia il tempo che trova), anzi, il movimento fa bene ad esigere palcoscenici nazionali, ché farsi richiudere su sé stessi (come a lungo ha fatto da solo) sarebbe già un principio di normalizzazione, una dichiarazione di subordinazione a una maggioranza che fissa le regole del gioco. No, quello che qui si prova a dire è che bisogna, seppur trainati da un linguaggio universale, farsi di volta in volta minoritari in potenza. Ossia essere capaci di divenire, trasformarsi, sfuggire, proprio come quelle piccole comunità che devono la loro futura sopravvivenza alla capacità che hanno di farsi strada (sui sentieri del ritmo) ponendosi le solite poche e irrisolte domande: perché e per chi fare cosa.
L’ultima ondata di rap, sembra purtroppo impantanata nell’onda lunga di Gomorra (nella sua serialità), e ci sembra un vero peccato se quel sottoproletariato metropolitano finalmente conquistato al genere, sprecasse questo grande strumento autocompiacendosi, svilendo quella vocazione emancipatrice che la cultura hip hop ha dalle sue origini. Perché, è vero, It’s like a jungle sometimes, ma è anche vero che sta a noi individuare le vie d’uscita. Con un passo ulteriore, che sappiamo essere un abisso, questi ragazzi potrebbero iniziare a raccontarsi fuori da quegli stereotipi che si ritrovano tatuati addosso e darci nuovi dischi, tanto più memorabili quanto necessari.
Ma forse non è tanto quello che il rap ci ha lasciati e ancora ci darà in termini di discografia a contare. Il bagaglio più prezioso è sicuramente quello che ha fatto sì che più di una generazione iniziasse ad avere fiducia in sé stessa, fosse consapevole dei propri mezzi e, soprattutto, iniziasse a parlare con la propria voce (al di là delle ambizioni di successo che – come ci hanno insegnato – altro non è che il participio passato del verbo succedere). Proprio come quei ragazzini che di tanto in tanto, nei pressi di un cavalcavia trafficato – o fuori a un bar di periferia – continuiamo a vedere stringersi in cerchio, riaccendendo il fuoco di chi, stando col corpo nelle cose, sputa rime e ritmi a raffica, dandosi addosso a bout de souffle, come leali nemici, già pronti ad abbracciarsi, cresciuti, in una sfida che non ha perdenti di sorta.


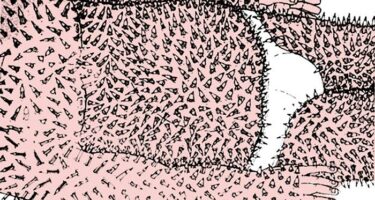


Leave a Reply