
La strada per arrivare all’Ex-Moi all’alba è brevissima, Torino da nord a sud in una decina di minuti scarsi. La bellezza del crepuscolo sul fiume, con l’ombra di Superga e delle colline sullo sfondo, mi sembra contraddittoria per la giornata che dobbiamo affrontare. Come annunciato ossessivamente nelle scorse settimane è iniziato lo “sgombero soft” dell’Ex-Moi. Un ossimoro solo a pronunciarlo, un’operazione accelerata nell’estate grazie ai finanziamenti di regione e ministero degli Interni, sia per le operazioni di sgombero che per gli incentivi di microcredito finalizzati ai rimpatri.
Via Giordano Bruno è deserta, calma, le camionette non si intravedono all’orizzonte. Fuori dalle palazzine decine di abitanti sembrano sereni, intenti nel trasloco iniziato il giorno prima, stoccando e ordinando le proprie cose, per portarsele via ovunque andranno. L’opera persuasiva di Compagnia di San Paolo, che da anni vende truffe d’inclusione e accompagnamento agli abitanti del Moi, sembra alla fine aver funzionato, in un déjà-vu dello sgombero della palazzina blu l’estate scorsa. Un inganno a cui hanno dato il loro contributo il decreto bis e le repressioni subite – circa un anno di carcere preventivo – da chi ha provato a contestare il progetto “MOI, migranti un’opportunità d’inclusione”.
Dall’altro lato della strada, dietro il nastro biancorosso, ci sono i giornalisti pronti a documentare la giornata. Una di loro riesce ad arrivare nella piazzetta che affaccia sulle palazzine. È vestita casual, dice di essere «alle prime armi». Il suo atteggiamento fintamente ingenuo e le domande fatte con troppa insistenza creano nervosismo: «Ditemi qualcosa, faccio solo il mio lavoro…». «Non abbiamo niente da raccontare», la zittisce un ragazzo finché lei sbuffando, col taccuino assetato in mano, se ne va a mani vuote.
Agenti di polizia, esponenti dei partiti politici e giornalisti ci guardano compiaciuti dalle strisce biancorosse. La loro smorfia ha sfumature differenti: piena di malizia per noi solidali, compassionevole e offensiva per gli abitanti, una compassione che sfocerà in sorrisi plastici e cortesie formali durante lo sgombero.
Alle 6.30, con l’arrivo dei blindati della celere, iniziano le operazioni. I poliziotti sono armati di piantine degli stabili e radio portatili, dietro di loro già si preparano gli operai per murature e transennamenti. Anche la Digos si muove compatta tra le palazzine. Come uno sciame d’insetti fittissimo i poliziotti avanzano a spalle larghe e passo virile, accompagnati da funzionari del comune spaesati e con dei numerini da banco degli affettati in mano. Ai lati, con discrezione, a osservare il procedere della parata, i dirigenti di San Paolo, che in giacca e mocassino indicano come dei capo cantieri le differenti aree degli stabili, raccontandosi a vicenda la loro impresa e il loro sogno innovativo. Fuori, al di là della strada e dei nastri, la neo vice sindaca è accompagnata dai rappresentanti dell’opposizione, Lega e Partito Democratico, a suggellare una vittoria tripartisan.
Intanto, nel piazzale sulla destra guardando la stazione, gli abitanti iniziano a raggrupparsi con le proprie valigie attorno a una ventina di pullman. Un muro abbastanza alto da regalare discrezione alla violenza dell’immagine, divide lo spiazzo dai bus.
La palazzina grigia è la prima a essere svuotata, l’arancione sarà l’ultima perché si prevedono possibili tensioni. In tanti non aspettano il sollecito per uscire dalle proprie case, anzi si affrettano per avere sotto controllo il trasporto delle proprie cose. I funzionari del comune rassicurano che tutto sarà portato nelle strutture in cui risiederanno gli sgomberati, assegnando come garanzia – esclusivamente a chi lo chiede con insistenza – un foglietto scritto a mano dove vengono segnati i bagagli. Si tratta di una promessa rivelatasi vana durante gli altri sgomberi, quando gli averi degli abitanti sono stati nella migliore delle ipotesi lasciati nel giardino, nella peggiore murati dentro le palazzine sgomberate, dal momento che spazio sufficiente, nelle strutture in cui verranno portate le persone, non ce n’è.
Mi aggiro per il Moi con gli altri solidali, cercando di controllare la rabbia e la frustrazione. Proviamo a testimoniare con foto e video la violenza latente di tutto l’intervento, venendo fermati, di tanto in tanto, dagli abitanti.
Intanto la fila aumenta e le persone vengono caricate sui bus. Gli sguardi sono stanchi e spaesati ma tranquilli. I poliziotti controllano il flusso e indicano verso quale pullman bisogna indirizzarsi. Nessuno dice agli abitanti dove andranno, a nessuno interessa il loro nome, le loro esigenze, la loro storia. A ognuno viene assegnato un numero identificativo scritto su un biglietto di carta, in una deportazione “soft” verso l’ignoto, tra Torino, la provincia, Asti e Cuneo.
Alcuni abitanti si rifiutano di lasciare le proprie case. Sono quelli che vengono definiti “i vulnerabili”, perché eccentrici o sofferenti di disagio psichico, secondo il gergo medico. Un ragazzo si aggira per le palazzine con sorriso beffardo, senza valigie, rivolgendosi a noi e alla polizia con ironia. Un altro si rifiuta di uscire dalla propria abitazione, bilocale pieno di piante e libri, perché preferisce «morire al Moi» che farsi deportare in posti che non ha scelto.
L’attenzione clinica riservata alla “resistenza” crea agitazione, sembra che qualcuno intenda procedere con un Tso. Chi non vuole andar via deve essere pazzo, non sono plausibili altre spiegazioni. Le trattative durano ore, alcuni agenti della Digos raccontano aneddoti familiari dal sapore multietnico, sfoderando un umorismo dolce che alla fine convince il ragazzo a salire da solo su un furgoncino del comune, con il suo gatto. Entrambi scortati, per precauzione, da quattro volanti della polizia.
Lo sgombero di circa seicento persone dalla propria abitazione, nonostante i numeri ufficiali ne dichiarino duecento in meno, dura in tutto cinque ore. A partire dall’ora di pranzo i centri di smistamento della protezione civile a Mirafiori e Vallette sono inondati. A tante persone viene dato senza troppi convenevoli un foglio di via e sette giorni per lasciare il paese. Qualcuno viene convocato in questura e (pochi) altri ancora “messi in attesa per una soluzione abitativa”. Dovranno ripresentarsi fra tre mesi.
Intanto la sindaca, assieme ai rappresentanti di tutti i partner dell’operazione (regione, San Paolo e diocesi) parla fiera in conferenza stampa. Il primo ringraziamento è per l’ormai famosa “rete”, che comprende o ha compreso i ministri Minniti e Salvini, la regione, le forze dell’ordine, la diocesi e la Compagnia di San Paolo. Il discorso è un calderone confuso di strategie di comunicazione politica: quello che diciamo lo facciamo, in rete, perché le situazioni complesse si risolvono insieme. Viene spiegato che tuttavia la priorità restano le persone, e l’obiettivo “di farle uscire da situazioni di fragilità, dando loro autonomia”. Infine, riqualificare il quartiere, perché sicurezza e inclusione possono lavorare insieme.
Ripenso alla foto dei politici sornioni davanti ai murales del Moi, che per noi significano tanto; ai giornalisti che per primi hanno fatto il tour delle palazzine svuotate, agli sguardi distrutti e sconfitti delle persone del Comitato, a chi cercava di caricare sui carretti le dispense dei propri negozi, alla resistenza dei “folli” e a chi è finito in qualche posto imprecisato della regione, in mezzo al nulla, obbligato al coprifuoco e al corso di formazione per fare origami. Spero che qualcuno nella notte sia scappato e che questa non sarà la loro soluzione finale. Mi viene in mente uno striscione appeso al Moi qualche tempo fa: “We’re not going anywhere“, fatevene una ragione. (ilaria magariello)


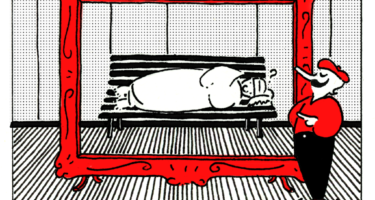


1 Comment