
In piazza d’Armi vedo operai in tute fluorescenti tagliare l’erba, isolato si muove un trattore che traina una barra falciante. Sono in un vasto piazzale d’erba, ghiaia e cemento, qui han vissuto per anni uomini e donne senza casa e sono stati sgomberati prima che il festival di Eurovision avesse inizio. Vicino sorge l’impianto che a maggio ha ospitato lo spettacolo internazionale. È una tarda primavera e osservo il vuoto seduto su un jersey in cemento e pietrisco. È ruvido, screziato di bianco e la sua forma mi suggerisce la storia recente di Torino, rimossa. Al confine settentrionale della città una lunga linea di jersey circonda l’area di Lungo Stura Lazio: dopo la distruzione del campo di baraccati le istituzioni hanno abbandonato le macerie accumulate dalle ruspe e hanno chiuso la zona per impedire il ritorno dei reietti. A San Pietro in Vincoli, lungo la Dora, gli straccivendoli sono stati allontanati con i manganelli e le multe, in seguito il piazzale è stato abbracciato dai blocchi di cemento. I jersey in piazza d’Armi, invece, chiudono l’accesso al parcheggio dopo l’esodo di roulotte, camper e la rimozione delle tende.
La barriera di cemento è una traccia lasciata da governi diversi. I baraccati accanto alla Stura sono stati sgomberati dalla giunta di Fassino, Appendino è invece responsabile dell’esilio degli straccivendoli e l’attuale amministrazione guidata da Lo Russo ha allontanato gli abitanti di piazza d’Armi. Un jersey è un oggetto inventato per la sicurezza stradale, andrebbe posto fra due corsie e ha il piede a base inclinata per deviare la rotta d’un veicolo in caso di contatto. Qui la barriera assolve una diversa funzione: ostruisce un accesso, emargina, evita il ritorno dei dannati. Questo blocco grigio, oggetto urbano concreto, m’appare come allegoria della sorellanza fra sicurezza ed esclusione.
Vivevano in questo piazzale accanto al parco cittadini romeni, rifugiati dalla Bosnia, italiani. Alcuni erano rom, altri no; la polizia e i funzionari comunali hanno ordinato di andar via, dove non importa. Si sono dispersi in città alla ricerca di angoli appartati. Alcuni camper possono apparire in un parcheggio alberato in un quartiere meridionale, altri mezzi sostano in vie isolate al confine fra i condomìni e la campagna, oppure trovano rifugio a nord in porzioni di città nascoste alla vista. Ci sono famiglie che si spostano tutto il giorno, forse per essere inafferrabili o invisibili: al pomeriggio s’accampano accanto a un parco di periferia, poi la sera migrano in strade dove atti di violenza contro di loro sono meno probabili. L’esclusione, le angherie della polizia, l’assenza di politiche sociali, le minacce dei razzisti e gli sgomberi dei campi impongono ai reietti una vita instabile, sono frammenti in spostamento forzato. Qui il nomadismo non ha nulla di romantico, né di atavico: è l’esito del governo urbano.
Quando pronuncio o scrivo le parole “rom”, “campo” o “nomade” ho il timore che esse abbiano un mero valore referenziale, ovvero servano a indicare una presunta realtà esterna. Non è così e l’ho capito grazie a un libro di Sergio Bontempelli: I rom. Una storia (Carocci, 2022). Bontempelli non scrive una storia dei rom, ma una storia del punto di vista bianco, dominante, su popolazioni emarginate. L’autore, ad esempio, mostra come la concezione dei rom proposta dalle istituzioni filantropiche deriva da una tradizione scientifica compromessa con il nazifascismo. Così si diffondono “l’idea della ‘primitività degli zingari’ e la tesi della ‘degenerazione’, secondo cui i rom erano come bambini privi di una propria cultura”. “Tra i vecchi nazisti che avevano in vario modo collaborato allo sterminio dei rom – continua Bontempelli – nessuno fu mai condannato. E i membri dell’Unità di igiene razziale [ente nazista] continuarono a lavorare come psicologi, psichiatri e consulenti di importanti istituzioni pubbliche, nonché a promuovere ricerche scientifiche intrise di pregiudizi razzisti. In tal modo, gli stereotipi ereditati dal Porrajmos [il genocidio dei rom] si perpetuarono anche nel dopoguerra, e condizionarono persino l’operato delle associazioni più sensibili ai diritti dei rom”. Ora osservo la città e non m’interessa tanto chi siano i rom, quale la loro identità, né è mio compito trasformarli in oggetti d’un racconto; rilevante è sfatare il significato della parola “rom” impiegato da istituzioni, giornalisti e altri commessi delle classi dirigenti.
Anche l’attribuzione di “nomade” è un’operazione del pensiero che domina, quasi un sogno borghese. Così la questione abitativa dei rom, sin dalla fine degli anni Sessanta, è stata affrontata in modo separato ed eccezionale. Secondo Bontempelli, per le istituzioni “gli ‘zingari’ non erano baraccati come tutti gli altri, e non dovevano essere confusi con i senzatetto, gli sfrattati e gli abitanti delle tante bidonville che ancora punteggiavano le periferie delle città”. A partire dagli anni Ottanta la creazione di aree di sosta e campi diventa una misura speciale per una minoranza esclusa da normali percorsi di cittadinanza: “almeno in Italia, gli interventi rivolti ai rom sono stati quasi sempre pensati come un settore specifico delle politiche pubbliche, separato dalle politiche sociali o abitative promosse per la generalità dei cittadini. Etichettati stereotipicamente come ‘nomadi’, rappresentati come un’alterità irriducibile e in qualche modo inassimilabile, i rom sono stati quasi sempre destinatari di interventi etnicamente connotati”. Sono peculiari, fra le altre, le vicende di rom jugoslavi fuggiti in Italia e costretti a vivere in campo nonostante avessero sempre abitato case prima d’allora. Il libro di Bontempelli è anche una storia dei campi come invenzioni governative.
Ora esploro una città punteggiata dai segni di campi sfollati e distrutti dalle ruspe: non solo Lungo Stura Lazio (2015), ma anche corso Tazzoli (2018), via Germagnano e via Reiss Romoli (2020). Gli sgomberi dell’ultimo decennio sono l’esito di politiche richieste dall’Unione Europea, volte a ridurre i ghetti, evitare la reclusione nei campi e delegittimare un approccio gestionale emergenziale. Le istituzioni cittadine assicurano che ogni distruzione è accompagnata da soluzioni d’inclusione, eppure alcuni abitanti di piazza d’Armi provenivano dal campo di via Germagnano, le famiglie non hanno ricevuto alcun aiuto efficace, mai, e sole si muovono in città braccate dalle volanti dei vigili. Perché, e com’è possibile? Dopo l’imposizione di campi connotati etnicamente, ed escludenti, si procede con la distruzione coatta delle baracche e la dispersione dei reietti: a errori decennali si rimedia con nuovi errori.
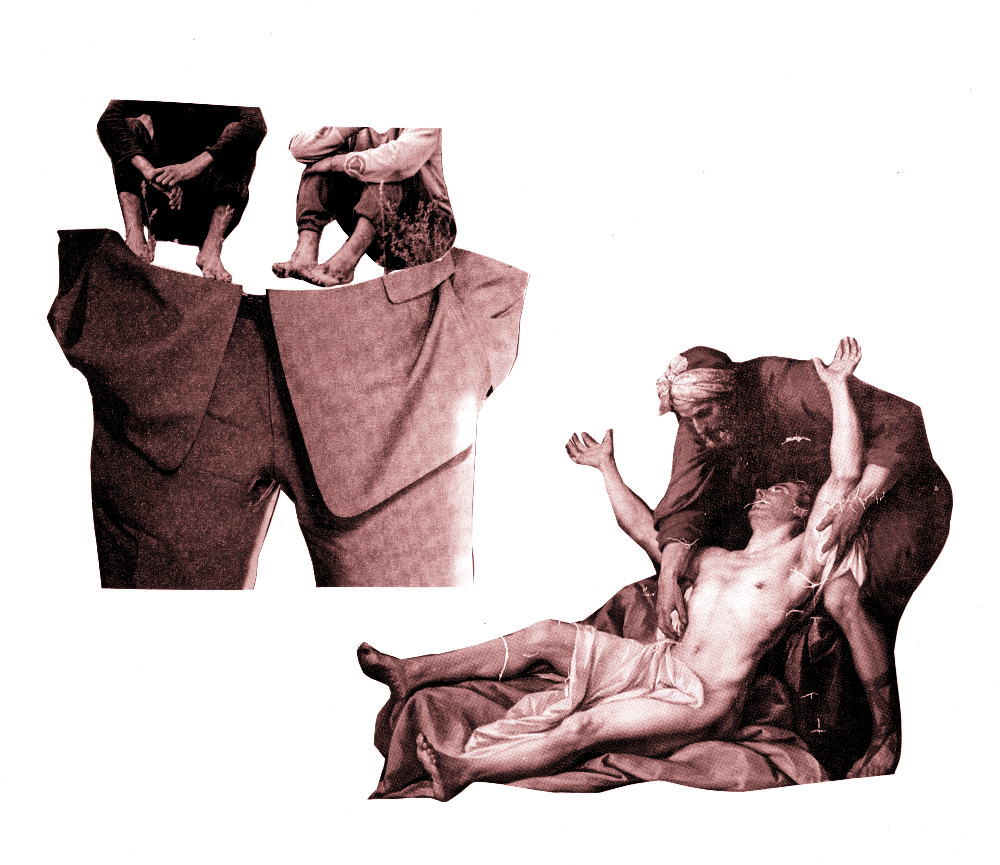
In questa amara, euforica primavera a Torino ho letto le delibere di sgombero, i progetti di inclusione, i protocolli scritti negli ultimi dieci anni. Nel 2012 Fassino era al governo e la deliberazione del 18 dicembre approva “iniziative progettuali volte al superamento delle criticità relative agli insediamenti di comunità nomadi (sic)”. Nasce così il progetto de “La città possibile” grazie a un finanziamento ministeriale di cinque milioni di euro. Il progetto è diviso in tre lotti e i primi due sono assegnati a un’associazione temporanea di enti del terzo settore: la cooperativa Valdocco, la cooperativa Liberitutti, Aizo (Associazione Italiana Zingari Oggi), l’impresa sociale Stranaidea e Terra del Fuoco, associazione nata dalla nebulosa di don Ciotti. Nel primo lotto, in particolare, si dispone il “superamento totale del sito spontaneo” di Lungo Stura Lazio con un finanziamento di due milioni di euro. Il capitolato speciale d’appalto redatto dalla Città di Torino sostiene che nel campo vi siano ottocento abitanti e prevede di inserire nelle iniziative di accompagnamento sociale seicento “ipotetici beneficiari”. Gli abitanti erano più di ottocento, ma è interessante limitarsi alla logica dei documenti governativi, e interrogarla: se è previsto lo sgombero completo, quale può essere la sorte degli abitanti eccedenti? Un progetto umanitario e benevolente istituisce sin dalla sua origine degli esclusi, divide i paria sommersi dai paria da salvare.
Per i salvati il progetto promette corsi di formazione, rimpatri in Romania, limitati percorsi di inclusione abitativa. Resto aderente alla razionalità dei documenti istituzionali e mi chiedo quali siano i criteri di inclusione e di esclusione. Gli estensori, improvvisati antropologi, distinguono alcune categorie di abitanti: ci sono “romeni” che “svolgono attività lavorative ordinarie”, abitanti le cui “attività lavorative” sono “al limite della legalità”, “persone che apparentemente (sic) svolgono attività di meccanica e ricambistica”, “Rom tradizionali nei costumi e negli usi che vivono di elemosina femminile e di espedienti”. I criteri di distinzione sono vaghi e incoerenti (se non paternalistici e razzisti al contempo), ma servono a definire chi merita di partecipare a un determinato percorso d’inclusione.
Lo strumento più efficace e sottile per operare il discrimine è un altro ancora e si chiama “patto di emersione”. Ogni nucleo familiare ben disposto verso i mediatori e i funzionari del progetto deve garantire “l’adesione incondizionata ad un ‘patto’ che dovrà sancirsi tra gli abitanti del sito e l’amministrazione comunale sui temi della scolarizzazione, della pulizia, della legalità. Per coloro che non collaboreranno e non aderiranno al Patto si valuteranno opportune misure a cura delle competenti autorità”. Il patto è dunque il bisturi che separa i meritevoli dai cattivi: è accolto nei percorsi d’aiuto chi manda i figli a scuola, collabora nella pulizia dei rifiuti, partecipa con costanza ai corsi di formazione e, soprattutto, rispetta la legalità. Ma la possibilità di abitare e lavorare dignitosamente non sono diritti? I diritti vengono formalmente assicurati soltanto a chi assolve doveri morali. Ora penso che i baraccati siano un campo sperimentale d’una democrazia a venire dove i diritti dipendono dalla buona condotta. Chi in questi mesi ha vissuto senza green pass mi può comprendere.
Torino è una città di governanti e funzionari ipocriti. I mediatori benevolenti, paternalisti, offrono soluzioni spesso effimere a chi si comporta bene e al contempo escludono e abbandonano i dannati della terra. I fondi del progetto “La città possibile” servono quindi a rompere i legami nel campo: chi accetta il ricatto lentamente se ne va, poi le baracche sono distrutte, gli spiazzi vuoti sono recintati con spesse reti arancioni, la Croce Rossa sorveglia le aree vuote per impedire ritorni. Infine, mentre i mediatori del terzo settore redigono la relazione finale, arrivano i celerini con gli scudi e gli operai con le ruspe. Gli ultimi, ormai isolati, piegano la testa e s’allontanano. Alcuni dirigenti de “La città possibile” sono stati indagati per truffa aggravata e frode in pubbliche forniture: la notizia ha increspato un poco la coscienza dei cittadini attenti, sono usciti articoli di denuncia. Ho il timore che l’attenzione dedicata agli atti illegali di classi dirigenti filantropiche distolga il pensiero critico dall’origine del problema: l’esistenza stessa, legale, d’un progetto fondato sulla discriminazione.
Torino è ipocrita, penso, quando osservo un manifesto sulla cancellata di piazza d’Armi: un albero è disegnato su uno sfondo verde e accanto leggo “Festival internazionale dell’economia. Merito, diversità, giustizia sociale”. Dal 31 maggio al 4 giugno, in aule e salotti diffusi in centro, parlano dal palco economisti, direttori di fondazioni bancarie, accademiche, assessori, scrittrici. La linea del festival è tracciata dal direttore scientifico Tito Boeri e sostiene l’equilibrio, entro il sistema capitalistico vigente, fra ricompensa meritocratica e giustizia sociale. La competizione, dunque, deve essere libera e favorire i migliori, ma al contempo deve mostrarsi attenta a ridurre le diseguaglianze, temperare le discriminazioni. Immagino dirigenti progressisti convinti di contendere il terreno dell’egemonia a capitalisti cinici e intransigenti. Uno strumento peculiare – quasi una loro ossessione – è “l’innovazione sociale”, ovvero la possibilità di trovare nuove soluzioni per migliorare la vivibilità delle città, le relazioni fra le persone, l’accesso ai servizi. L’innovazione sociale deve coinvolgere le istituzioni, il terzo settore, le imprese, il volontariato in un sistema di beneficenza organizzata e raggiunge il suo pieno obiettivo se riesce a generare profitto dagli stessi servizi offerti. Gli economisti benevolenti intendono valutare anche “l’impatto sociale” di queste iniziative filantropiche, ovvero indicare in modo quantitativo gli effetti dei progetti innovativi e il relativo risparmio per la spesa pubblica. I progressisti hanno un sogno: affidare i servizi sociali a ibride entità pubbliche e private, smantellare ancora il welfare, ridurre la spesa pubblica, incentivare la filantropia e il protagonismo del terzo settore, garantire la pace sociale magari ricavando profitti e posti di lavoro. Ma io economista non sono, osservo i campi dei disperati e il sogno degli ipocriti un incubo m’appare.

Porto con me i documenti del “Progetto speciale campi nomadi”, spiccano frasi evidenziate in calde giornate. Il progetto nasce con la deliberazione del 15 febbraio 2018, era il tempo di Chiara Appendino e Guido Montanari al governo. I finanziamenti sono esigui, duecento-cinquantamila euro assicurati dalla prefettura di Torino, e l’obiettivo prevede la cancellazione dei campi di via Germagnano, lungo la Stura. Ora è la cooperativa Liberitutti ad agire come capofila di una rete di enti che s’aggiudica il bando. Le procedure di sgombero sono ancora più grezze e violente rispetto al passato: agli abitanti di via Germagnano sono offerti mille euro per ogni nucleo familiare che accetta la demolizione della baracca. L’offerta scende a quattrocento euro se le famiglie erano già state coinvolte nei percorsi di inclusione de “La città possibile” (davvero, dunque, il progetto di Lungo Stura Lazio non ha funzionato e alcuni fuoriusciti si sono rifugiati in altri campi?). Secondo i mediatori culturali l’elemosina offerta serve per affrontare il viaggio di ritorno in Romania, oppure a pagare la caparra per un mese d’affitto in alloggio. I soldi della prefettura non bastano a coprire le offerte economiche, allora nell’estate del 2020 interviene la Compagnia di San Paolo, devolve a Liberitutti centro-trentamila euro e le famiglie sono allontanate dopo la firma dell’ennesimo patto di collaborazione.
La deliberazione del 10 dicembre 2019 sostiene che il “Progetto speciale campi nomadi” deve ispirarsi all’esempio virtuoso che ha portato allo sgombero delle palazzine dell’Ex-Moi, a sud della città. Anche in quel caso la Compagnia di San Paolo ha donato capitali per vani progetti sociali e poi è giunta la celere in tenuta anti-sommossa ad accerchiare gli edifici occupati. Questa procedura a Torino è chiamata “sgombero dolce”. La Compagnia di San Paolo è una fondazione bancaria che detiene il maggior pacchetto azionario di Intesa San Paolo; la banca a sua volta è una dei principali creditori della Città di Torino; la Città, ogni anno, versa capitali alla banca soltanto per pagare gli interessi sul debito. Il taglio dei servizi pubblici è una conseguenza di questo sistema di relazioni. Che impressione: la Città ha il collo stretto nella morsa di una banca e la relativa fondazione bancaria, certo filantropica, sparge briciole per favorire l’inclusione sociale, o gli sgomberi. Qui a Torino l’ipocrisia non è un atteggiamento sentimentale, ma una materiale componente cognitiva che struttura il capitalismo urbano.
L’associazione Liberitutti gestisce la casa del quartiere di via Agliè, in Barriera di Milano. Lo spazio mantiene in attività docce e bagni pubblici, offre un servizio di ristorazione, accoglie eventi culturali e dibattiti. Nella casa del quartiere è ospitato anche il laboratorio di Rasid Nikolic, marionettista e artista itinerante. Incontro Rasid in tarda mattinata in via Agliè, mi racconta della sua storia di rifugiato, delle sue origini al contempo serbe e bosniache e della sua consapevole appartenenza alla cultura rom. Rasid descrive il rapporto fra la sua arte e una parallela tensione politica: «Io sono schierato. Oltre alle marionette e ai dialoghi sulla cultura rom, sono anche artista di strada e credo nei precetti morali dell’arte di strada». Nei suoi spettacoli Rasid si propone di divulgare l’origine, il senso e i valori della cultura rom fra coloro che rom non sono.
Chiedo a Rasid se non è una contraddizione essere un attivista per i diritti dei rom e al contempo essere ospitato da un’associazione responsabile degli sgomberi: «La politica che vivo io qua dentro è questa: io ho un laboratorio e in cambio metto a posto e partecipo ai progetti come mediatore culturale. Ma i miei obiettivi non sono per forza paralleli, identici o affini a quelli della comunità rom che vive nel disagio». Per Rasid l’interlocutore è la borghesia, non il popolo dei campi: egli si rivolge ai cittadini italiani per renderli più consapevoli del mondo rom. Per questo collabora anche a progetti di formazione per mediatori culturali, vigili, professoresse e carabinieri. Non è certo Rasid a cadere in contraddizione, da artista ha il diritto di cavarsela come ritiene più opportuno; problematico è il discorso culturale che tende a risucchiare, inquadrare e digerire la sua figura. I buoni hanno bisogno di sentire le storie di Rasid, assolversi, legittimarsi come classe sociale dominante: la cultura ora m’appare come pubblico confessionale. Intanto le dure storie di baracche distrutte, le testimonianze dei marginali, i racconti di un esilio scatenato dalla sbornia di Eurovision cadono nell’oblio della pubblica incoscienza.
La cultura, termine vago e inafferrabile, mi sembra una patina di simboli fluidi, discorsi confezionati e merci seriali utile a impastare in un amalgama di legittimità l’arte di governo degli ipocriti. Il Salone del Libro di Torino è un rito peculiare, un abituale raduno dei cortigiani della cultura. Ho vagato per due giorni fra i padiglioni del Lingotto. Ricordo ad esempio un incontro con questo titolo: “Torino, Città che accoglie”; era presente l’assessore Tresso con delega alla protezione civile. Ascolto le frasi di Tresso registrate: «…Torino è sempre stata una città capace di dimostrare inclusione, di dimostrare anche solidarietà…». Qualche giorno dopo un altro dibattito proclamava nel titolo: “Torino città dell’inclusione”. Qui era presente Rosatelli, assessore alle politiche sociali con delega a “stranieri e nomadi”. Sento ancora la sua voce: «…penso che le persone che camminano per il Salone e si fermano anche solo per raccogliere qualche frammento di quel che diciamo, si rendano conto di quanta ricchezza c’è nella nostra città nel mondo della solidarietà organizzata, ricchezza umana senza dubbio, ma anche ricchezza professionale…». Accanto a Rosatelli sedeva Maria Cardino, funzionaria comunale per gli interventi a tutela delle minoranze etniche, dunque una responsabile degli sgomberi dei campi di baraccati.
Ho commesso un errore: è insulso trascorrere ore al Salone, ascoltare parole, temi, ovvero significati, nella speranza di tracciare un quadro critico dell’ideologia. Vi sarà sempre una nicchia, una sopravvivenza di pensiero indigeribile – forse fecondo, forse inutile. Capisco adesso, al suono delle registrazioni, che il vero dominatore della fiera è il brusio generale che avvolge i temi affrontati. A governare questo mondo è il cicaleccio, il fluire omogeneo e continuo di voci mentre fra le corsie s’aggirano automi, o meccanismi linguistici incoscienti, e portano il volto di Walter Veltroni, Nicola Lagioia, Lo Russo sindaco. Dai rumori emergono pezzi di lessico abusato: “Inclusione”, “Solidarietà”, “Diritti” – sono feticci di significato in una melma di cacofonie. Il brusio è la chiave per capire la gestione del potere simbolico al Salone e fuori dalle sue stanze. Ecco, un’accozzaglia di significanti annulla la sintassi, ovvero cancella i legami fra le parti, le connessioni logiche, le cause e gli effetti. La sintassi svanisce e così scompare il senso. Allora non è possibile una critica tematica al Salone, ma soltanto una critica musicale. Rammento Paul Celan, Mandelstam e Minstrels di Montale: vorrei reagire e trovare una svolta del respiro, impegnarmi in un lavoro d’intonazione, cercare il canto che singhiozza. Ma non riesco; e qui, in ogni caso, è necessario essere letterali e comprensibili. Ma per chi? Leggeranno mai i reietti?
A maggio, durante gli spettacoli di Eurovision e gli eventi del Salone del Libro, l’amministrazione al governo ha sgomberato altre famiglie in un campo autorizzato, in Strada dell’Aeroporto. Non sono state proposte soluzioni abitative e le nuove distruzioni appartengono ancora al “Progetto superamento campi nomadi”. Cambia la giunta, s’alternano i linguaggi degli assessori, ma inesorabili continuano le procedure amministrative, tecniche di governo indipendenti dalla retorica di nuove, vecchie fazioni al potere.
Sono in Strada dell’Aeroporto, alla frontiera settentrionale di Torino, un’ala del campo è in via di smantellamento. Molti abitanti sono già partiti, le ruspe hanno distrutto le case di fortuna e hanno lasciato i detriti a terra. Due baracche sono ancora in piedi, incontro le famiglie fra cumuli di macerie. Due anziani, uno in dialisi, hanno ottenuto una casa per la prossima settimana; l’altra famiglia, con sette minori, deve andarsene, e basta. L’uomo anziano è in Italia da cinque decenni e tutti gli adulti sono in questo campo dal 1991. Gli esiliati che abitavano accanto a loro hanno parcheggiato il loro mezzo in un angolo oscuro di città, oppure hanno aperto case popolari vuote. Una donna dice: «Guarda dove ci fanno vivere, tra i rifiuti! E ora ci mandano via». Quali sono le soluzioni proposte? Le forze dell’ordine e i funzionari comunali intimano di trovarsi un recesso poco visibile dove parcheggiare un mezzo. La zia più anziana racconta che solo otto mesi fa alcuni abitanti di Vallette hanno incendiato il camper di una loro parente, madre di diversi bambini. Per fortuna la donna è uscita in tempo con i figli, non è morto nessuno. «Capisci perché abbiamo paura ad andare via di qui, e stare da soli in città?». Vedo una fila di jersey in cemento. Mi raccontano che oltre le barriere vivevano baraccati poi fuggiti al tempo della pandemia; il comune ha demolito tutto, ha lasciato mucchi di frantumi e ha chiuso la strada. M’allontano, gli abitanti salutano e ripetono quasi cantando: «Vogliamo una casa, vogliamo una casa!». (francesco migliaccio)


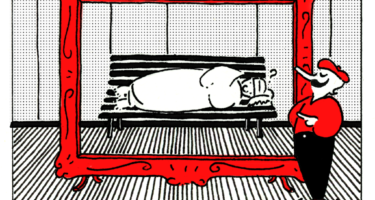


Leave a Reply