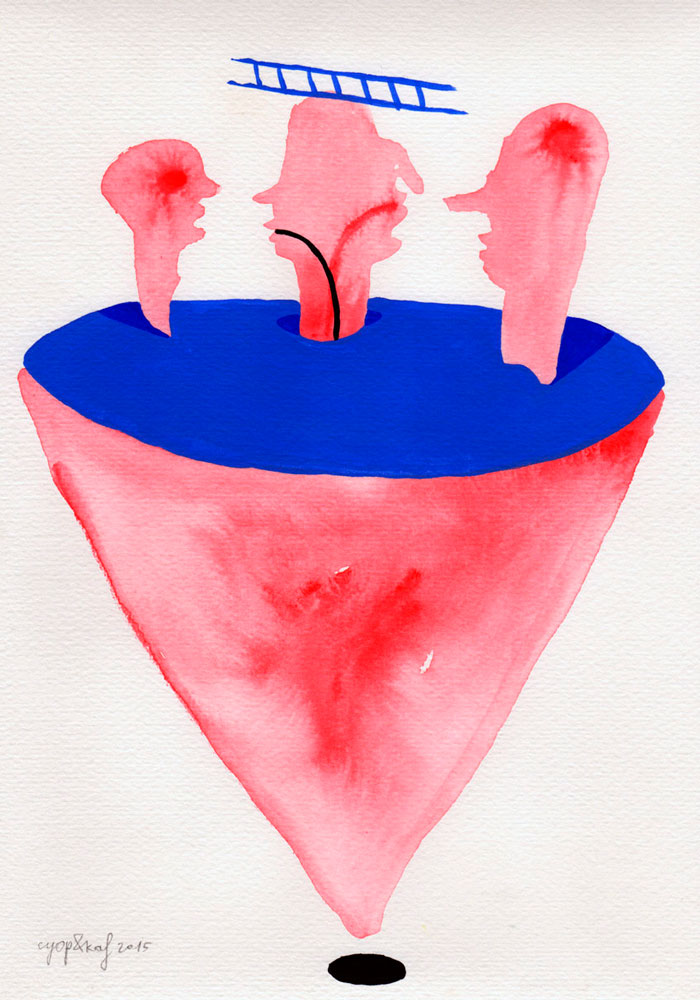
Rumino ancora parole e soprattutto immagini di Vite che non sono la mia di Emmanuel Carrère, libro che da pochi giorni ho chiuso, ma che prima di riporre lascio ancora per un po’ sul comodino, come quando si prova a ritardare la separazione da qualcosa che ci è appartenuto. Per un terzo del libro l’autore racconta l’evento di cui fu testimone durante una vacanza con la famiglia in Sri Lanka nel Natale del 2004, erano i giorni del maremoto, quando uno tsunami devastò le coste dell’isola. Carrère narra l’esperienza attraverso i suoi occhi, quelli del turista occidentale che viene travolto da una tragedia collettiva somma di tante enormi tragedie private. Territori devastati, distruzione di abitazioni e di attività si accompagnano alla più grave, la perdita di vite amate che l’onda ha con violenza strappato via dalla rena lasciando tra i detriti l’incomprensibilità del suo gesto. Il flagello colpì allora una comunità vittima di un altro flagello, quello della guerra civile, iniziata nel 1983 e cessata solo nel 2009 dopo un incerto periodo di tregua post-tsunami quando il male comune portò una ventata di solidarietà tra i civili in lotta. La stessa solidarietà che ha mosso Carrère e i suoi familiari ad aiutare in quell’occasione chi fu meno fortunato di loro – ché a volte si prova vergogna a essere felici da soli – e in particolare una coppia di francesi alla ricerca del corpo senza vita della figlia di quattro anni.
Carrère ci mette di fronte alla gratuità del dolore, alla sordità delle risposte di fronte alle grida delle domande, dandoci come compito per casa la ricerca del modo per sederci a tavola con l’assurdo. Ancora sporchi di fango e smarriti tra i detriti, nel breve tempo di un volo, l’autore ci porta in Francia dove racconta una sofferenza altrettanto ricca, la morte per cancro di una donna di trentatre anni. Si tratta di un’altra perdita, si tratta di un altro dolore, si tratta ancora di assurdo. Rumino ancora, e il caldo di questa sera di giugno mi chiede di uscire di casa. Incontro degli amici in una piazza con poche panchine mal disposte, ma dove si respira una brezza che stasera, a detta di uno di loro, ha sapore di mare. Accanto a me è seduto un ragazzo su cui non mi soffermo fino a che non si rivolge a noi chiedendo il permesso di parlare. Legge il sorriso aperto nei nostri occhi e si racconta. Viene dallo Sri Lanka ed è in cerca di lavoro. È in Italia da tredici anni e ha lavorato per molto tempo come operaio specializzato alla Malaguti di Bologna. Racconta di aver fatto tre mesi di formazione per acquisire le competenze necessarie a lavorare come meccanico, lui che invece ha studiato per diventare architetto. Vedendo il mio sguardo aprirsi in una smorfia di stupore e di curiosità, mi elenca le materie studiate contandole partendo dal mignolo. «Come ti chiami?», «Gerardo». «Sì ma il tuo vero nome qual è?». Dice il suo vero nome, noi lo ripetiamo, più volte, come a voler sciogliere la nostra lingua nella sua. Giochiamo con quei suoni forestieri e li restituiamo riaccentati. Lo dimentichiamo presto il suo vero nome, in molti lo avranno fatto, sarà per questo che ha imparato nel tempo a chiamarsi Gerardo. Dietro a ogni nome c’è una storia, tolta quella restano infinite verità, “non sa di nomi, la vita” ci ha detto Pirandello. Alla Malaguti riusciva a guadagnare anche tra i mille e quattrocento e i mille e ottocento euro mensili, ma la sconfitta industriale italiana ha coinvolto anche quell’azienda e, quando ha chiuso, Gerardo ha ripiegato su quei lavori che la maggior parte dei suoi connazionali è chiamata qui a svolgere: giardiniere, guardiano, badante, scaffalista.
I nostri occhi avanzano di un altro passo nella sua vita, le domande incalzano. Racconta che il padre morì durante il corso dei suoi studi e lui dovette abbandonare l’università e trovarsi un lavoro. La madre ostetrica, nonostante prendesse la pensione del marito defunto, non riusciva a sostenere la famiglia. Non ci spiega perché si trovi a vivere a Napoli, ma ci dice che qui ha difficoltà a trovare lavoro come meccanico specializzato. Ha quarantasei anni. Una moglie e due figlie in crescita lo ancorano al suo paese. Gli chiediamo dello Sri Lanka. Ci racconta che è un’isola piccola. Ma noi non ci crediamo e con sfacciata confidenza gesticoliamo un “ma va!”. Ci racconta che è molto più piccola dell’Italia. E di nuovo con il nostro “ma va!”, ad accentuare la confidenza concessa. Siamo curiosi. Chiediamo aiuto a Google Maps, e insieme a Gerardo sorvoliamo i cieli virtuali della sua terra. Confrontiamo con occhio approssimativo la dimensione dello Sri Lanka con quella dell’Italia, e giochiamo con le loro forme per scoprire quante volte l’isola è contenuta nella penisola. Ruotando l’una e capovolgendo l’altra cosa succede? E io immagino confini sconfinati, terre di nessuno e mari comunicanti ma di blu diversi. I nostri occhi ora piantano con forza entrambi i piedi nella sua vita e gli chiediamo di portarci a casa sua. Se i suoi occhi prima brillavano, adesso sono grandi torce nere di gioia. Gerardo ci chiede aiuto a utilizzare il cellulare, e insieme percorriamo con le dita le strade della sua città: ci mostra il centro del paese, la chiesa, la strada principale e quella che conduce a casa sua. È emozionato e noi con lui. Noi febbrili per la scoperta, lui per detenerne il segreto.
Gerardo vive con altre persone, ma ne parla come se gli fossero estranei, come se non ci fosse vicinanza. Come a sottolineare che in fondo è solo. (Si soffre la distanza, si soffre la vicinanza. Ma tu hai provato a misurarle?). Carrère ci ha parlato del dolore della perdita, della morte cinta in abbraccio dall’amore e dalla solidarietà; parole da vocabolario, ma dove per solidarietà intendiamo l’identificazione dei destini e per amore la fornace che alimenta il cuore. E mi viene in mente il romanzo La peste, dove Camus mette in scena la reazione dell’uomo alla tragedia del vivere e quindi del morire. E nella comunanza dei destini, l’uomo non ha altra strada che quella della comunione.
Si è fatto tardi. Ci salutiamo. Camminiamo tutti e soli verso casa. Ognuno sarà solo in casa sua. “In verità, tutto per loro diventava presente; bisogna dirlo, la peste aveva tolto a tutti la facoltà dell’amore e anche dell’amicizia; l’amore, infatti, richiede un po’ di futuro, e per noi non c’erano più che attimi”. Mi guardo attorno, osservo questa “città involontaria” che ci ha unito stasera. Entro in casa e apro il frigo. È semivuoto. Racimolo. Mi stendo sul letto, e in attesa che i sogni mi raccontino una favola, ripenso a quello che è accaduto in questa sera profonda. È stato un attimo, che per fortuna ricordo. (viviana malangone)





Leave a Reply