
Almaterra è un’associazione del terzo settore a Torino e si occupa di progetti di inclusione sociale volti a tutelare le donne e dare loro forza. Nel febbraio 2024 l’associazione interrompe il contratto di M., una lavoratrice, in seguito a contrasti interni. Due compagne di M. palesano la loro solidarietà e a loro volta sono estromesse dal lavoro. Ad aprile abbiamo pubblicato un loro comunicato. La loro storia non è un caso isolato, ma il sintomo delle profonde contraddizioni nel terzo settore e delle sue modalità gestionali. La contestazione in seno ad Almaterra nasce in seguito allo sciopero portato avanti dalle lavoratrici dell’associazione Eufemia e si inserisce in un percorso di consapevolezza critica nel lavoro sociale a Torino.
Pubblichiamo qui l’intervista alle quattro lavoratrici estromesse da Almaterra. L’intervista a M. e alle sue compagne si è tenuta il 3 luglio. Risulta una testimonianza corale. L’interruzione che separa una voce dall’altra è segnalata dalla fine di ogni paragrafo.
* * *
Di cosa si occupa l’associazione Almaterra? Qual era in particolare il vostro lavoro, e da quanto tempo ci lavoravate?
Almaterra è un’associazione che si descrive come “associazione di donne e per donne”, che vuole tutelare le donne e le soggettività vittime di violenza di genere e di qualsiasi forma di discriminazione, che sia di razza o a livello lavorativo. Ci sono diversi sportelli: uno per il supporto psicologico, uno legale, lo sportello per il lavoro, il laboratorio di italiano, e altri ancora. Per ogni servizio c’è una persona di riferimento. Io ho lavorato per Almaterra circa un anno e tre mesi, nella prima accoglienza. Era, in pratica, il primo ufficio dal quale si passa appena si entra nell’associazione, in cui confluivano tutte le persone che attraversavano lo spazio. Le mie mansioni erano attività di segreteria: curare i social, rispondere alle mail e al telefono dell’associazione, gestire gli appuntamenti di tutti i vari servizi. Io non ero inquadrata con un rapporto di lavoro subordinato, ma con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.), eppure avevo le chiavi dell’associazione e dovevo aprire ogni giorno alle nove. Un ruolo di grande responsabilità. Tutte noi svolgevamo inoltre mansioni che ci sono state imposte in un secondo momento. Io, per esempio, mi sono occupata anche dello scarico del banco alimentare, quando arrivavano i furgoni. La gestione pratica era sulle nostre spalle. Sono stata spesso redarguita per questioni di sicurezza, come se io ne fossi la responsabile, come nel caso del furto di un cellulare, eppure spesso mi era imposto di allontanarmi dalla segreteria perché mi venivano dati compiti da interprete o da mediatrice. Mi hanno fatto anche firmare in un’occasione dei fogli come interprete, senza che se ne fosse mai parlato in precedenza.
Io ho fatto il servizio civile in Almaterra, a metà del servizio civile sono diventata responsabile dello sportello lavoro dell’associazione, ruolo poi ricoperto per i tre anni e mezzo seguenti. Mi occupavo dell’inclusione lavorativa delle donne (o persone socializzate come donne) con background migratorio. Gestivo l’area “Inclusione, lavoro e nuove povertà”, coordinavo altre colleghe all’interno dei gruppi di lavoro e avevo dei ruoli di responsabilità. Anche al di fuori del mio orario di lavoro ricevevo continuamente chiamate e mail. Soprattutto la sera. Non potevo aspettare l’indomani per rispondere alle chiamate o alle mail perché ricevevo pressioni da parte dell’amministrazione per rimanere in contatto con assistenti sociali, avvocate e più in generale per rispondere alle necessità dell’associazione. Non avevamo alcun supporto psicologico nel nostro lavoro, nonostante fossimo a contatto con persone fragili e vittime di violenza, che vivevano storie pesanti e terribili legate alla tratta di esseri umani. Facevamo tutto questo senza ricevere nessun tipo di sostegno.
Io ho lavorato come insegnante di italiano, c’erano quattro classi e io ne seguivo due. Adesso è rimasta una sola insegnante. Ho fatto il colloquio per la scuola di italiano, ma mi è stato chiesto di fare anche eventuali corsi di informatica. Obiettai che non ero preparata a riguardo, ma la risposta è stata: «Tanto non sanno fare niente, molte di loro non sanno nemmeno accendere il cellulare». Mi hanno assunta con questi incarichi, più quello di fare delle riunioni mensili per un progetto di educativa.
Io ho iniziato quasi un anno fa, e ho cominciato come operatrice sociale, nella parte abitativa dell’associazione (Casa Clio), un progetto per nuclei monogenitoriali, ovvero famiglie di donne sole con bambini. Facevo quindici notti al mese, le restanti notti le copriva una collega. Avevo un co.co.co, però con orario di entrata e di uscita precisi: dalle sei la sera alle nove del mattino, chiudendo quindi il cancello e le porte per la notte. Ho sempre firmato i miei contratti minimo due o tre settimane dopo l’inizio del lavoro, l’ultimo contratto mi è stato fatto a novembre, dopo un mese, e ho dovuto ricordarlo io. Da ottobre mi sono poi spostata nell’area babysitting, tenevo tutti i bambini. Ho chiesto a un certo punto di avere una copertura maggiore perché i bambini erano molti rispetto alle figure preposte alla cura: mi è più volte stato rinfacciato che fossi io a chiedere troppo, o che forse avrei voluto lavorare di meno. Ma le condizioni di sicurezza per i bambini non c’erano: ho trovato io delle volontarie per aiutarmi.
Avevate tutte contratti analoghi?
Tutte avevamo un contratto co.co.co, tutte a scadenza, contratto determinato. Alcune di tre mesi, altre di un anno. Retribuzione ogni tre mesi e mezzo, firma del contratto a posteriori. Un compenso forfettario rispetto al co.co.co.
Noi siamo partite con le vertenze quando l’avvocata ci ha confermato che con il co.co.co tu dovresti gestirti in autonomia: puoi andare e venire con gli orari che vuoi, purché tu consegua il tuo obiettivo ovvero segua i tuoi progetti, quello che devi fare. Di fatto invece eravamo subordinate: avevamo il foglio ore mensile, gli orari non erano concordati, ma erano decisi in base a quelli dell’associazione e a quando loro volevano fossero offerti i servizi.
Una nostra ex-collega a novembre dell’anno scorso ha deciso di lasciare l’associazione. Nella lettera di licenziamento esplicitava che non avrebbe dato i trenta giorni di preavviso e che, se le avessero contestato le dimissioni, avrebbe fatto vertenza dimostrando inoltre l’esistenza di un rapporto subordinato mascherato da co.co.co. Dopo questa lettera la presidente e la vicepresidente si sono allarmate: da allora, per tenerci buone, hanno alluso alla possibilità di passare a contratti subordinati. Ma questo ci è sempre stato dato come prospettiva, non è stato qualcosa di reale.
A gennaio 2024 ci hanno detto: «Stiamo sentendo ancora il commercialista», ma il rinnovo seguente è stato di nuovo con il co-co-co.
Nei loro discorsi erano sottolineati soprattutto gli aspetti negativi del rapporto di subordinazione, dicevano che saremmo state pagate meno, che addirittura avrebbero utilizzato delle applicazioni per controllare il nostro operato: la geolocalizzazione per sapere dove andavamo durante gli accompagnamenti, i badge da timbrare.
Eravamo sotto il costante ricatto del rinnovo contrattuale. Inoltre, nello stesso foglio ore che inviavamo mensilmente all’amministrazione nel quale inserivamo le attività di lavoro svolte, dovevamo indicare anche le ore di volontariato, indicando giorno e ora.
Una condizione implicita del lavoro era quindi quella di prestare anche ore di volontariato?
Sì, ed era controllato. Ci veniva detto: «È altamente consigliato». Avendo dieci ore di lavoro soltanto e svolgendo anche altri lavori per campare, io non sapevo se avrei trovato il tempo, ma la risposta è stata: «Noi tutte abbiamo fatto ore e ore di volontariato e di lavoro non retribuito, bisogna credere nell’associazione». La storia della grande famiglia, tutte sorelle, un classico.
Come è comune a tutto il terzo settore, era molto sfruttata la nostra empatia, la volontà di aiutare le persone, perché una magari si prende a cuore delle situazioni di violenza. Pomeriggi interi a lavorare, ma tanto era volontariato. Cosa fai, non ti metti a disposizione? La persona cosa deve fare, andare da sola? Sei una donna, non ti riconosci ad aiutare un’altra donna? Giornate molto pesanti in cui magari andavi a dormire senza avere avuto nemmeno un supporto psicologico, e ti avevano pagato tre ore di ufficio delle dieci fatte. E poi la reperibilità continua: messaggi, chiamate anche nei weekend o in orario serale. E se non rispondevi poi c’erano ripercussioni psicologiche, di demansionamento.
In alcune situazioni veniva “richiesta” la mia disponibilità per partecipare a degli eventi istituzionali, in realtà mi veniva imposto di andarci. C’era una pressione psicologica per la partecipazione alle iniziative con la Città di Torino, con Rosatelli (assessore alle politiche sociali, ndr), con Urban Lab, ed era molto importante che a presenziare fosse, per esempio, quella tra di noi di seconda generazione: il discorso di immagine era importantissimo. Mi è stato specificato in seguito che si trattava di volontariato e che non avrei ricevuto alcuna retribuzione per quelle giornate di lavoro.
L’associazione si presenta come inclusiva e attenta alle discriminazioni, fornisce un’immagine che deve passare all’esterno, ma è notevole il contrasto con la realtà che vi siete trovate a vivere.
Io sono stata sminuita da una delle figure direttive, che mi ha detto: «Se le persone ti stanno a sentire è solo perché sei bionda con la minigonna». Questo uno tra i tanti esempi di sessismo, neppure velato, tra donne, in un’associazione che si autodefinisce “transfemminista”.
Nei confronti delle persone che attraversavano l’associazione c’era un atteggiamento molto discriminatorio, razzista. Le nigeriane erano tutte “urlatrici”, “pazze”, donne che “pensano di essere al mercato”, mentre “qui siamo in Italia e per discutere non si urla” (elemento opinabile tra l’altro). Non c’era attenzione ai nomi: «Come si chiama? Vabbè, quella là». Nei confronti delle donne della residenza ho sentito più volte frasi gravissime, una in particolare: «Questa va a scopare in giro e noi le manteniamo il figlio!»
Io ho chiesto in alcuni casi che ci fosse attenzione rispetto all’utilizzo di un linguaggio inclusivo, e sono stata liquidata con due parole, mi hanno chiamata “scioglilingua”. E questo nonostante si facessero delle summer school e delle iniziative sul linguaggio inclusivo! Questo è quello che stava dietro all’immagine pubblica dell’associazione. E quando capitava che qualcuno alzasse un poco la voce: «Qua non siamo al mercato!».
La discriminazione era palese davanti alle persone stesse. Una delle figure responsabili purtroppo è una figura molto intimorente, dagli atteggiamenti spesso razzisti.
Era una questione anche più grave secondo me. La permanenza nella parte abitativa dell’associazione non è a lungo termine: si pensa che ci si possa restare un anno e mezzo, due anni, e poi si trova un’altra sistemazione. Le persone arrivano dall’emergenza abitativa del comune di Torino, a seguito di uno sfratto. Ad alcune si trova una casa ma non esiste che possano rifiutarla: hanno già infastidito troppo e non se lo meritano. C’è molta infantilizzazione, sudditanza, premialità.
Come è esplosa per voi questa bolla, come siete giunte alla consapevolezza?
Questo clima era molto frustrante. L’evento scatenante è avvenuto il 7 dicembre 2023, mentre eravamo in mensa, dove lavora come cuoca una nostra collega. In mensa possono venire a crearsi situazioni difficili da gestire o di tensione. In una di queste situazioni, perché era terminato il cibo, una delle figure dirigenti è scesa e invece di disinnescare la tensione si è rivolta alla cuoca in modo molto grave, urlandole in faccia. Io avevo spesso notato un atteggiamento svilente e colpevolizzante nei suoi confronti. Ho preso le sue difese perché non era responsabilità sua se il cibo che le danno da preparare è limitato; in risposta sono stata fisicamente strattonata e spinta contro il muro, successivamente mi è stato imposto di uscire dalla stanza. Ho chiesto spiegazioni e la risposta è stata: «Io sono l’autorità e faccio quello che voglio». Le ragazze del servizio civile e le persone beneficiarie dei servizi sono rimaste visibilmente turbate. C’erano tante persone. Dopo questo episodio di violenza ho deciso di scrivere una lettera ad alcune socie, al direttivo e ad alcune colleghe che lavoravano con me tutti i giorni, in cui ho fatto emergere cos’era accaduto, chiedendo un momento di confronto collettivo per parlare delle dinamiche interne all’associazione e migliorare la situazione. L’altra figura dirigente mi ha ripetuto più volte che avremmo creato dei momenti di confronto in seguito, ma sempre individuali – «…perché non abbiamo tempo da perdere, non affronteremo collettivamente le problematicità da te sollevate», diceva. Tuttavia, dopo questa lettera, c’è stato un atteggiamento estremamente ostile nei miei confronti. In seguito a tutti questi spiacevoli avvenimenti sul posto di lavoro, ho iniziato a non stare bene e a soffrire di attacchi di panico. Nonostante avessi esplicitato il mio malessere, ho ricevuto un provvedimento disciplinare con l’accusa di aver leso l’immagine dell’associazione con la condivisione del testo sopracitato, sostenendo tra l’altro che la lettera fosse indirizzata a terzi.
Inoltre con il co.co.co non è previsto alcun provvedimento disciplinare, mica sei una lavoratrice subordinata!
Ricevendo questa contestazione disciplinare, ho risposto insieme alla mia rappresentante sindacale con un’audizione orale riportando le mie giustificazioni. La loro risposta è stata il licenziamento come conseguenza della sanzione disciplinare, avvenuto quindici giorni prima della scadenza del mio contratto come ennesima ritorsione nei miei confronti. Quindi in un’assemblea convocata il 23 aprile uno dei punti all’ordine del giorno era la mia esclusione dall’associazione: mi hanno espulsa come socia. Io, fino a quel momento, gestivo il registro delle socie e, guarda caso, poco prima dell’assemblea le associate erano diventate molte di più. Quel giorno ci saranno state una cinquantina di persone in più del solito, con molte deleghe.
Ci sono analogie con quanto raccontato dalle lavoratrici di Eufemia. Con loro abbiamo ragionato sul ruolo del bando di Compagnia di San Paolo. La fondazione assicura finanziamenti in cambio di una ristrutturazione delle gerarchie interne. In Almaterra erano cambiate le dinamiche interne?
Almaterra ha partecipato al bando del Next Generation You, un processo di aziendalizzazione del terzo settore. Il progetto è iniziato nel 2023, ad aprile: puntava a gestire al meglio le risorse economiche; inoltre intendeva definire ruoli interni ben circoscritti, organigrammi, processi decisionali definiti, e verticistici. E guarda caso chi ricopriva i ruoli di potere erano sempre le solite due figure. In più è stata assunta una persona come supervisor, amica della presidente. Quindi il suo ruolo di mediatrice era compromesso dal fatto di non essere affatto una figura esterna e neutra.
Rispetto a quanto accaduto per Eufemia c’è una importante differenza, ovvero che noi non ci siamo mosse per avere un ruolo nel direttivo, perché una di noi già ne faceva parte.
È importante dire che il direttivo era un fantoccio: quattro persone sempre d’accordo e nessuna trasparenza. Così come nel caso dell’espulsione di M., dove la figura di responsabile ha deciso da sola di licenziarla, perché il consiglio direttivo non si è riunito, non è stato neanche convocato. È stato risposto che, da statuto, in una situazione di emergenza la presidente può prendere tutte le decisioni senza consultare nessuno.
Dopo il licenziamento di M. non era un segreto che fossimo solidali con lei. Anche io ho chiesto più volte un confronto collettivo per parlare del clima interno, ma non è stato mai concesso. E si è arrivati anche al nostro licenziamento.
Come è stato giustificato il vostro licenziamento?
Da tempo sapevamo che sarebbero stati necessari lavori di bonifica dei locali in seguito al rilevamento di amianto, tant’è che alcune attività come il babysitting già erano state spostate per un periodo in un’altra sede. Ma di colpo la questione è stata presentata come una situazione emergenziale, giustificando il nostro licenziamento “per motivi della nostra sicurezza”. E sottolineo: la nostra sicurezza? Quando di norma firmavamo il contratto un mese dopo!
Parlare di sicurezza per me era il colmo. Con il cambio dei locali era stato imposto di spostare il servizio di babysitting in un luogo per niente adatto ai bambini, con mobili molto spigolosi, ma alla mia proposta di fare una pausa di qualche giorno per creare delle minime condizioni di sicurezza mi risposero perentoriamente di no, perché «si deve dare continuità al servizio», e invece di lì a poco ci hanno addirittura lasciate a casa!
Insomma, i lavori a causa dell’amianto richiedono un trasloco. Dopo cinque giorni in cui siamo impegnate a fare scatoloni, il venerdì ci viene fatta una convocazione telefonica. Siamo in videochiamata con la nostra coordinatrice che ci dice che il servizio di italiano e di babysitting, per la nostra sicurezza, non sarebbe più potuto andare avanti e ci si imponeva una sospensione di due settimane.
A me era stato richiesto di svolgere comunque del lavoro – d’altra parte nelle due settimane di sospensione ci avrebbero pagate – quindi stavo preparando i compiti a casa da consegnare alle donne che seguivano le mie lezioni di italiano. Poi, dopo il weekend, ci arriva la lettera di licenziamento.
Anzi, non un licenziamento, perché noi non siamo subordinate: è un’interruzione del contratto con anticipo di circa un mese. Sottile: noi così non abbiamo diritto a nessun tipo di ammortizzatore sociale.
Arrivavo da un lavoro di quattro anni come rider, quindi con una multinazionale dove non viene minimamente preso in considerazione il lato umano, sei un numero e basta. Purtroppo ho riscontrato che il rapporto con le figure dirigenti di Almaterra è stato identico. Sono entrata nel terzo settore ignara di queste dinamiche allucinanti e sono stata licenziata con una mail, senza ricevere nemmeno un messaggio o una telefonata. Diversamente invece avveniva quando, a seconda delle loro esigenze, mi contattavano fuori dagli orari di lavoro per risolvere questioni legate alle attività da me svolte in associazione.
Io, invece, ho trovato doloroso interrompere un lavoro con persone che seguivo da otto mesi: e la continuità con i bambini, l’importanza di avere una figura di riferimento?
Per fortuna è scaturita più rabbia che presa male e abbiamo iniziato a organizzarci. L’otto marzo abbiamo volantinato in piazza per far emergere anche la nostra situazione lavorativa e, dopo il nostro intervento al microfono, per puro caso ho incontrato una compagna che mi ha detto di essere stata contattata proprio da Almaterra per insegnare italiano. L’ennesima conferma di un licenziamento avvenuto solamente perché eravamo scomode.
Fino a oggi (il giorno dell’intervista, ndr) non hanno assunto nessuno di nuovo, per ricoprire i nostri ruoli ci sono state le partecipanti al servizio civile che, pagate una cifra irrisoria, svolgevano le nostre mansioni. L’amministrazione delle figure dirigenti esplicitava la necessità di fare un cambio generazionale, per cercare una nuova freschezza, nuove idee. In verità fare contratti a persone giovani e sensibili a tematiche di genere e transfemministe è un modo per strumentalizzarne la sensibilità e renderle più ricattabili, sfruttabili dal punto di vista lavorativo, con contratti precari.
È molto complicato trovare gli strumenti giusti per lottare e uscire anche dalla disperazione individuale.
Io ho impugnato il licenziamento senza ottenere risposta. Con le vertenze tutte chiediamo le differenze retributive rispetto alla subordinazione e il reintegro lavorativo. Per noi è la prima volta che ci troviamo a tematizzare determinate questioni sullo sfruttamento lavorativo all’interno del terzo settore. Abbiamo organizzato un’assemblea pubblica il 23 giugno. Per noi è stato molto importante e, vista la grande partecipazione, cercheremo di rilanciare altri momenti come questo.
Di solito quando ci si confronta sui problemi legati al lavoro sociale, ma non solo, si è molto appesantite e demoralizzate o spesso si ha paura di fare vertenza per timore di non trovare più un impiego nel settore. Invece noi pensiamo che lottare contro le condizioni di sfruttamento lavorativo sia fondamentale per far sì che sempre più lavoratrici e lavoratori trovino il coraggio di raccontare la loro storia e di reagire insieme. La nostra vertenza è solo un tassello che si aggiunge a questo percorso, è uno strumento che si mette in atto per far pressione al padrone. È fondamentale trasmettere questa consapevolezza: i vertici del terzo settore non si aspettano che ci siano lavoratrici pronte a rispondere alle ritorsioni e agli attacchi sul posto di lavoro. (intervista a cura di stefania spinelli)


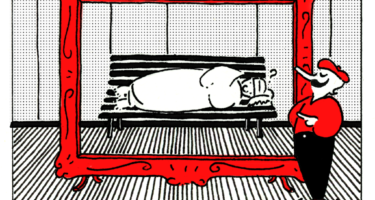


Leave a Reply