
Sono le nove di una sera di fine gennaio a Milano e tra un’ora inizierà il coprifuoco. Ho raggiunto la stazione centrale a piedi attraversando il centro della città. Piove, le strade deserte sono bagnate, l’aria è umida. Sotto i porticati di via Vittorio Pisani incontro le prime persone. Un uomo dorme seduto su una scatola di cartone, la testa inclinata in avanti. Un altro sta in piedi, fermo davanti a un carrello della spesa che contiene due grosse valige. Ha il volto segnato, lo sguardo assente, i capelli bianchi e trascurati che contrastano con gli abiti eleganti che indossa: una giacca scura, un paio di pantaloni chiari e una sciarpa di lana.
Sono indeciso se continuare o fermarmi: proseguo. Appena gli sono davanti si rivolge a me chiedendo un euro per il caffè. Mi fermo, in tasca ho venti centesimi, gli dico che ho solo quella moneta e ne approfitto per chiedergli come sta e da quale paese viene. «Ghana», mi risponde. «Sono stato ad Accra e Kumasi», gli dico. «Sei stato lì? Ora hai tanti amici lì?», reagisce un po’ sorpreso; fa una pausa e aggiunge: «Devi fare attenzione. C’è quello che parla bene e quello che non parla bene. Il cervello può uccidere». Non capisco, gli chiedo: «Perché?». La risposta è altrettanto oscura: l’uomo non parla bene in italiano e il discorso è difficile da seguire. Cerco di orientarmi tra le parole, provo a dargli un senso generale. Penso che deve avere sofferto molto, tradito forse da un amico a cui era legato. Gli chiedo se è stato in galera. «Non lo so perché parlare così. Che significa galera? Quelli che uccidere persone devi andare in galera. Quelli che non fa male a nessuno non deve andare in galera».
Capisco che si è sentito offeso. Gli do ragione e cerco di giustificarmi. Ma lui, indispettito, riprende a parlare in modo confuso, poi chiude il discorso dicendomi: «Scusa tanto per venti centesimi, grazie tanto, ti saluto» e si allontana mentre io resto sul posto turbato da quell’epilogo. Poco dopo lo raggiungo per chiedergli scusa. Ora ho davanti un’altra persona. Non faccio più caso alle parole, osservo il suo volto gonfio, gli occhi spalancati e rossi. Ho paura, temo un gesto improvviso, arretro lentamente e aspetto che smetta di parlare per salutarlo e andare via.
Percorro via Ferrante Aporti, una strada che costeggia i binari della stazione, fino al portico d’ingresso del Memoriale della Shoah. Qui decine di persone hanno trovato un riparo per la notte. Alcune sono in piedi, altre a terra protette da ampie coperte. Mi avvicino.
«Ciao, come state?».
«Bene, bene».
«Mi chiamo Salvatore. Dormite qua?»
«Sì».
«Siete in tanti a dormire qua?»
«Sì tanti dormi qua. Loro girare, dopo torna qua… C’è altra zona sotto il ponte, dietro».
«Non avete una casa?».
«No, noi dormiamo qua».
«Nessuno vi aiuta?».
«Loro ci aiuta: mangiare, coperte, vestiti, ma casa no».
«Da dove venite?».
«Senegal».
«Siete da molto tempo in Italia?».
«Sì, io abito qua da quattro anni».
«A Milano?».
«A Milano tre anni».
«Da tre anni dormi qua?».
«No, non è tre anni. Solo due mesi io stare qua».
«Prima dove dormivi?».
«Io andare altri amici, non ce l’hai famiglia ma amico, amica qua».
«Lavorate?».
«Prima lavoravo, adesso…».
«Non avete i documenti».
«No, non abbiamo i documenti».
«Li avete avuti in passato?».
«Io ce l’ho documento però cambiare è problema».
«Perché?».
«Non ce l’ho contratto di lavoro».
«È difficile?»
«La vita non è facile».
Arrivano altre persone. «Ciao, come stai?», mi chiede uno di loro. È un ragazzo basso, con gli occhi spenti e un paio di baffi su un viso giovane. Gli chiedo da dove viene. «Sono del Senegal e tu?». «Io sono di Napoli». «Oh amico mio! Comm’ stai? Tutto a post’? Sono stato a Napoli, eh!», dice in modo accorato e con un forte accento meridionale. Poi racconta di aver vissuto a Salerno prima di trasferirsi a Milano; lì ha lavorato in un ristorante e pure in una fabbrica, guadagnava bene, ma con la diffusione del virus hanno chiuso tutto ed è partito. È nervoso, mi spiega, e stressato perché pensa ai genitori in Africa: come faranno a vivere senza il suo aiuto?
Fa una breve pausa, mi osserva e chiede sorridendo: «Ma chi sei? Sei uno sbirro? Dimmi la verità! Giura! Giura su tua mamma. Fammi vedere la tua carta». Gli spiego che sono lì per raccogliere le loro storie, per capire quali difficoltà hanno e come aiutarli. Mentre parlo però mi accorgo che le mie parole sono generiche. Propongo allora di chiamare un amico gambiano che conosco da anni e che può garantire per me. Accetta e gli passo il cellulare. Al termine della telefonata allunga la mano in segno di amicizia e accetta di accompagnarmi a vedere altri luoghi della stazione dove le persone si rifugiano di notte. Camminando mi racconta che una volta una signora italiana, vedendo come erano sistemati, si è commossa e ha pianto. «Ti rendi conto! Una cosa incredibile», aggiunge stupito.
Mi racconta la sua storia. Dice che è arrivato in Italia con la barca nel 2015. Aveva sedici anni, oggi ne ha ventidue. Ha viaggiato senza i genitori che sono rimasti in Africa. È stato prima a Vibo Valentia, poi a Salerno e ora a Milano. Qui ha frequentato la scuola per stranieri ottenendo la licenza media. Gli chiedo se anche lui dorme per strada. Risponde di no. La sera quando è stanco di camminare va a casa di un amico a riposarsi. Ci fermiamo davanti al sottopasso ferroviario di viale Lunigiana. «A mezzanotte è pieno», dice. Osservo questo tunnel sostenuto da vecchie colonne di ghisa e formato da tre campate, due per le automobili e una centrale per i pedoni. In lontananza noto una coperta rossa stesa sul selciato grigio, segno che qualcuno si è già sistemato per la notte tra il rumore assordante delle macchine che passano veloci.
Superato il tunnel il ragazzo inizia a lamentarsi: ha fame. Capisco che è già stufo di fare la guida e gli propongo di andare insieme a comprare un panino e una birra. Entriamo in un primo locale, si informa sui prezzi e poi ad alta voce dice: «Andiamo avanti. Qua non conviene proprio. Mi dispiace amico». Percorriamo ora via Fabio Filzi in direzione di piazza Quattro Novembre. Il coprifuoco è iniziato da qualche ora e per le strade intorno alla stazione si vedono solo immigrati che si aggirano a coppie di due.
Ci fermiamo davanti a un altro locale. Qui i prezzi sono più bassi ma anche la qualità del cibo sembra inferiore. A lui non sembra interessare questo aspetto e ordina una decina di crocchette di pollo. Di ritorno verso il Memoriale della Shoah mi racconta di avere una fidanzata a Napoli, conosciuta a piazza Garibaldi grazie a un amico in comune. Dice che scende spesso giù a trovarla, che dorme a casa sua e aiuta la madre vedova con piccoli lavori.
In via Ferrante Aporti incontriamo l’unità di medicina di strada del Naga, un’associazione milanese che si batte per i diritti dei cittadini stranieri. I volontari hanno parcheggiato il camper a bordi della strada e stanno sistemando un tavolino sul marciapiede dove si sono raggruppate alcune persone. Ci avviciniamo per salutarli e poi proseguiamo per unirci al gruppo che sosta sotto i porticati del Memoriale.
Si avvicina un ragazzo con un ampio cappuccio che gli copre parte del volto piccolo e spaesato. «Ieri mi hanno regalato un telefono però non ho i soldi per comprare la scheda», mi dice mostrando il cellulare nuovo. «Sono di Lodi, da due mesi sono qua in giro, devo tornare il 10 febbraio». Gli chiedo perché solo il 10 e non prima. Mi racconta che era fidanzato con una ragazza italiana, andavano a scuola insieme e a volte fumavano delle canne. Poi si sono lasciati, lui si è fidanzato con un’altra ragazza e la sua ex per ripicca è andata in questura. All’epoca non è successo niente perché era minorenne, ma nel 2020, tre mesi dopo aver compiuto ventuno anni, lo hanno arrestato. Ha fatto otto mesi di carcere e poi gli hanno detto di andare via dal comune fino a febbraio.
«Vuoi vedere i documenti?», mi chiede e poi ripete: «Voglio comprare la scheda però non c’ho soldi, se dormi qua ti rubano tutto. Ieri avevo i soldi per comprarla però mi sono addormentato e stamattina non c’avevo più niente». Mi mostra il provvedimento del giudice che leggo ad alta voce: «Divieto di dimora dal comune di Lodi… in sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari…». Gli chiedo: «A Lodi non avevi un posto dove stare? Non hai amici o parenti? Nessuno di loro poteva aiutarti?». Mi spiega che ora non può tornare perché rischia di essere arrestato, ma appena potrà ritornerà nella casa che condivideva con un amico. A Lodi abita da cinque anni, ha studiato fino al primo anno di superiori, poi ha iniziato a lavorare come commesso in un negozio di abbigliamento. «Ora sono sulla strada. Questa è la mia prima volta. Prima, prima, prima. Infatti non ce l’ho l’esperienza. Io non mi vestivo così. Sembro come un barbone». Mi mostra i vestiti e le giacche: la prima, la seconda, la terza, che indossa una sull’altra per proteggersi dal freddo. Poi, assillato da un pensiero che non riesce a dominare, dice: «Vado a fare un giro in Centrale. Vedo se riesco a trovare i soldi per comprare la scheda».
Arriva un gruppo di giovani volontari che si ferma davanti al porticato con un cestino giallo della spesa colmo di viveri. Distribuiscono bevande calde, pizze, biscotti e frutta. Qualcuno si avvicina, altri aspettano il loro turno seduti a terra. Osservo questa scena in disparte mentre bevono e mangiano in silenzio per poi scomparire di nuovo sotto delle pesanti coperte.
Decido di spostarmi e raggiungere il sottopasso Mortirolo. All’ingresso incontro un altro gruppo di volontari. Fanno parte dell’associazione Islam 360, escono due volte a settimana e ognuno di loro porta con sé quello che riesce: vestiti, coperte e cibo. Hanno iniziato prima del Covid, poi hanno interrotto per tutto il 2020 e ora hanno ripreso da qualche settimana. «È semplicemente un messaggio», mi dicono in coro. Attendo che si allontanino prima di entrare nel sottopasso. Anche questo è composto da tre campate, ma è più largo e imponente di quello precedente, sorretto da robusti pilastri che scandiscono lo spazio. Ai piedi di queste strutture, che separano le corsie laterali (a un senso di marcia) da quella centrale (a doppio senso), ci sono due marciapiedi appena sopraelevati dal livello stradale e protetti da una ringhiera continua. In questo spazio angusto, ogni giorno, decine di persone trovano un riparo per la notte.
Il primo che incontro è ancora sveglio. Sta seduto a terra con le spalle appoggiate al muro e le gambe incrociate. Mi guarda senza rispondere alle mie domande e continua a toccarsi la nuca. Più avanti mi fermo a osservare un giaciglio fatto di coperte adagiate sull’asfalto. Per un istante dubito che lì sotto ci sia qualcuno a dormire, poi il movimento rapido di un corpo che cambia posizione mi fa ricredere. Mi chiedo cosa si provi a stare lì a terra, sul ciglio della strada, protetto solo da un pezzo di stoffa. (salvatore porcaro)


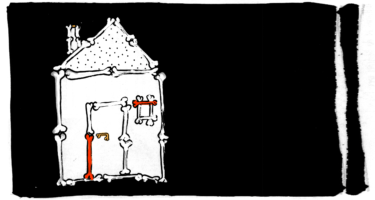
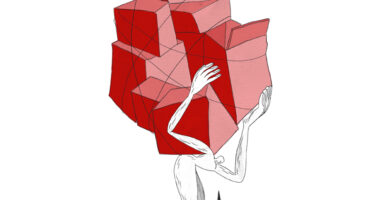

1 Comment