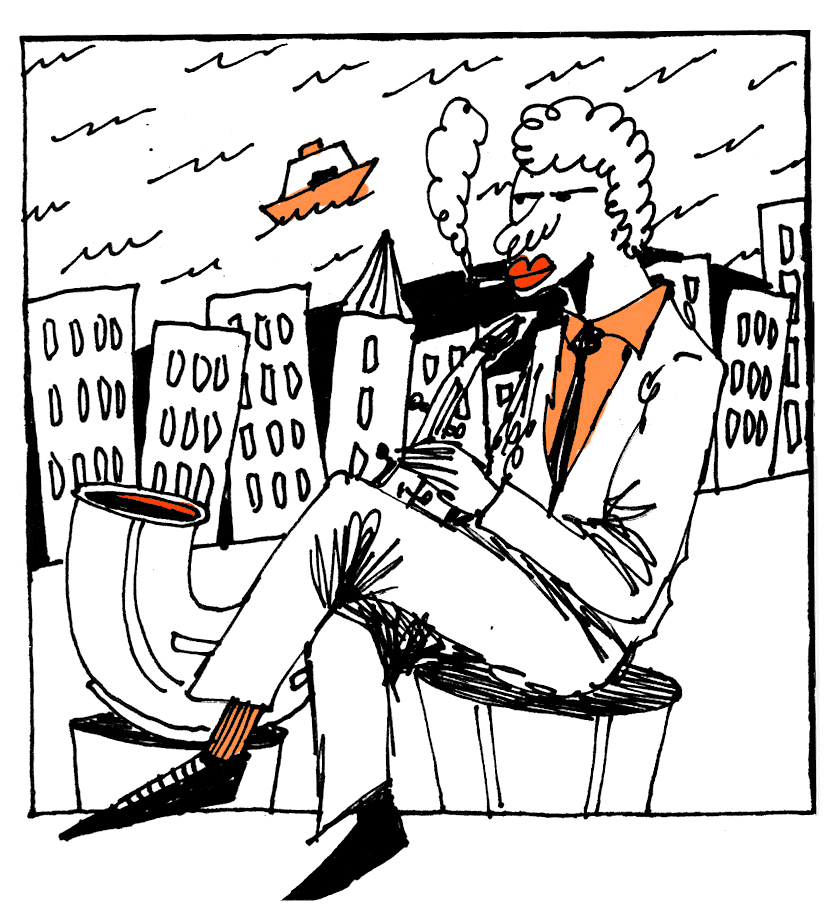
C’era veramente bisogno di un libro che portasse come titolo la parola Gentrification. Questo libro è Gentrification: tutte le città come Disneyland? di Giovanni Semi (Il Mulino, 2015). Premetto, per chi non lo sa, che la gentrification (c’è chi dice “centrificazione”) è quando un quartiere operaio si popola di nuovi abitanti borghesi, che fanno cambiare il tipo di negozi, il tipo di vita notturna, la qualità degli spazi pubblici e soprattutto il prezzo delle case. È una parola troppo importante per dover ancora combattere contro i negazionisti, cioè quelli che sostengono che la gentrification non esiste, che è solo la dura legge del mercato, o che in Italia non succede, o che non si può comparare con l’America o l’Inghilterra. Negli Stati Uniti il dibattito è molto acceso, la parola viene usata regolarmente sui giornali, e anche se ci si scontra tra chi è a favore e chi è contrario, difficilmente si nega l’esistenza del fenomeno; anche perché ormai da mezzo secolo gruppi di cittadini lottano contro la gentrification dei loro quartieri. Semi cita un episodio del 2014, quando Spike Lee in un dibattito pubblico si è scagliato contro i gentrificatori che pretendono di aver “scoperto” Brooklyn, dove suo padre vive e suona jazz fin dagli anni Sessanta, e che ora chiamano la polizia perché la sua musica li disturba.
Oltre ai negazionisti, ci sono poi i giustificazionisti: quelli che, magari in buona fede, sostengono che i pregi della gentrification sono maggiori dei difetti, che i quartieri gentrificati un tempo erano troppo degradati, e che tutti i giovani o gli studenti che ci sono andati a vivere in realtà hanno portato un gran beneficio. La proliferazione di queste tesi è stata descritta in un bellissimo articolo di Tom Slater, intitolato Missing Marcuse, in cui si evocava la figura dello studioso Peter Marcuse, che per tutta la vita ha insistito che non si può parlare di gentrification senza parlare di displacement, cioè di espulsioni. Se in un quartiere entra gente nuova, c’è sempre qualcuno che se n’è dovuto andare; i quartieri migliorano, sì, ma non per i vecchi abitanti, che sono spinti in periferia, dove magari hanno case più salubri, ma perdono lo spazio, le reti di relazioni, il privilegio di vivere in centro.
Chi studia la gentrification, anche nei casi migliori (come nel libro Evicted from Eternity di Michael Herzfeld sul quartiere Monti a Roma), tende a concentrarsi su quelli che sono rimasti, non su quelli che sono andati via. Ripescare chi da Monti è dovuto andare a vivere nel “serpentone” di Corviale, o in borgata, è molto difficile, e spesso è ancora più difficile fare le domande giuste per capire veramente com’è stato quel passaggio, e che conseguenze ha avuto.
In Italia le tesi giustificazioniste emergono dove meno lo si aspetta. Un’intervista di qualche anno fa alle attiviste romane di Tuba Bazar al Pigneto si concludeva proprio con una tesi giustificazionista sulla gentrification del quartiere, ora capoluogo della classe creativa, attraversato da costanti conflitti in cui razzismo e classismo si confondono. Anche nel recente libro su Torpignattara di Giuliano Santoro, Al palo della morte, la gentrificazione del quartiere fa da sfondo a una realtà di conflitto e tensione tra gruppi di abitanti, ma dove non è chiaro quale parte essa abbia avuto: quella di esacerbare i problemi, o di portare nuove arie in un luogo infame?
A partire dal libro di Semi, possiamo dire che il fenomeno in Italia esiste, ed è riconosciuto: è già molto. Ora si tratta però di riscattarlo dall’ambivalenza che avvolge tutti i discorsi che lo riguardano. Per quanto siano interessanti anche le posizioni che ammettono che la “scoperta” (o conquista?) di territori isolati da parte di giovani che vogliono recuperare una dimensione di quartiere porta giovamento anche agli abitanti locali – forse proprio Torpignattara a Roma è un caso di questo tipo – credo però che ci sia una chiave di volta di tutta la questione.
Il punto è questo: quando cerchiamo di capire come si passa da un quartiere degradato a un quartiere gentrificato, ci stiamo interessando solo alla seconda parte di un fenomeno. La domanda più importante è quella che non si pone: perché questi quartieri erano degradati? Come è avvenuto questo degrado? Decenni di film e serie americane ci hanno portato a considerare il Bronx degli anni Ottanta come un luogo invivibile per natura, di fronte al quale il recupero degli anni successivi non può che assumere un carattere positivo. Rivendicare il Bronx malfamato e pericoloso è follia, e per quanto possa sembrarci poco avventuroso trovare negozi biologici dove prima c’erano fabbriche abbandonate e inseguimenti della polizia, si tratta in fondo di una questione di costume. Nel suo libro Giovanni Semi insiste sul proliferare del tofu, del biologico; sulle abitudini di consumo degli abitanti tradizionali contrapposte a quelle dei gentrificatori – i “bevitori di succhi di frutta”, come li definiva George Orwell. Su questo aspetto lavorano quasi tutti gli studiosi: è più facile studiare un quartiere gentrificato in cui i ricchi vanno a vivere, che un quartiere pericoloso da cui anche i poveri fuggono.
Ma ci sono molti lavori, meno conosciuti, che studiano anche la prima parte della gentrificazione: quella che porta allo stato di abbandono su cui la gentrification basa la sua legittimità. Se non si capisce questa prima parte, o la si naturalizza, considerandola un fenomeno spontaneo o incontrollabile, è molto facile giustificare la seconda. In un paio di note del libro di Semi si citano due fenomeni importantissimi, a cui bisognerebbe dare più risalto. Uno è il redlining, che in America ora è proibito: la pratica degli istituti di credito di bloccare i finanziamenti per la ristrutturazione di immobili in alcune zone specifiche della città, segnate con un’immaginaria linea rossa sulla mappa, e quindi condannate a deperire (p. 191, nota 5). Invariabilmente queste aree, una volta toccato il punto più basso della rendita immobiliare, entrano nel processo di messa in valore, cioè di speculazione, magari per mano delle stesse banche che ne hanno promosso il declino. Un secondo fenomeno è il blockbusting: in alcune zone di cui si prevede una riqualificazione, le autorità lasciano entrare e operare indisturbata gente malvista o pericolosa (p. 159, nota 8). A Barcellona succedeva con i gitani dell’est, che erano cacciati dovunque si fermavano, tranne che in zone come Poblenou e Santa Caterina, dove lo spaccio e il piccolo crimine venivano evidentemente tollerati dalla polizia. Gli abitanti si sentivano assediati, privi di protezione, in pericolo; dopo qualche anno, pur di andare via da quartieri che non riconoscevano più, finivano per accettare le condizioni di trasferimento sfavorevoli offerte loro dagli speculatori immobiliari.
Ci sono anche casi più eclatanti. I concetti di planned shrinkage e di benign neglect sono piuttosto usati negli Stati Uniti, ma è difficile trovare parole equivalenti in italiano. Nel libro A Plague on Your Houses di Deborah e Rodrick Wallace (New York, 1998) si spiega come, all’inizio degli anni Settanta, le autorità municipali di New York incaricarono un rapporto che dimostrasse che, grazie all’introduzione di un nuovo tipo di allarme antincendio, sarebbe stato possibile ridurre considerevolmente (to shrink) le dotazioni dei vigili del fuoco del South Bronx. Il rapporto, affidato a un ente privato, era basato su dati sbagliati o falsi, ed evidentemente finalizzato a legittimare una decisione già presa: entro il 1975 quasi la metà delle caserme dei pompieri del Bronx chiusero o ridussero il personale, provocando una vera e propria epidemia di incendi. I palazzi bruciati furono occupati da spacciatori o malavitosi e la popolazione traslocava verso i quartieri vicini. In alcune aree questo processo provocò una perdita di popolazione fino all’ottanta per cento, e un affollamento altrettanto dannoso nelle zone contigue. Così il Bronx divenne la zona malsana e pericolosa dei telefilm, pronta ad accogliere a braccia aperte la gentrification.
Oggi è facile confrontare l’enorme miglioramento che ha sperimentato il Bronx, con l’abbandono e la devastazione – urbana, sanitaria, morale – di venti o trenta anni prima. L’incuria “benigna” delle autorità rispetto ad alcuni servizi fondamentali, come la protezione dagli incendi, ha stimolato l’allontanamento della popolazione preesistente, che aveva un potere d’acquisto più basso. Dopo lo svuotamento dell’area, i nuovi venuti, a quartiere “risanato”, erano molto più ricchi: l’intera operazione ha fatto aumentare la base di tassazione, e quindi gli introiti per le casse comunali; ma questo guadagno è solo lontanamente paragonabile agli immensi profitti realizzati dai privati, soprattutto quelli che sapevano che era in corso il planned shrinkage. Dare la responsabilità al “mercato” per ogni processo di trasformazione della città nasconde il ruolo fondamentale che vi giocano amministratori e pianificatori – a volte agendo direttamente, a volte evitando di agire quando sarebbe loro compito farlo.
E in Italia? Il libro di Semi racconta dei casi di palese gentrification a Genova, Torino, Milano, Roma. Si ha l’impressione che, anche una volta smentite le tesi negazioniste, rimanga una certa ambivalenza: tutto sembra più confuso nel nostro paese, le strategie di lungo periodo sembrano irrealizzabili (una classica mistificazione: l’eccezionalismo italiano). Ma anche se l’abbandono delle zone in via di gentrificazione in Italia non potesse attribuirsi a un’intenzionalità chiara come nel Bronx, non dobbiamo sottovalutare il ruolo della pianificazione urbanistica. Nei quartieri di Roma est che hanno subito o stanno subendo la gentrification – dal Pigneto di cui parla Semi, alla Certosa, lì vicino, passando per Torpignattara, che ne è la frontiera, fino alle future colonie di Centocelle e Quadraro – fin dagli anni Settanta il comune ha condotto “sbaraccamenti” di decine di migliaia di persone, trasferendole in estrema periferia, lontane anche quaranta chilometri dai loro quartieri. Se per molti questo processo è stato il coronamento di una lunga “lotta per la casa”, per altri ha rappresentato un trauma da cui ancora non si sono ripresi, che ha spezzato relazioni, processi, dinamiche di adattamento già faticose in sé.
Quale impatto abbia avuto questo trasferimento forzato dai quartieri che poi vedranno arrivare i bevitori di succhi di frutta, come sia avvenuto nel dettaglio, come si siano trasformati quegli spazi, sono fatti che vanno studiati con attenzione. Quel che è certo è che non si può attribuire lo svuotamento dei centri storici solo a tendenze demografiche, o a processi fisiologici su grande scala (p. 142). A Roma migliaia di persone ricordano perfettamente il momento in cui le scavatrici del comune vennero a buttar giù le case costruite dai loro genitori e nonni, offrendo in cambio appartamenti non finiti in mezzo al nulla, a Nuova Ostia o Spinaceto. Le zone dove vivevano sono salite di prezzo esponenzialmente; magari sulle macerie delle loro case sono stati costruiti parchi pubblici, che oggi, per chi vi abita, sono “polmoni verdi” che hanno trasformato quelle zone un tempo infami in quartieri “bene” (per esempio, l’Acquedotto Felice e l’Appio Claudio).
Se riuscissimo a completare l’opera iniziata da Giovanni Semi, a difendere la parola gentrification senza chiedere il permesso prima di usarla, ma allo stesso tempo allargandone lo spettro temporale, legandola decisamente alle espulsioni, agli sfratti e alla produzione attiva del malessere che la legittima, avremmo fatto un bel passo avanti per decodificare le trasformazioni delle nostre città. (stefano portelli)





1 Comment