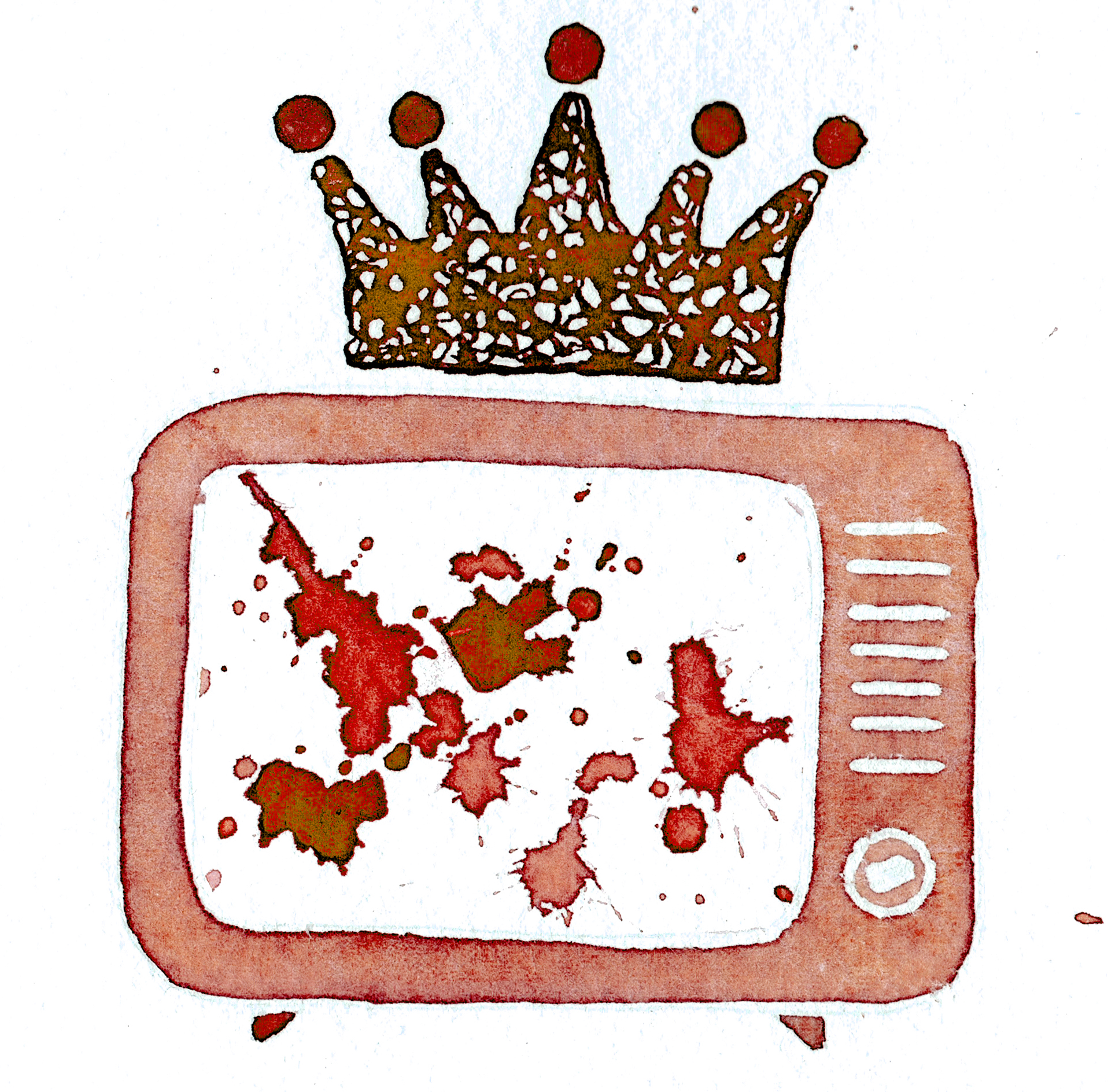
L’oppressione materiale era svanita: il classismo era diventato
lo sguardo culturale del piccolo borghese sul proletario.
La differenza tra la piccola borghesia di sinistra e quella di destra
era ridotta alla coscienza di tale sguardo.
(Mimmo Cangiano)
Ed è parte di grand’intelligenza che si dia a veder
di non vedere, quando più si vede, già che così ‘l giuoco è
con occhi che paiono chiusi e stanno in se stessi aperti.
(Torquato Accetto)
The quality of nothing
hath not such need to hide
it be nothing, I shall not
(Shakespeare, King Lear)
Nell’autunno 2015 va in onda negli USA la diciannovesima stagione di South Park, che segna un decisivo scarto con le precedenti – sia per i temi che per la modalità impiegata nel trattarli (non più episodi autoconclusivi ma un principio seriale). Un nuovo preside (Principal PC) si insedia nella scuola elementare dove si svolgono le vicende, pretendendo di cambiare le abitudini comunicative di una società (quella di South Park) reputata arretrata, offensiva e intollerante. Per lo spettatore è chiaro che l’accusa mossa dal personaggio PC si rifletta sulla serie stessa, proverbialmente scorretta, e in cui uno degli unici personaggi afferenti a qualche minoranza, in questo caso quella nera, è chiamato indicativamente Token.
PC è appena uscito dal college, il luogo di irradiazione della nuova cultura woke, che in South Park si confonde con quella delle confraternite universitarie (i PC sono costretti, verso il finale della stagione, a una sessione di autocoscienza per capire se hanno sposato idee di tolleranza solo “to crush pussy”). Garrison, il maestro di quarta, entra subito in conflitto con il preside, decidendo di licenziarsi e intraprendere quasi per caso una picaresca carriera politica basata sull’odio e la xenofobia (riferimento non troppo velato: nella stagione successiva Garrison si trasformerà anche fisicamente in Trump). I media nazionali (Jimmy Fellon) iniziano così a prendere di mira South Park, che, a causa di Garrison, diventa una sorta di epitome dell’anti-progressismo.
L’unico modo per rivalutare l’immagine della città è quello di riuscire ad aprire un Whole Foods (catena di supermercati che vende solo prodotti biologici di origine controllata – dal 2017 è proprietà di Amazon). Ma il capitalismo etico e sostenibile è restio ad associarsi a South Park, e richiede un alto prezzo: la gentrificazione. Il quartiere più malfamato della città, per offrire una giusta cornice al supermercato, si trasforma in una zona di lusso piena di residence, locali e ristoranti. La narrazione a questo punto si concentra sulla nuova morfologia esperienziale della città: tra ristoratori ricattati da critici dilettanti su Ielp, campagne umanitarie all’insegna del virtue signaling, articoli sponsorizzati, senzatetto che vengono esclusi dallo spazio urbano, disabili puniti per essersi opposti all’infantilizzazione e alla reificazione imposta dal linguaggio inclusivo (e per questo accusati di aver introiettato i codici degli oppressori), algoritmi umani, ecc., la serie scorre fino agli ultimi due episodi, in cui i cittadini si rendono conto di non poter più abitare in una città diventata troppo costosa, e che tutti loro, PC compresi, sono vittime di una cospirazione ordita dal Capitale (la serie si conclude con il Whole Foods che prende vita e abbandona South Park).
Tra le numerose pubblicazioni dedicate negli ultimi anni ai nuovi codici culturali (gli stessi che, ormai dieci anni fa, venivano trattati da Parker e Stone, gli autori di South Park) ne affronterò due molto diverse tra loro. La regola del gioco di Raffaele Alberto Ventura (Einaudi, 2023) e Guerre culturali e neoliberismo di Mimmo Cangiano (nottetempo, 2024). Se il primo saggio affronta la questione da un punto di vista particolare, cioè descrivendo le dinamiche interne a un certo tipo di discorso, il secondo – poco interessato a passarsi tra le dita i grani di un’aneddotica potenzialmente infinita – interpreta la wokeness all’interno di una dimensione sistemica e dialettica. Partiamo da un assunto forse un po’ banale. Il politicamente corretto e il suo strumento espropriativo, la cancel culture, esistono – ma dipendono dal contesto e dalla situazione comunicativa. Nella cultura occidentale, e soprattutto in Italia (rimasta ai margini della modernizzazione e affetta da uno spaventoso provincialismo), convivono spazi più o meno regolati. Questi dipendono soprattutto da due fattori: la policy delle piattaforme e il capitale culturale. Due piccoli esempi. Il caso dell’epiteto razzista di Acerbi a Juan Jesus durante Inter-Napoli ha rimesso in primo piano il razzismo di un paese che non è mai sceso a patti con il suo passato coloniale. Per molti, la vicenda è servita solo ad avere il via libera per pronunciare la n-word senza subire conseguenze, usandola non come insulto ma come elemento probatorio, sdoganandola su radio, podcast e televisioni. Questo non è stato possibile per chi trasmetteva in diretta Facebook, come il giornalista Umberto Chiariello che, nel suo programma Un calcio alla radio, dopo il solito attacco alla demonizzazione della parola (“Ai miei tempi un gelato si chiamava così e nessuno ci vedeva niente di male. Volete farmi credere che Edoardo Vianello era razzista?”), ha ammesso di non poterla pronunciare solo perché l’algoritmo altrimenti avrebbe buttato giù il contenuto video.
Secondo. Cinque anni fa, quando coordinavo un seminario sulla poesia barocca durante il mio primo anno di dottorato in un’università del nord, un paio di studentesse di lingue mi fecero notare, in tono scherzoso, come il mio mancato uso del linguaggio inclusivo nelle mail di gruppo dimostrasse la mia appartenenza a un contesto socio-culturale, quello meridionale, percepito come arretrato e patriarcale (o potremmo dire: più povero). Del resto, poche settimane fa un amico d’infanzia, ricercatore in ingegneria informatica in Calabria, mi ha raccontato di essere stato preso in giro da colleghi e studenti di entrambi i sessi per avere usato l’asterisco in una chat collettiva su WhatsApp. A dimostrazione che un tratto che altrove appare prescrittivo, in un contesto simile ma leggermente slittato può risultare fuori fuoco.
LA REGOLA DEL GIOCO
Nella terziarizzazione endemica del tardo capitalismo post-fordista, dove ormai crescono in maniera esponenziale gli impiegati nel settore dei servizi, e i nuovi borghesi – quando non occupati nei meccanismi di produzione – sono diventati tutti artisti, curatori (ormai tutto si cura, non solo una mostra ma anche un profilo Airbnb), agenti, redattori, documentaristi, tecnici del suono, e un dottorato con borsa ormai non si nega a nessuno – tutto è comunicazione, reputazione, capitale simbolico. E da come si investe quel capitale può derivare un vantaggio materiale. Finanziarizzazione e aziendalizzazione sono processi che, come anticipato da numerosi teorici del neoliberismo già quasi un ventennio fa, toccano ormai ogni aspetto della nostra vita extralavorativa, dalle amicizie, al sesso, ai ristoranti che consigliamo. È necessario per il singolo azzerare il rischio d’impresa, e per farlo bisogna che si impadronisca dei codici culturali richiesti dal mercato (un mercato che ha assorbito le istanze delle soggettività oppresse risignificandole in nuovi strumenti di estrazione di plusvalore), codici che rispondono al nome di politicamente corretto. La regola del gioco si pone perciò come manuale per le nuove élite culturali del paese. Ventura non contesta lo status quo, anzi, lo trova inevitabile (anche se con lo spirito di un “curatore fallimentare”), e offre al lettore gli strumenti “per non sembrare uno sfigato” [sic] e per migliorare la propria posizione nel mondo del lavoro (sostanzialmente egli deve: dire il meno possibile, essere vago e inoffensivo, farsi piacere tutto per difendere se stesso).
Ventura non ignora le nuove disuguaglianze create dal disciplinamento delle corporation e delle aziende, a cui è necessario sottostare se si vuole avere un ruolo di rilievo nella società, il che non fa altro che aumentare il divario di classe – ma le trova inevitabili (si veda il prezioso Linguaggio inclusivo ed esclusione di classe di Brigitte Vasallo, uscito per Tamu nel 2023). Se non sei capace di adeguarti a quello che il mercato richiede – e questo succede, solitamente, se parti da una posizione svantaggiata socio-culturalmente –, peggio per te. La tua specie non ce l’ha fatta. Il politicamente corretto così inteso è ormai molto simile a una performance di classe.
Per Ventura ci troviamo in una situazione a tutti gli effetti distopica (tra censura introiettata, psicoreati, shitstorm, concorrenza tra vittime – in uno stato di guerra permanente tra poveri), perché il modello anomico della deregolamentazione morale affermatosi tra gli anni Sessanta e Settanta ha fallito. Questo modello però è in parte ancora in funzione, solo che è stato sussunto e regolato dal mercato, che si è fatto rizomatico, fluido, nomade (salvo poi tornare rigido e monologico quando le circostanze lo richiedono). Ritorno a una distinzione lacaniana a cui ho accennato in un articolo che in parte è un prologo a questo e che mutuo da un saggio di Giglioli su cui tornerò più avanti: quella tra il Discorso del Padrone (sostanzialmente il super-Io freudiano applicato alla società, con le sue ingiunzioni all’impegno, al sacrificio, al lavoro, in un universo dominato dalla proibizione) e il Discorso del Capitalista (godi, esprimiti, sii te stesso: un Es camuffato). Da un lato quindi un’etica calvinista (repressione), dall’altro una logica edonistica (in realtà anedonica) di eccitazione perenne (concessione). È perciò paradossale (ma solo apparentemente) che un disciplinamento di ritorno (volto, tra l’altro, a vedere come neutrali, quindi universali, il mercato e la competizione) trovi spazio all’interno del logos Capitalista così come è stato definito da Lacan. Un logos che incontra pieno sostegno nei social network, strumenti di autoespressione continua che potenzialmente autorizzano l’utente a dire tutto ciò che vuole sempre e dovunque a un pubblico vastissimo. L’illusoria promessa di un’espressione ubiqua e simultanea (più che una promessa, ancora, un’ingiunzione) si rivela presto falsa, o meglio, richiede il raffinamento di un disciplinamento che tende a normare espressioni e comportamenti. E qui non mi riferisco tanto alle policy di Meta o di TikTok, ma a ciò che è accettato o meno da una data comunità, e da cui dipende il valore reputazionale del singolo. Se l’esibizionismo, il narcisismo e l’anomia sono il recto, il verso è rappresentato dal controllo e dal moralismo. Il paradigma espressivista (uso la terminologia di Radici dell’Io di Charles Taylor) e quello censorio convivono sotto lo stesso tetto. Noi li attraversiamo entrambi, sempre più scissi e confusi, addormentati e violenti, mentre il nostro potere di spesa diminuisce ogni giorno.
GUERRE CULTURALI E NEOLIBERISMO
Se La regola del gioco è un breviario normativo per attrezzarsi e non rimanere indietro nella guerra di tutti contri tutti, una serie di prudenti indicazioni capaci di integrare chi le segue nel sistema che lo sfrutta e lo aliena, un’ode alle soft skills diffuse, il saggio di Mimmo Cangiano, Guerre culturali e neoliberismo, è un’opera di rigorosa critica materialista, che tenta di interpretare gli stessi fenomeni descritti da Ventura all’interno di una cornice dialettica, cioè come sintomi, come manifestazioni di elementi strutturali rimasti latenti (talmente visibili da apparire invisibili). Secondo Cangiano il motivo per cui una serie di pratiche oppositive e antagonistiche (e di posizioni epistemiche che hanno monopolizzato i college americani, tutte genealogicamente riconducibili al post-strutturalismo francese) ha finito per essere neutralizzata e assorbita dal mercato è dovuto allo scarso peso che si è dato alle condizioni materiali e al funzionamento dell’economia, allo strabismo tra oppressione e sfruttamento, struttura e sovrastruttura. Ricondurre il monismo delle identity politics (“balcanizzazione” è uno dei termini più usati da Cangiano, con riferimento al proliferare dei particolarismi e delle alleanze identitarie dei gruppi oppressi) verso un orizzonte di senso comune, e un nemico comune (i metodi di estrazione del plusvalore), attraverso il concetto procedurale e continuamente negoziato di classe (un concetto contro-identitario) è l’obiettivo massimalista del libro.
Se la wokeness si è affermata come una postura riformista incapace di intaccare i modi di funzionamento della società corrente – anzi finendo per neutralizzarli dandoli per scontato –, ciò dipende dall’attitudine culturalista del nuovo progressismo, secondo cui la politica è diventata pedagogia – nella convinzione che il cambiamento sia un discorso di educazione (e quindi, personale: se sarai sensibile ai temi del razzismo il razzismo scomparirà). Come già notava Giglioli in Critica della vittima (nottetempo, 2014), nonostante il retroterra filosofico di questi posizionamenti abbia demineralizzato il concetto di soggetto, ritenendolo il luogo in cui si consolidavano i meccanismi escludenti e oppressivi del potere, esso (il soggetto) ritrova la sua preminenza nelle identity politics, circonfuso dal balsamo vittimario, con la conseguente paralisi dell’azione reattiva del singolo, e quindi della sua capacità politica, la cui mozione risarcitoria si limiterà il più delle volte al campo del simbolico, alimentando uno stato di concorrenza e competizione che di fatto salda i processi di sfruttamento e perpetua le disuguaglianze.
Una lotta che privatizza la politica e depoliticizza l’economia, non riconoscendo la collaborazione tra il piano materiale e quello immateriale – che è un suo sintomo – finisce per essere ben vista dalle tecniche aziendali del profitto, che ne mutueranno, con intenti diversi (un solo intento: accumulare quanto più capitale possibile ottimizzando i costi), strategie e richieste. Si può parlare di “Risarcimento neoliberista” o di “Dipartimento Risorse Umane del capitale”.
Cangiano è consapevole che i Cultural Studies alla base del pensiero woke hanno quasi sempre avuto una matrice anticapitalista, ma essi si sono fermati a una sola delle molteplici manifestazioni ideologiche che il capitalismo è strategicamente capace di abbracciare – ossia a quella, potremmo dire, legata al Discorso del Padrone: sessista, razzista, monologica, universalista, formale; il potere come dispositivo concentrazionario – fallendo nel riconoscere l’altro versante, quello più viscoso, inerente al Discorso del Capitalista (molteplice, nomade, rizomatico, espressivista, inclusivo, deregolamentato, non prescrittivo, flessibile, informale).
Quando la wokeness si astrae dal piano storico della prassi si situa in una dimensione passiva rispetto alle ideologie dominanti, dove la richiesta di maggiore riconoscimento e inclusività si sostanzia come perfetto sintomo di quel realismo capitalista su cui ha insistito Fisher (nessuna trasformazione dei modi di produzione è possibile, possiamo solo negoziare i nostri livelli di comfort personale, i quali sintomaticamente aumentano in parallelo alla riduzione dei salari, l’aumento delle ore di lavoro e il peggioramento delle sue condizioni – mai così dure forse dal XIX secolo –, la crisi abitativa e una generale erosione del welfare e dei servizi, ormai trasformati in privilegi, tutt’altro che simbolici, percepibili solo a certi livelli di censo).
Una delle conseguenze dello stato di cose attuale è che gli aggregati politici formati su tali basi non seguono più una logica sociale, ma etico-ideologica. Il posizionamento politico non dipende più cioè dal ruolo del singolo nel meccanismo produttivo della società, ma dalla sua Lebensform (forma di vita), dallo sposare le idee giuste e dalla tipologia dei suoi consumi.
Secondo Cangiano il passaggio dalla lotta all’oppressione a quella allo sfruttamento può attuarsi unicamente mediante il recupero del concetto di classe (spostando il focus dall’ontologia – ciò che sei – alla pragmatica – ciò che fai), un concetto per sua natura relazionale (poiché nasce da una negoziazione con la struttura, ossia dai diversi modi di relazione con la sfera della produzione e del mercato – influenzati, senza ombra di dubbio, da questioni di genere, razza, ecc.). Lungi da essere l’ennesima identità-vittima, la classe è un luogo del fare operativo e strategico che permette di recuperare le guerre culturali in un orizzonte davvero trasformativo e non più correttivo-attenuativo.
CONCLUSIONE
In questo spazio mi sono soffermato sul politicamente corretto inteso come una partizione del dicibile e del pensabile, una sorta di compromesso tra le legittime rivendicazioni di gruppi oppressi e la capacità adattiva del nuovo capitalismo. Uno strumento compensativo che lascia i rapporti di forza immutati in cambio di un risarcimento simbolico che, nei casi deteriori, può apparire come una mercificazione disciplinante della coscienza (sia chiaro: ciò non toglie che contemporaneamente da destra arrivi, lo stiamo vedendo in questi mesi, una mozione censoria vecchio stampo). Per Ventura la situazione è compromessa, e non resta che equipaggiarsi per non rimanere esclusi dalla corsa al capitale simbolico richiesto per un buon posizionamento in società, per non essere considerati degli “sfigati” (o peggio, come gli abitanti di South Park, dei louts, degli zotici), guardati con il solito misto di disprezzo ed esotismo. Cangiano vede invece il fenomeno della wokeness come un ennesimo segno del culturalismo imperante e di un essenzialismo di ritorno, e rivendica la necessità di un aggancio con la sfera economica. Mentre il pianeta su cui viviamo sta diventando troppo caldo e troppo caro per la nostra specie, rimane da capire (ed è quello che più interessa chi, come me, si occupa di letteratura) come questo plesso di tendenze correttive influisca su quello che si scrive e si pubblica, se stiamo assistendo, cioè, anche a una nuova – e forse più pericolosa – partizione del sensibile. (fabrizio maria spinelli)





Leave a Reply