
Il 16 febbraio 2024 il consiglio comunale di Milano ha approvato il quarto Piano annuale dei servizi abitativi. Si tratta di uno dei principali strumenti, insieme al Piano triennale, di programmazione delle politiche abitative previsto dalla disciplina regionale lombarda. Mentre il Piano triennale definisce le strategie e gli indirizzi, integrandosi il più possibile con le politiche sociali, dell’istruzione e del lavoro, quello annuale ha il compito di aggiornarlo e rendere conto del suo stato di attuazione. Al suo interno si trovano informazioni sulla consistenza del patrimonio immobiliare di proprietà pubblica o privata destinato all’edilizia residenziale pubblica e a quella sociale (housing sociale); le unità abitative che il Comune prevede di assegnare nel corso dell’anno; le quote da destinare alle persone in condizione di povertà assoluta e all’emergenza abitativa; le misure per sostenere l’accesso e il mantenimento dell’abitazione in locazione (fondo sociale affitto, fondo morosità incolpevole, ecc.) e le unità abitative assegnate nell’anno precedente.
Gli elementi interessanti di questo recente strumento di programmazione riguardano la centralità assegnata ai territori e l’assicurazione di una maggiore trasparenza sulla disponibilità del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Una nuova disciplina che invita le amministrazioni a trattare la questione abitativa in modo articolato, a rendere pubblici i dati e le strategie intraprese.
Tuttavia, come è stato notato, gli esiti che questa nuova disciplina sta producendo sono ancora molto deboli e incerti. L’elemento che emerge con più evidenza è il fatto che a determinate responsabilità non vengono corrisposte adeguate risorse. È una delega di responsabilità che lascia quindi a ciascun territorio anche il compito, non esplicitato nella normativa, di trovare le risorse necessarie per adempiere alle attività programmate.
Il passaggio di competenze dalla Regione a consorzi di comuni, così com’era accaduto in passato quando lo Stato aveva ceduto alle regioni la competenza esclusiva in materia di politiche abitative (vedi Riforma del Titolo V della Costituzione), è avvenuto, anche in questo caso, senza un adeguato trasferimento di risorse. Si sono delegate competenze importanti senza mettere nelle condizioni i comuni di esercitare pienamente le loro nuove responsabilità. D’altra parte, dalla chiusura dei fondi ex Gescal avvenuta alla fine degli anni Novanta non sono state più stanziate risorse strutturali per le politiche abitative. Attualmente le risorse a cui possono fare riferimento i comuni sono quelle una tantum legate al fondo sociale affitto o al fondo morosità incolpevole che nell’ultima legge di bilancio, per l’appunto, non sono stati rifinanziati, oppure i finanziamenti subordinati alla partecipazione ai programmi di iniziativa statale (vedi Pnrr) o regionale (in rarissimi casi, con risorse proprie e, sempre più frequentemente, con risorse della comunità europea, per esempio Por Fse e Por Fesr). Un’attività di programmazione che chiede ai comuni alcune capacità (implicite, come si diceva) come per esempio saper progettare, partecipare a bandi, co-finanziare programmi, coordinare gli eventuali progetti finanziati all’interno di una strategia locale.
Un secondo elemento è il fatto che il livello locale ha poca possibilità di incidere se pensiamo che i principali problemi di accesso alla casa dipendono da un mercato del lavoro contraddistinto da salari medi in diminuzione e da un mercato dell’affitto che continua a registrare un incremento dei prezzi. Due settori la cui regolamentazione non dipende dal livello locale ma da quello nazionale, europeo se non mondiale.
Una devoluzione delle politiche quindi che rischia di tradursi come mero tentativo di scaricare le difficoltà di gestione dei problemi abitativi ai livelli più bassi. E lì troviamo gli operatori dei servizi sociali comunali e territoriali. “Sotto”, in teoria, non c’è più nessuno, a meno che tale livello non sia in grado, come a volte succede, di delegare, per esempio a realtà del terzo settore. È comunque a questo livello che viene data la responsabilità, anche dalla politica locale, di gestire le crescenti situazioni di emergenza abitativa con risorse sempre più scarse. Il risultato lo abbiamo raccontato qui. In questo contesto, per poter gestire una domanda così elevata, si mettono in atto dispositivi difensivi volti a selezionare accuratamente i destinatari (non tutti coloro che hanno bisogno hanno diritto a una risposta), respingere, allontanare e far desistere le persone, che il servizio sociale è obbligato a prendere in carico (quelle con fragilità: anziani, minori e persone con disabilità), dal richiedere un supporto pubblico.
In questo quadro il Piano annuale dei servizi abitativi del comune di Milano non può che apparire come un mero adempimento farcito di buoni propositi. Nello specifico, i dati, lo dicono anche le parti sociali che hanno analizzato gli ultimi tre piani annuali del Comune, sono rimasti costanti o addirittura peggiorati (più domande e meno case disponibili). Un nulla di fatto in termini di modificazioni sostanziali delle politiche e soprattutto dei benefici che sono state in grado di produrre.
È necessario dare più tempo a questi processi per misurare cambiamenti apprezzabili? Può darsi, ma la situazione ci parla di un’incapacità cronicizzata di rispondere alla domanda abitativa e di un peso ridotto del problema casa nelle politiche pubbliche. Un’incapacità strutturale aggravata dalla scelta del livello locale di non considerare l’allocazione delle risorse in relazione alla diversa gravità e urgenza delle situazioni di deprivazione. Un approccio che tratta tutte le situazioni (dal grave disagio abitativo al rischio abitativo) in modo equidistante non considerando l’importanza di riconoscere un ordine di priorità.
Quindi per risolvere i problemi che abbiamo di fronte bastano delle risorse in più e la disponibilità di un numero maggiore di case? Pur riconoscendo una importanza fondamentale a questi due fattori forse si dovrebbe osare di più, prendendosi dello spazio di riflessione e azione che provi a uscire dalle maglie strette entro cui siamo portati a ragionare (la casa come diritto, più case accessibili, più stato e meno mercato).
Quello che abbiamo appreso dal passato è che, se a mutare non sono i paradigmi alla base delle politiche abitative, il problema rischia di non essere risolto. Tant’è che anche quando le politiche hanno potuto beneficiare di risorse consistenti non sono state in grado risolvere il problema, soprattutto quello dei più poveri.
Non si vuole per questo negare la necessità di un incremento di un’offerta accessibile, potenziando la casa pubblica in affitto, rafforzando il regime dell’affitto, finanziando un fondo sociale affitto che copra le situazioni di grande rischio abitativo. Si ritiene però che l’investimento da fare sulle politiche debba aggredire anche i paradigmi di fondo. Quali elementi allora può valere la pena rimettere in discussione? Senza pretesa di esaustività se ne richiamano alcuni tra quelli più rilevanti sui quali iniziare una riflessione già aperta da Antonio Tosi in alcuni suoi scritti.
Il primo è la riduzione del tema casa a una questione di fabbisogno abitativo, intesa come stima della domanda insoddisfatta dall’offerta abitativa attuale. Le domande sono: possono davvero le situazioni abitative di singoli individui o nuclei familiari essere rappresentati da alcuni semplici indicatori? Questi indicatori sono in grado di rappresentare tutte le situazioni di bisogno? Soprattutto, quali riteniamo possano essere le risposte in relazione a tali informazioni? Rispetto alla domanda che viene rappresentata nel Piano annuale del comune di Milano si rilevano alcuni limiti. Il primo riguarda la scelta dei bisogni da inserire nel piano. Chi ha una conoscenza dei bisogni abitativi più legata a ciò che accade sul territorio e meno fondata sui dati forniti dalle fonti statistiche ufficiali, rileva che dentro quel piano non sono rappresentati quei lavoratori con percorsi migratori alle spalle costretti a vivere in condizioni di sovraffollamento o precarietà abitativa, o quei nuclei familiari che rischiano di perdere un’abitazione perché in corso di espulsione dal libero mercato, oppure quelle famiglie che sono in centri di accoglienza o strutture temporanee, oppure i senza fissa dimora o le persone che vivono nei campi autorizzati o non. Significa che quei bisogni non esistono? Significa che non sono le politiche abitative a doversene occupare?
Il secondo limite riguarda cosa è stato osservato. Così come non sono osservate alcune situazioni di disagio, non sono al contempo riconosciute le risorse, le potenzialità, le leve che queste diverse soggettività possiedono per risolvere la loro condizione. A cosa servono dunque le informazioni nel Piano e che importanza assumono? A queste informazioni fredde e che privano di vita l’esistenza umana è necessario associare degli strumenti e spazi/occasioni di conoscenza che consentano di individuare i passaggi più appropriati per consentire alla persona di ritrovare la sua strada, il suo equilibrio. Non è sempre detto che la soluzione stia nella fornitura di un tetto sopra la testa.
Un altro aspetto della questione attiene al cosiddetto “trattamento amministrativo dei bisogni”, cioè a quell’approccio per cui a ogni bisogno può essere fatto corrispondere un servizio, un oggetto, un manufatto. Perdendo interesse e attenzione per l’ascolto e la lettura dei bisogni nella loro diversità, la risposta diventa un problema di matching, di accoppiamento tra tipologia della popolazione e tipologia delle soluzioni abitative (alle famiglie numerose i quadrilocali, a quelle monofamiliari i monolocali, alle madri coi figli le comunità alloggio o i co-housing, ai disabili le residenze per disabili, agli anziani quelle per anziani, agli adulti privi di mezzi ma autosufficienti i dormitori). È il tema degli standard abitativi, che hanno prodotto nel tempo sicuramente un generale miglioramento delle condizioni abitative, ma siamo sicuri che la questione delle tipologie sia sufficiente per stabilire delle condizioni di buon abitare? Qual è il loro effettivo valore abitativo per le singole persone che lo praticano?
Un terzo aspetto del paradigma, strettamente connesso a quest’ultimo, attiene all’appropriatezza delle risposte. Nel preoccuparsi della questione abitativa lo Stato, oltre a istituire e strutturare un mercato, si è fatto, in passato, produttore diretto di case con una visione quantitativa, specializzata e centralistica della produzione. Le sue principali preoccupazioni erano di tipo igienico-sanitario e sociali. Le condizioni abitative erano viste come componente fondamentale per la salute degli individui e delle famiglie, ma anche una base per il mantenimento dell’ordine sociale (di fronte alla sperimentata pericolosità delle concentrazioni operaie), un fattore essenziale dei processi di sviluppo economico. In questo contesto si è fatta posto una concezione specializzata dell’abitare che ha misconosciuto le competenze degli abitanti a favore, per l’appunto, di competenze specializzate, offerte da esperti e professionisti. La casa da esperienza globale e complessa è stata trasformata in funzione specifica, iscritta in uno spazio delimitato: come luogo della riproduzione e del consumo non può più inglobare le molteplici funzioni che caratterizzavano le società pre-moderne/tradizionali. Questa visione massificante e quantitativa non è mutata nel tempo (anche se sono numerosi i casi di pratiche abitative irriducibili a quel modello) e ha prodotto, tra le altre cose, un progressivo scollamento tra le forme abitative e i territori, le condizioni ambientali, le risorse locali, l’assetto produttivo, l’organizzazione sociale, i modi di vita e le concezioni culturali dei diversi contesti. È possibile recuperare dei saperi locali, un’ecologia locale, nella realizzazione di nuove risposte alla domanda abitativa?
Un quarto aspetto riguarda il ruolo giocato dall’abitante. Nel contesto in cui ci troviamo la relazione diretta abitanti-produttori di case viene meno a favore di competenze e apparati specializzati. Il progressivo allontanamento tra la figura dell’abitante, del costruttore, del progettista mette l’abitante sempre di più nelle condizioni di essere destinatario, obiettivo di politiche o di un mercato, e non protagonista, attore. Le sue competenze non sono riconosciute e non rappresentano un valore bensì un ostacolo. Molto spesso lo Stato ostacola e reprime la libera iniziativa degli abitanti nei diversi tentativi di risolvere in modo autonomo, autorganizzato, autocostruito il proprio bisogno abitativo, anziché far leva sulle risorse attivate e messe in campo. Allo stesso tempo la presa in carico da parte dello Stato implica, in una prima fase, un processo di deresponsabilizzazione delle persone che sono obbligate a sottostare ai protocolli di intervento standardizzati definiti dai servizi e, in una seconda fase, che scatta in un momento predefinito nel protocollo, un processo di espulsione dal sistema di supporto pubblico nel nome dell’emancipazione, della responsabilizzazione del destinatario, anche se le condizioni, rispetto al punto di partenza, non sono mutate. Il riconoscimento del potere di autodeterminazione all’abitante, non può e non deve tradursi, come spesso accade in modo riduzionistico, come forma di risparmio ma deve essere sostenuta con mezzi e risorse affinché possa esprimersi.
Lo sforzo operato verso un ripensamento delle ideologie e dei paradigmi che stanno alla base delle politiche abitative potrebbe offrirci l’occasione per riscoprire, insieme, che cosa significa ridare valore all’esistenza umana e individuale, di ricomprendere e nel caso ridefinire, con questa nuova priorità, il senso e il significato dei sistemi e delle istituzioni entro cui ci troviamo ad agire e abitare. Occorre rimettere al centro di un nuovo paradigma le persone, l’unicità della loro esistenza, riconoscendone diversità, libertà e competenze e capire quali pratiche, concrete, possono favorire questa transizione. È una richiesta scontata? Forse no, se pensiamo alla debolezza di alcune pratiche alternative a quelle proposte dallo Stato e dal mercato. Può essere un percorso risolutivo delle situazioni più gravi? Forse no, ma potrebbe portare alla creazione di precedenti importanti, all’individuazione di nuovi spazi di azione o forse solo a una maggiore consapevolezza e libertà del nostro agire come abitanti. (alice boni)


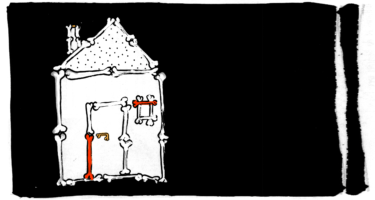
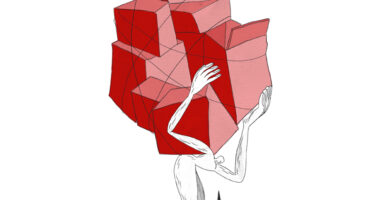

Leave a Reply