
«Cuori pazzi, i nostri». È così che Pino Daniele aveva commentato, ventuno anni fa, celando il dolore, la telefonata con cui un giornalista del Mattino gli annunciava la morte del suo amico fraterno Massimo. Esattamente come lui, questa notte, Daniele è morto quando a scoppiare è stato il cuore, quel cuore che lo ha logorato negli ultimi suoi anni di vita, non impedendogli tuttavia di continuare a fare musica, una attività continua che in un certo senso ricorda proprio quella di Troisi, il suo desiderio di lasciare qualcosa, tutto quanto possibile, prima che il tempo scada.
Prima che grande cantautore Pino Daniele è stato grande musicista. Ha duettato con i nomi più prestigiosi della musica internazionale, ha scritto e suonato il miglior blues, rock, funk, persino jazz degli ultimi quarant’anni, da quando il compagno di classe Peppe Lanzetta gli suggerì di lasciar perdere il ruolo di chitarrista durante le tournée di Bobby Solo («Con tutto il rispetto tu nun c’azzicche niente là…!») e il giovane session man andò a bussare alla porta degli ex Showmen Senese e Musella. Era l’epoca in cui i due (Daniele e Lanzetta) giravano in Renault 5 per i night del paese, l’epoca in cui ogni volta, nei pressi del casello di Caserta, il giovane musicista faceva finta di dormire per non pagare la sua quota.
Da allora Pino Daniele non si è mai fermato, fino a stanotte. A ventidue anni ha pubblicato Terra Mia, uno degli esordi più dirompenti della storia della musica leggera italiana, un disco che conteneva, una dietro l’altra, tracce come Napul’è, Na tazzulella ‘e cafè, Terra mia, Furtunato, Che calore.
C’è una vecchia puntata di Blitz (altro storico esordio, quello di Gianni Minà come autore e conduttore televisivo), dedicata a Napoli, durante la quale, uno alla volta, nel salotto del “secondo canale” si accomodano Troisi, Lello Arena, Senese e i Napoli Centrale, Lina Sastri, Salvatore Piscicelli, Ida Di Benedetto, Eduardo De Crescenzo. Una generazione che faticosamente, senza proclami ma attraverso musica, teatro e cinema, provava a demolire l’oleografia immobile di una città basso-imperiale e che in quel contesto televisivo veniva messa a confronto con un Benigni guitto e grottesco, che invece, provocatoriamente, sbatteva in faccia al gruppo tutto il peggior repertorio di cliché e luoghi comuni in salsa partenopea, fino a dedicare al grande malato metropolitano, duettando con De Crescenzo, una irresistibile ballata dal titolo: Napoli, cosa si può fare per te?.
Di quella generazione Daniele era uno degli esponenti più brillanti e apprezzati. I suoi testi erano militanti ma mai tromboneschi, testi che parlavano il giusto e sapevano fermarsi l’attimo prima di diventare ideologici, negli anni in cui l’ideologia veniva seppellita dopo i bagordi del ’77. Daniele, figlio dei quartieri popolari del centro città, cantava la terra sua da una prospettiva altra, quasi postcoloniale; svelava i travestiti e le donne Concetta del quartiere, parlava della pizza raccontando in un verso di dieci parole il dramma dell’eroina, il movimento dei disoccupati svenduto da partiti e sindacati, le grandi abbuffate di Tangentopoli e del nuovo sacco edilizio. Scriveva poesie civili e d’amore indifferentemente e con la stessa leggerezza. Lì, quando si fermavano le parole, entrava prepotentemente in scena la musica: creativa, potente, innovativa, nel solco di quella grande stagione che era stato il Neapolitan Power, che poi null’altro era se non il potere paradossale del ghetto nero (a metà) della città del sole.
Dalla musica era partito e alla musica era tornato, Pino, che come Eduardo e tutti i più grandi amava essere chiamato solo con il suo nome di battesimo, rimarcando che, in fondo, di Pino ne esisteva soltanto uno. I problemi al cuore, le operazioni, lo stress, i controlli lo avevano lentamente privato di quella ruvida forza vocale che era stata il timbro delle sue canzoni, ma non per questo aveva rinunciato a portarle in giro per il mondo, ritornando a riempire nel 2008, ventisette anni dopo il grande concerto voluto, si narra, da Maurizio Valenzi, la “sua” piazza Plebiscito. Negli ultimi quindici anni (dall’uscita nel ’98 di Yes I know my way, memorabile disco antologico con una fantastica copertina, che proponeva inediti come Amore senza fine e Senza peccato e i rifacimenti dei suoi più grandi successi), da vero artista Pino Daniele aveva acquisito la consapevolezza di non poter più permettersi certi lussi e certe note, ed era appunto tornato lì da dove era partito. Dal suono, dalle piazze, dalle vecchie band riunite una dopo l’altra come un vero blues brother in missione per conto di Dio. Uno dopo l’altro ha regalato una serie di concerti alla sua città, della quale pure aveva parlato di tanto in tanto un po’ a sproposito, forse per lontananza o per troppo amore. Ha ri-suonato con Senese, De Piscopo, Amoruso, Zurzolo, Esposito, Avitabile, Di Meola, Vitolo in session memorabili. Si è tolto degli sfizi che a qualcuno dei suoi fan dei quartieri alti e dalla bocca troppo buona per uno sporco blues-man non sono andati troppo a genio, come quelli di duettare con Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio (dopo averlo fatto con Clapton e Pat Metheny, De Gregori e la Mannoia, Giorgia e Irene Grandi, Gragnaniello, gli Almamegretta e i 99 Posse, e poi, anni dopo, pure Clementino e Rocco Hunt), dall’alto di una autorevolezza guadagnata in quarant’anni di carriera, e che ormai nessuno poteva più contestargli.
Quei concerti di fine anno erano diventata una tradizione, un evento con cui, ogni volta, Pino avrebbe voluto non far voltare pagina alla sua città, ma contribuire a farla andare avanti con sempre meno chiacchiere (e parole) ma attraverso ‘o rit’m, come lo chiama Enzo Avitabile, qualcosa che a quella generazione di artisti è rimasto nel sangue nonostante le baruffe, i litigi, le separazioni e i successivi ritrovamenti. L’ultimo di quei concerti, lo scorso dicembre, è stato anche il suo ultimo regalo a Napoli.
C’è un filmato, che si trova facilmente su internet, in cui una telecamera mantenuta probabilmente da Anna Favignano riprende Massimo Troisi che ascolta da un walkman, davanti a un Pino Daniele con la tipica criniera già brizzolata di quegli anni, per la prima volta una demo di Quando, futura colonna sonora di Pensavo fosse amore… invece era un calesse. Con le cuffie piantate in testa Troisi accenna a cantare qualche parola, stonandola irrimediabilmente, chiudendo poi con «No, non cambiamola. Questa è proprio stile Pino Daniele». Uno dei tanti, in realtà, di un grande artista che ha attraversato quarant’anni di musica napoletana, portandola nel mondo (ancora Benigni) parlando pure della pizza ma senza mai suonare il mandolino. (riccardo rosa)


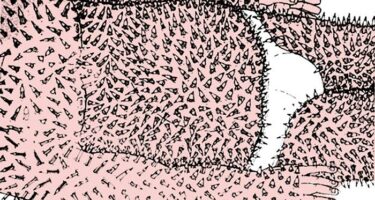


Leave a Reply