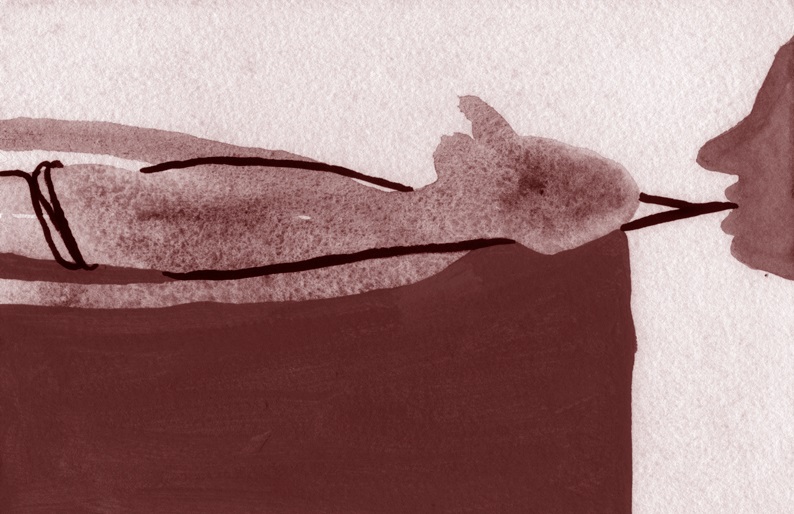
Lo sportello di supporto psicologico per i familiari dei detenuti, da cui prende le mosse anche questa rubrica, va allargandosi progressivamente. Non solo vi partecipano i familiari delle persone uccise dal carcere, ma anche i familiari dei detenuti che vivono un calvario all’interno del sistema penitenziario a causa di patologie non conciliabili con la detenzione, mancanza di cure fisiche e psicologiche. Vi sono inoltre ex detenuti che hanno vissuto l’oscurità delle celle e che condividono la propria storia.
Tutti sono benvenuti a partecipare, ogni contributo è importante. Le riunioni si svolgono ogni venerdì dalle 17:45 alle 20:00. Il link per accedere alla riunione settimanale viene pubblicato qualche giorno prima dell’incontro sul gruppo Telegram “Morire di carcere” e su quello Whatsapp “Sportello di supporto psicologico per i familiari dei detenuti” .
Adesioni e lettere possono essere inviati all’indirizzo e-mail dell’associazione Yairahia Ets (yairaiha@gmail.com). Avvocati, volontari, membri di associazioni, garanti delle persone private della libertà sono invitati a unirsi e a condividere il proprio punto di vista.
Quella che segue è la trascrizione di alcuni passaggi di una intervista alla moglie di Pasquale Condello, ex boss dell’Ndrangheta, noto come ‘U Supremu, attualmente detenuto al 41 bis nel carcere di Opera, con una condanna a quattro ergastoli e ventidue anni di reclusione. Quando era detenuto nel carcere di Parma, Condello ha cominciato a manifestare gravi forme di sofferenze psichiche, e a lamentare l’utilizzo di scosse elettromagnetiche come “terapia”. Progressivamente, una spirale di sofferenza lo travolge, trasportandolo in un regno indefinito in cui anche la sua famiglia resta intrappolata. Sua moglie e i suoi figli non hanno sue notizie da oltre tre anni. A causa delle sue patologie, Condello rifiuta tutte le cure per lui indispensabili. La data del suo fine pena è prevista per il 31/12/9999 distante 7975 anni, 797 secoli da oggi.
* * *
Sono la moglie di un detenuto ristretto dal 2008. Ǫuando mio marito è stato arrestato, non immaginavo l’abisso che si celava dietro le mura del 41 bis, un universo di isolamento estremo e di sofferenza umana. La mia fiducia nella giustizia è crollata quando ho visto mio marito con ematomi alla testa e lividi in faccia. Al 41 bis il peso della punizione supera ogni limite umano.
Incontrai per la prima volta Pasquale nel 1982. Io ero diplomata da non molto tempo, lui aveva trent’anni. Nonostante provenissi da una famiglia tranquilla, con genitori commercianti, la mia vita prese una svolta quando decisi di fidanzarmi con lui. Pasquale aveva due anni di pena da scontare, ma speravamo che potesse mettere da parte il suo passato e lavorare con suo fratello nel settore dei sanitari e delle ceramiche.
Purtroppo, appena sposati, mentre aspettavo la nostra prima figlia, venne arrestato per scontare questi anni di pena rimasti. Ma la tragedia ci travolse ancora di più quando scoppiò la guerra di mafia a Reggio Calabria (nell’ottobre del 1985 un’autobomba esplose a Villa San Giovanni per colpire Antonino Imerti e tre giorni dopo venne ucciso Paolo De Stefano): il 13 gennaio 1986 uccisero Domenico Francesco Condello, il fratello di Pasquale, sebbene fosse estraneo agli ambienti di mafia.
Da quel momento, la mia vita è stata segnata dalla sofferenza. La guerra portò morte e distruzione. Pasquale era in carcere, lontano dagli eventi ma comunque coinvolto indirettamente. Nel 1991, finalmente, la guerra ebbe fine, ma i segni indelebili rimasero nella nostra città. Molte madri, mogli e fratelli erano stati uccisi, tantissime persone avevano perso i propri cari. A quell’epoca piangevo spesso al pensiero che mio figlio maschio potesse un giorno essere ucciso o finire coinvolto in organizzazioni criminali. Ho cresciuto i miei tre figli da sola, con l’aiuto della mia famiglia, ringraziando Dio per il loro sostegno.
Oggi, dopo tanti anni, la situazione non è migliorata. Pasquale è ancora in isolamento in carcere, al 41 bis, mentre io e i nostri figli viviamo nell’incertezza e nella paura per il suo futuro. La speranza è che possa ricevere le cure di cui ha bisogno e che possiamo riunirci un giorno come famiglia.
Nel 2008, dopo una lunga latitanza, mio marito è stato arrestato e portato nel carcere di Parma, dove ha subito violenze e torture. Potevamo vederlo dietro un vetro, una volta al mese, senza mai poterlo abbracciare. Anche i nostri nipotini erano felici di vederlo, ma quando iniziò ad avere problemi psichiatrici, decidemmo di non portarli più a visita, per rispetto nei suoi confronti.
Nel 2012, Pasquale fu ricoverato per ematomi alla testa. Noi familiari venimmo a saperlo casualmente, non fummo informati in alcun modo dalla direzione del carcere. La sua salute mentale peggiorava, e questo ci riempiva di preoccupazione. La situazione era diventata insostenibile, ma non potevamo abbandonarlo. La nostra famiglia continuava a sperare in un cambiamento, nella possibilità di riunirci e di vederlo guarire.
Quando è stato ricoverato in ospedale non abbiamo potuto vederlo, non ci è stato permesso, solo l’avvocato era autorizzato. Dopo nove anni di detenzione a Parma è stato trasferito nel carcere di Novara. Eravamo speranzosi che fosse meglio per lui, che ci fossero meno episodi di violenza e privazioni personali, ma il primo colloquio è stato devastante. Fin dai primissimi incontri delirava, diceva cose che non aveva senso, aveva allucinazioni. La situazione è peggiorata durante il lockdown per l’epidemia di Covid-19. Non potevamo andare a visita, abbiamo potuto solo telefonare, dal carcere di Reggio Calabria.
A un certo punto ha smesso di voler parlare. Ha rifiutato i colloqui con noi, con l’avvocato, persino con i medici che volevamo mandare per visite. Dal febbraio 2021 non sappiamo nulla di lui, non lo vediamo, non riceviamo notizie. La sua condizione mi tormenta. Non so se viene curato, se si fa la barba, se ha i capelli lunghi, come si veste. Non mi manda più indumenti da anni, non so in che condizioni possa essere, e questo è un grande dolore per me.
Paradossalmente mi viene da pensare che quando andavamo a vederlo in carcere e facevamo i colloqui con i miei figli eravamo contenti, perché almeno lo vedevamo e quando stava bene lui parlava con loro, dando consigli e dicendogli parole che li facevano stare bene.
Non riesco a descrivere il mio dolore, oggi. Cerco di vivere la mia vita normalmente, lavoro come insegnante e cerco di metterlo da parte. Ma ho un chiodo nel cuore che mi devasta, ancor più pensando alle sofferenze dei miei figli.
Pasquale dovrebbe vivere la sua malattia agli arresti domiciliari, ma sappiamo che questa intenzione non c’è, a causa del suo cognome pesante. Noi vogliamo solo che venga assistito, che sia almeno messo in una struttura sanitaria e riceva le cure di cui ha bisogno, perché vogliamo tornare a vivere come una famiglia normale, poter fare colloqui e parlare con lui. Non possiamo abbandonare un malato nelle carceri, viviamo nell’angoscia di ricevere una brutta notizia da un momento all’altro […]
Io resto orgogliosa di come ho cresciuto i miei figli. Nonostante le difficoltà e il coinvolgimento passato del padre in situazioni criminali, sono tutti impegnati nel loro lavoro. Mi sono impegnata come mamma e come maestra, ma non ho ricevuto in cambio i miei diritti di madre, moglie e cittadina. (luna casarotti, yairaiha ets)
ALTRE PUNTATE
- La storia di Stefano Dal Corso
- Mustafa Fannane, ucciso dai Cpr
- Il suicidio di Fabio Romagnoli, sofferente psichico lasciato morire in carcere
- Carcere, lutto e sofferenza. Come l’istituzione abbandona i detenuti a loro stessi
- L’accanimento dell’istituzione carceraria sul corpo di Marco Leandro Bondavalli
- 41bis, presunzione di innocenza e sciopero della fame. La storia di Domenico Porcelli





Leave a Reply