
«Ca’, r’e ‘mericani ce putimm’ aspetta’ tutt’ cos’!», ricorda Nicola ai compagni e alle compagne con gli ombrelli aperti fuori ai cancelli. La pioggia si fa battente, ma il blocco umano all’ingresso dello stabilimento numero dodici rimane compatto. È il 27 aprile. Nicola, in piedi sotto il semaforo rosso che da undici giorni indica il blocco della produzione, è uno dei cinquanta operai rimasti a presidiare gli stabilimenti della Indesit Company di Carinaro, nell’area industriale di Aversa Nord, in provincia di Caserta. Altri seicento, all’alba, a bordo di dodici pullman, sono partiti con mogli e figli alla volta della capitale. L’appuntamento è alle dieci e trenta al ministero dello sviluppo economico, dove la multinazionale americana Whirlpool incontrerà i sindacati per discutere dei milletrecentocinquanta esuberi annunciati giovedì 16 aprile, di cui più di ottocento nel solo sito di Carinaro. Se a questi si aggiungono i lavoratori dell’indotto, a Carinaro i licenziamenti salirebbero a quota milletrecento, condannando l’intera area industriale a trasformarsi nel giro di qualche anno in un cimitero di fabbriche.
I picchetti durano da una decina di giorni e impediscono l’accesso a tutti e tre gli stabilimenti: il numero dodici, con le sue linee deputate alla produzione di frigoriferi e piani cottura; il numero quindici, utilizzato per lo stoccaggio delle produzioni Whirlpool provenienti dal sito produttivo di San Giovanni a Teduccio; e lo stabilimento numero sedici, dove fino a poche settimane fa tutta la merce prodotta a Carinaro veniva caricata e stipata nel ventre di bestioni autoarticolati per essere poi distribuita nei magazzini di mezza Europa. «Continueremo con i blocchi – dice Nicola – perché qui non ci sarà più nulla se chiude la Indesit. Qui intorno è pieno di aziende che lavorano per noi in conto terzi perché la produzione di frigoriferi, essendo basata sull’assemblaggio, ha bisogno di un indotto. Sono tutte aziende che tramite l’Indesit hanno realizzato il loro piccolo percorso industriale e che ora rischiano la chiusura: la Comap ha ottanta dipendenti, poi c’è la Acroplastica, la Mondoplast, ecc. Siamo un casino di noi!».
Nicola ha la fronte ustionata dal sole. È a picchettare la fabbrica dall’inizio della vertenza. Mi spiega che i presìdi sono organizzati in tre turni da otto ore in modo tale da garantire un blocco di ventiquattro ore. All’inizio tutto è andato liscio, ma da qualche giorno per alcuni operai i turni cominciano a diventare pesanti, complici il sole e le ore di sonno rubate dai picchetti notturni. Qui il buio esonera solo le donne e gli operai con i figli piccoli; per gli altri non esistono alternative ai sedili delle auto.
Nicola decide di accompagnarmi all’altro presidio, quello dei lavoratori della logistica, a patto che dopo gli dia un passaggio a casa perché la sua macchina ha l’assicurazione scaduta. «Io sono stato assunto alla Indesit quasi trent’anni fa. Ho due figli e lavoro solo io a casa mia. Quest’azienda è stata la vita mia. Qui in fabbrica abbiamo vissuto dei momenti d’oro quando c’erano produzioni di livello da portare a termine. Abbiamo prodotto più del cento, siamo arrivati anche a centoquattordici di produzione, raggiungendo sempre gli obiettivi senza mai fare problemi. Sto parlando del 2006. In quell’anno dagli stabilimenti uscirono un milione di frigoriferi. Te li immagini tu un milione di frigoriferi?», mi dice scrutando dal finestrino della macchina i capannoni in disuso che un tempo appartenevano alla Indesit.
Il marchio impresso sulla giacca della tuta blu di Nicola è ancora quello della Merloni Elettrodomestici, quasi come a dimostrare che con le acquisizioni societarie ci si può impadronire dei marchi, dei capitali, dei mercati, del sudore di chi lavora ma non della memoria, almeno non della sua. Era il 1987 quando entrò in fabbrica. In quello stesso anno la Merloni, già proprietaria del marchio Ariston, si apprestava, con un’operazione dispendiosa e complessa, a rilevare e rilanciare sul mercato il suo storico concorrente: il marchio Indesit. L’operazione riuscì così bene da spingere Vittorio Merloni, una ventina di anni dopo, a rinominare l’azienda di famiglia Indesit Company. Proprietaria dei marchi Ariston, Indesit, Hotpoint e Sholtes, la Indesit Company viene poi rilevata nel 2014 dal colosso statunitense degli elettrodomestici Whirlpool Corporation, sbaragliando le offerte della svedese Electrolux e della cinese Sichuan. Obiettivo del gigante americano è la leadership della multinazionale italiana in due importanti mercati, quello russo e quello europeo, e il controllo delle innumerevoli nicchie a essi connesse.
Sono quasi le tredici quando raggiungiamo il picchetto allo stabilimento quindici. Gli operai sono asserragliati davanti all’ingresso e incollati ai loro telefoni cellulari. Da Roma le notizie giungono frammentarie. Quel che si sa è che l’incontro al ministero è iniziato e che i compagni sono lì, a cinquecento metri dal palazzo, a rivendicare a suon di fischi il diritto violato. Nicola cerca di reperire informazioni più dettagliate mettendosi in contatto con il proprio delegato sindacale. I delegati qui alla Indesit sono diciotto in tutto, sei per ogni federazione: Fiom, Uilm e Fim. La loro posizione e la loro azione sono state unitarie sin dall’inizio: no ai licenziamenti e blocco totale dell’attività di produzione e di carico e scarico merci.
Alle quattordici arriva la notizia. A confermarla è un delegato Fiom da Roma. I lavoratori si guardano attoniti, increduli. Al ministero, assediato da più di seicento persone, hanno preferito il ricorso a una strategia già consolidata; rimandare l’incontro e stilare un calendario che allenti la tensione ripartendo la discussione su tre appuntamenti: il 29 aprile, il 5 e l’8 maggio.
Da lontano, defilato, osservo Nicola agitarsi imprecando contro azienda e governo. Gli altri invece sono seduti, in silenzio, con le mani tra le gambe, con i loro sguardi malinconici diretti verso lo stabilimento, come a vegliare qualcuno sul letto di morte. Improvvisamente sento fischiare, è Nicola che mi fa segno di andare. Metto in moto e partiamo. (giuseppe d’onofrio)



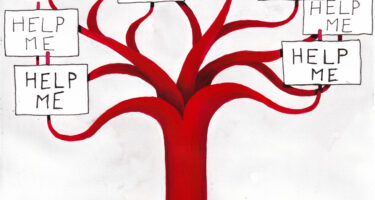

Leave a Reply