
Anche Milano in questo periodo è stata attraversata da una varietà di mobilitazioni, tra gli scontri del 26 ottobre, lo stato di agitazione dei rider e il presidio del 4 novembre per rivendicare reddito, salute e istruzione. Negli stessi giorni, altre iniziative di segno e intensità differenti hanno avuto luogo in varie parti della città. Le cronache che seguono provano a restituirne l’atmosfera, mentre adesso Milano si prepara a un nuovo lockdown.
Una luce particolare illuminava Milano nei giorni scorsi. Dopo giornate di pioggia intensa, buie e grigie, il cielo era tornato sereno e il sole emanava una luce neutra e diffusa, che illuminava un paesaggio vivido e tridimensionale in cui risaltavano i dettagli minuti degli edifici e le sfumature autunnali della natura. In questo scenario, che contrastava con le notizie sempre più preoccupanti sulla diffusione del virus, anche gli abitanti avevano un aspetto nuovo. Era possibile scorgere l’espressione dei volti, i movimenti dei corpi e ascoltare le loro voci come un regista, dietro una cinepresa, osserva gli attori in una scena cinematografica.
Con questo stato d’animo giovedì 29 ottobre raggiunsi via Corelli per partecipare alla conferenza stampa indetta dalla rete “Mai più Lager no ai Cpr” dove sarebbe stata annunciata la nascita della Volante antirazzista.
La prima cosa che vidi fu un gruppo di agenti in borghese, alcuni dei quali avevano in mano delle telecamere e sostavano al centro della strada in attesa di documentare eventuali azioni di protesta. Poco più avanti, sotto un ponte pedonale, si erano riuniti gli esponenti della rete appartenenti a diverse realtà antagoniste cittadine. Al centro del gruppo c’era Igor, uno dei leader del movimento, che distribuiva pettorine gialle con su scritto “Volante antirazzista. No Cpr”.
Avrei preferito non indossarla, non perché non condividessi l’iniziativa, anzi da alcune settimane ero entrato a far parte della rete partecipando alle assemblee settimanali, ma perché senza di essa mi sarei sentito più libero di muovermi e documentare ciò che accadeva. Invece l’avevo indossata e un po’ impacciato mi ero messo di lato, con le spalle appoggiate a una grossa parete in cemento armato che sosteneva il ponte pedonale, come se in quella posizione potessi mimetizzarmi e restare in silenzio.
Intanto sopraggiungevano altri militanti: giovani studenti, lavoratori, pensionati, donne e uomini. Arrivò il momento della conferenza stampa. Fu aperto uno striscione giallo che riportava il nome della rete e la frase: “No ai centri di permanenza per il rimpatrio e al decreto Salvini”. Le persone si misero tutte dietro, mentre Igor si posizionò davanti e con l’aiuto di un megafono iniziò il suo discorso rivolto a un paio di giornalisti presenti.
Mi misi a osservare quest’uomo basso, dalla corporatura robusta, il volto rotondo, gli occhi piccoli e chiari. La bocca e il naso coperti da un’ampia mascherina e in mano un microfono protetto da un sacchetto di plastica trasparente. «Da oggi – disse – saremo presenti tutti i giorni intorno al Cpr per vedere che vi succede, per controllare le angherie che vengono fatte agli immigrati che si trovano all’interno, affinché non sia più possibile che tutto quello che succede avvenga nel silenzio».
Igor parlava con voce rauca e intermittente, faticava a respirare ed era spesso costretto a interrompere il discorso. «Con questa iniziativa – ripeté con vigore – vogliamo che l’attenzione intorno a luoghi come questo si mantenga assolutamente viva».
Ci fu una pausa, un fotografo ci chiese di raggrupparci intorno allo striscione per una foto di gruppo. Dovetti acconsentire e mi andai a posizionare in un punto poco visibile. Ma di fronte ai numerosi scatti del giornalista, che si spostava continuamente cercando il punto di vista migliore, anche Igor mi sembrò insofferente e impaziente di riprendere a parlare. «Ieri sera è arrivato un altro carico di ospiti nel centro che abbiamo alle nostre spalle. Presumibilmente tunisini, che oggi vengono portati qui a causa di un accordo con il nostro governo, accordo di cui non conosciamo i termini. Quel che sappiamo è che le persone vengono rispedite nel giro di pochi giorni al loro paese, senza avere la possibilità di espletare le procedure per essere riconosciute come rifugiati politici. Gli vengono sequestrati i telefoni, gli impediscono le relazioni con l’esterno, se si eccettua la possibilità di una telefonata, che ovviamente viene fatta alle famiglie. Nessuna comunicazione con la rete di avvocati che si sta formando in città. Tutto questo lo chiamano legalità. Noi lo chiamiamo sopruso, emarginazione, lo chiamiamo razzismo istituzionale».
Terminata la conferenza stampa si formarono piccoli gruppi. Si discusse della possibilità di fare la prima “passeggiata” di monitoraggio quel giorno stesso, ma l’idea fu accantonata per l’inutile rischio di essere fermati dagli agenti che sostavano numerosi davanti all’ingresso del Centro. La Volante sarebbe partita il giorno dopo, così com’era stato programmato nelle settimane precedenti quando i diversi soggetti della rete avevano dato la disponibilità a essere presenti un giorno a settimana con due o tre militanti.
Salutai le persone che conoscevo, ripresi la bicicletta e mi diressi a via Fulvio Testi dove il “Movimento delle imprese italiane” aveva indetto una manifestazione non autorizzata contro le limitazioni imposte dal governo Conte alle attività commerciali. Era la prima volta che sentivo parlare di questo movimento, nato a Sanremo e composto, a quanto pareva, da imprenditori, commercianti e professionisti.
Percorsi la circonvallazione esterna, raggiunsi piazzale Loreto, superai il sottopasso della stazione Centrale e poco dopo svoltai a destra per via Fulvio Testi. Era una strada ampia, con due corsie centrali delimitate da alberature, la linea del tram, e due controviali su cui affacciavano alti edifici. Le dimensioni fuori dal comune mi spaventarono e iniziai a pedalare più velocemente con la speranza di raggiungere presto il luogo della manifestazione, ma nonostante gli sforzi avevo la sensazione di trovarmi sempre allo stesso punto e che non avrei mai raggiunto la meta.
Mi tranquillizzai solo quando intravidi i lampeggianti della polizia e poi lentamente i mezzi e gli uomini del reparto mobile di Milano che sbarravano la corsia opposta a quella che stavo percorrendo. Di fronte a loro c’erano due autovetture di grossa cilindrata e un gruppo di persone, tra cui spiccava un uomo con la bandiera dell’Italia. Tutt’intorno c’erano giornalisti, videomaker e fotografi; alcuni intenti a raccogliere le dichiarazioni di quello che sembrava il leader del movimento, un uomo di piccola statura e dagli abiti eleganti; altri a osservare impazienti l’evolversi della situazione.
Non sembrava, in effetti, esserci nulla da raccontare se non appunto osservare e riflettere sullo stato dell’informazione in Italia, accorsa in forze in quel posto per una manifestazione composta da poche decine di persone e dei grossi Suv con i quali volevano raggiungere il centro della città.
Poco dopo seppi che la polizia non li avrebbe lasciati passare e che i manifestanti avevano deciso di rinunciare al corteo e di ritrovarsi alle 21:00 davanti al palazzo della Regione. La notizia fu accolta con malumore e molti dei presenti si lamentarono del tempo perso. Osservai i manifestanti salire in auto e allontanarsi lentamente con le bandiere italiane fuori dai finestrini, mentre i vigili deviavano il traffico, che nel frattempo si era formato. Diedi un ultimo sguardo alla polizia in tenuta antisommossa che sbarrava la strada verso Milano, e ai giornalisti che si allontanavano in piccoli gruppi. Infine presi la bici e mi avviai verso casa.
I RIDER IN PIAZZA
Il giorno dopo, venerdì 30 ottobre, era stata indetta una giornata di mobilitazione nazionale dei rider contro l’accordo siglato tra Assodelivery e il sindacato Ugl. A Milano l’appuntamento era previsto nel pomeriggio in piazza XXIV Maggio, un’ampia area pedonale che fa da snodo tra il Corso di porta Ticinese, la Darsena e i Navigli. Un luogo simbolico perché sotto l’imponente porta che domina la piazza i fattorini si ritrovano tutti i giorni prima di iniziare a lavorare, per una pausa o al termine di un turno faticoso.
Quando arrivai il presidio era iniziato. Parlava un ragazzo italiano, robusto, con la testa rasata, la barba curata e un paio di occhiali rotondi. Indossava una felpa scura e sopra portava un gilet arancione. Davanti a lui, disposti a semicerchio, c’erano numerosi rider con le loro biciclette e i sacchi per il cibo. A terra un vistoso manifesto con la scritta “Veri diritti, no ai falsi contratti!”, le sigle dei sindacati Uil, Deliverance, Cgil e gli hashtag #Riderxdiritti e #Rights4riders. «Oggi è una data importante – diceva il ragazzo –, perché lavoratori di diverse città italiane sono scesi in piazza contro questo contratto vergogna. Da oggi dichiariamo guerra alle piattaforme, non possiamo continuare a fare biciclettate, non possiamo continuare a fare presidi, la prossima volta oltre a impugnare i contratti e andare nei tribunali a chiedere quello che ci spetta, organizzeremo dei picchetti davanti ai ristoranti perché è ora di mettere in ginocchio queste aziende. Siamo stufi, non siamo schiavi, siamo lavoratori!».
L’intervento si concluse tra gli applausi e con il lancio dello slogan “Rights for riders” ripetuto più volte e con tono sempre più alto insieme alla parola “United”. Ci fu una pausa musicale e io ne approfittai per guardarmi intorno. Vidi tanti ragazzi, quasi tutti provenienti dall’Africa occidentale, le loro bici e i sacchi colorati dei diversi marchi. Indossavano abiti invernali, avevano in testa un cappello e i volti coperti da mascherine. Formavano piccoli gruppi, alcuni silenziosi, altri rumorosi, altri ancora intenti a rilasciare interviste o a mettersi in posa per uno scatto. Osservavo queste scene e mi colpiva la disponibilità a raccontarsi e la consapevolezza con cui rivendicavano i propri diritti.
Ripresero gli interventi, parlò prima un sindacalista che ribadì che la mobilitazione in atto era solo l’inizio di «una nuova guerra», che era necessario essere uniti e lottare per modificare il «contratto bufala». Poi invitò tutti a posizionarsi davanti al manifesto per fare una foto e si formò così un folto gruppo di ragazzi che alzarono in cielo i sacchi e le bici.
Poi parlò Davide, un rider italiano, da poco iscritto al sindacato Cgil. Aveva un aspetto dimesso ma combattivo, la fronte alta, il naso da pugile, la barba e i capelli brizzolati. «I nostri colleghi, tra virgolette, di Ugl hanno firmato un contratto che obbliga noi e altri trentamila rider a lavorare gratis quando stiamo aspettando in un ristorante anche mezz’ora perché ci diano l’hamburger, quando siamo fermi per strada ad aspettare che l’algoritmo si decida a darci un ordine. Quel tempo non ce lo paga nessuno, ma serve a tutte le aziende per fare profitto».
Dopo Davide, si alternarono interventi di sindacalisti e rider, separati da brevi pause musicali durante le quali ascoltammo brani di Bicycle race dei Queen, Sabotage dei Beastie Boys, I fought the law dei Stray Cats, e vedemmo alcuni ragazzi ballare al centro della piazza. Tra i rider, due mi colpirono particolarmente. Il primo aveva un corpo esile e indossava un ampio giubbotto e un cappello verde che gli davano un aspetto goffo. «Vorrei parlare del comportamento dei ristoratori – disse con voce calma ma decisa –, a volte arrivi, saluti e non ti rispondono, e quando entri per far vedere il numero ti fanno: “Vai fuori. Qua non puoi stare”. Noi siamo delle persone come tutti». Si fermò, interrotto dagli applausi, poi riprese: «Non sto facendo la vittima, ma il comportamento che hanno con noi è sbagliato». Fu di nuovo interrotto, poi continuò ribadendo che i modi dei ristoratori erano inaccettabili e che c’era un diverso trattamento con i clienti che andavano a prendere il cibo d’asporto. Questi ultimi, a differenza di loro, venivano fatti accomodare e trattati bene.
«Vorrei finire sui clienti che sono a casa – aggiunse –. A volte al citofono non rispondono, poi li chiami al telefono, ti danno il numero per aprire il portone e ti dicono “Scala C, gira a destra, gira a sinistra, settimo piano…”. Ma stiamo scherzando!». Ancora una pausa per dare spazio alle risate, le urla e gli applausi dei compagni che lo ascoltavano. «Vogliamo più diritti – tuonò chiudendo il discorso –, più assicurazione e più potere di lavorare. Grazie!»
L’altro rider parlò quando ormai il sole era tramontato. Aveva un colore della pelle così scuro che a quell’ora era difficile cogliere i lineamenti del volto, notai però gli occhi che mi sembrarono piccoli e malinconici. Prima di iniziare chiese scusa dicendo che non era abituato a parlare in pubblico. Invece con il suo intervento fu in grado di fare un’efficace sintesi di tutti i temi che erano emersi durante quel pomeriggio. Partì col dire che Uber non pagava il tempo necessario per raggiungere il ristorante e il tempo di attesa prima del ritiro. Ma quel tempo è parte del lavoro e deve essere pagato, disse. Prosegui denunciando la mancata assistenza delle piattaforme che, quando si chiede un aiuto, non rispondono. Raccontò poi che quando l’indirizzo del cliente è sbagliato lui annullava la consegna. Non è il cliente, spiegò, che deve chiamare per chiedere di consegnare in un altro luogo, ma l’azienda a riconoscere l’errore e pagare quel tratto aggiuntivo di corsa. Denunciò infine la validazione dei clienti che spesso era fatta su base discriminatoria e razzista, e che dunque andava eliminata perché inutile. Concluse con queste parole amare: «Dobbiamo sopravvivere e chi non lavora non vive. Vogliamo lavorare per sopravvivere, però non con questo contratto. Noi vogliamo un contratto con i nostri diritti!».
LA MANIFESTAZIONE FANTASMA
Quella sera stessa seppi che nel fine settimana ci sarebbero stati altri due appuntamenti. Il primo sabato 31 ottobre indetto sotto la sigla “Tu ci chiudi, tu ci paghi, la Lombardia non molla”. E il secondo tra sabato e domenica, promosso dalla rete “Ci Siamo”, che da anni occupa degli stabili in disuso per dare ospitalità a chi non può permettersi una casa.
Il giorno seguente raggiunsi piazzale Loreto alle 20:30. Il luogo e l’orario erano indicati in un volantino diffuso in rete che aveva come sfondo un’immagine del Duomo ripresa dal basso verso l’alto e con un cielo azzurro scuro, presagio di un imminente temporale.
Sul posto, a presidiare la piazza, trovai un forte spiegamento di forze dell’ordine. Carabinieri, poliziotti e finanzieri in divisa antisommossa sostavano ai due lati di corso Buenos Aires insieme a giornalisti e fotografi. Tra loro riconobbi molte delle persone che due giorni prima affollavano via Fulvio Testi. Dei manifestanti invece non vi era traccia e nessuno sapeva se e quando sarebbero apparsi. Rimasi lì a osservare le forze dell’ordine e i giornalisti. Non persi mai di vista quello che mi sembrò il capo della squadra mobile, un uomo alto, con i capelli corti e il volto cupo e preoccupato. Fermo sul ciglio della strada, riceveva informazioni da alcuni uomini in borghese, e da quel punto scrutava la piazza cercando chissà quale segnale. Più avanti mi accorsi che gli venivano indicati i ragazzi più giovani che a quell’ora uscivano dalla metropolitana o attraversavano la piazza. Alcuni di loro furono fermati, gli fu chiesto di mostrare i documenti e dove erano diretti, ma subito dopo furono lasciati andare.
Nel frattempo i numerosi videomaker e fotografi presenti, alcuni con più macchine al collo, il casco e lo zainetto sulle spalle, discutevano ad alta voce se restare o tornare a casa. Tra di loro c’era un atteggiamento goliardico come quello che si ritrova tra vecchi amici di scuola. Come i fotografi, anche i finanzieri ingannavano il tempo parlando e scherzando. Uno di loro aveva chiamato un collega a casa e in videochiamata gli chiedeva i risultati del campionato e gli mostrava uno a uno tutti i colleghi presenti che lo salutavano affettuosamente.
Decisi allora di spostarmi e percorsi velocemente il tratto di corso Buenos Aires che separa piazzale Loreto da piazza Argentina. Quando arrivai mi accorsi che anche lì non c’era ombra di manifestanti, ma i carabinieri si erano schierati uno di fianco all’altro con gli scudi protettivi in mano, mentre i fotografi, stanchi della lunga attesa, si erano messi a scattare foto ignari di una scena surreale che li vedeva contrapporsi alle forze dell’ordine.
Questo non fu l’unico spettacolo esilarante a cui assistetti quella sera. Poco dopo un gruppo di poliziotti, anche loro in tenuta antisommossa, guidati da un superiore, si mise a correre avanti e indietro lungo corso Buenos Aires senza alcuna ragione. Dietro di loro, incuranti del ridicolo, gli stessi fotografi di prima li inseguivano puntandogli contro le macchine fotografiche e le telecamere.
L’indomani, domenica 1 novembre, con il ricordo ancora vivo della notte passata a piazzale Loreto, raggiunsi via Siusi per partecipare all’assemblea della rete “Ci Siamo”. Davanti all’ingresso dello stabile occupato era steso un ampio lenzuolo con scritto: “Casa, Lavoro, Sanità, Documenti. Solo con la lotta si conquistano Libertà e Dignità”. All’interno del cortile pavimentato trovai un gruppo di persone che formava un ampio cerchio. Dal gruppo si staccò un ragazzo africano e iniziò a leggere una lettera che aveva tra le mani. Si chiamava Lamin ed era originario del Gambia. «Tutti noi lavoriamo – raccontò – ma con i soldi che guadagniamo non riusciamo a pagare l’affitto, così abbiamo occupato questa casa che è vuota da trent’anni».
Dopo di lui intervennero altri abitanti, anche loro provenienti dall’Africa occidentale, e tra questi una donna, ma lo fece nella sua lingua di origine e fu tradotta da un connazionale. Tutti ringraziarono la rete per averli aiutati a trovare una casa e richiamarono gli altri a rispettare le regole di una buona convivenza. Poi intervenne una signora sudamericana con accanto il marito e un bambino piccolo seduto nel passeggino. «Ho tre figli – disse –, sono della Bolivia, sono qua da tredici anni, ho sempre lavorato, ho sempre pagato, ma adesso non riesco più a pagare l’affitto e mi vogliono cacciare da casa». Si vedeva che era disperata, si commosse e concluse chiedendo aiuto.
A quel punto intervenne uno dei leader del movimento, un italiano, magro e con il viso sottile da cui sporgeva un naso aquilino. Parlò a lungo ricostruendo il percorso fatto e lo fece sempre in modo pacato, senza mettere enfasi sulle parole che pronunciava. Disse che il progetto di via Siusi riguardava trentacinque persone, che erano state allacciate l’acqua e la luce, ma che si dovevano ancora organizzare le stanze e far funzionare i bagni. Ci sarebbe voluto del tempo, bisognava avere pazienza e lavorare insieme.
Raccontò poi che mentre stavano organizzando questa occupazione, decine di famiglie si erano rivolte a loro perché avevano bisogno di un posto per dormire. Disse che era necessario organizzare nuove occupazioni e promise che la rete si sarebbe impegnata a trovare nuovi spazi per tutti. «Noi in strada non ci torniamo – concluse –, e non solo, affronteremo anche i problemi del lavoro e dei documenti, sappiamo che la soluzione di tutto questo non può essere un piccolo gruppo, ma un grande movimento. Noi qui stiamo iniziando a fare questo».
Poco dopo l’assemblea si sciolse e gli abitanti si spostarono all’interno dello stabile appena occupato per continuare la riunione in forma privata. Io rimasi ancora un po’ in cortile a osservare dall’esterno l’immobile, che era stato un tempo la sede degli uffici delle patatine San Carlo. Poi entrai e visitai quelli che a breve sarebbero diventati gli alloggi di una piccola comunità internazionale. Non riuscii a vedere tutto perché solo alcune stanze erano illuminate da potenti fari posizionati a terra, mentre altre erano al buio e inaccessibili. Fui colpito dalle buone condizioni dello stabile, dalla qualità degli spazi ancora integri nonostante gli anni di abbandono. Desiderai di poter dare una mano a recuperare quei luoghi per dargli nuova vita. (salvatore porcaro)


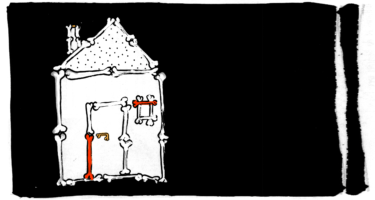
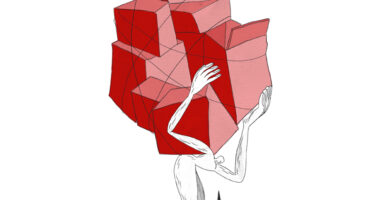

Leave a Reply