
Oggi andiamo nell’antico Egitto, la terra nera di limo e rossa di deserto da cui provengono. Al faraone Amenofi II ha dedicato una mostra il Mudec, il Museo delle Culture di Milano, nato qualche anno fa dall’operazione di recupero di archeologia industriale nell’area dell’ex fabbrica Ansaldo. Ci andiamo insieme, una domenica limacciosa di gennaio, attraversando un pezzo di città con il naso attaccato ai finestrini della 90.
All’ingresso del museo c’è un cartello ad informarci che rispetto al progetto originario dell’architetto David Chipperfield ci sono stati “alcuni scostamenti d’impatto estetico”. Mi balena il dissing tra l’archistar e il comune, e i calcinacci volati sulle pagine del Corriere, per via di un pavimento “sbagliato”. Chipperfield aveva chiesto si usasse la pietra basaltina di Viterbo ma il comune (risparmiando un milione di euro) scelse una pietra lavica dell’Etna, di cui l’architetto ebbe a dire: “Sarebbe inaccettabile nella cucina di chiunque di noi”.
Sgranchiti dalla colata lavica sotto i piedi e agitati da un fuoco di fornelli, saliamo lo scalone in pietra nera che conduce alla piazza coperta. «Ma è vuoto!», mi urla contrariato. Bravo Chipperfield, penso. La prima cosa che percepisce un bambino è il vuoto, il nulla, di certo non “lo spazio fluido e luminoso dell’agorà a forma di fiore”. Cominciamo a correre e con tre salti siamo già nella prima sala, con un aria da commedia francese. Qui incontriamo Amenofi II in forma di sfinge, con testa di faraone e corpo di leone. Poco più avanti si mostra con il gonnellino e lo scettro, protetto da una divinità a forma di babbuino. Suo padre, Thutmosi II, invece ha il volto fissato in un sorriso e la barba posticcia, in granodiorite, simbolo del divino. Loro, con lo stupore dell’archeologo e la fretta del tombarolo, si sparpagliano tra i vasi canopi in alabastro, gli amuleti-scarabeo, le stele di pietra e lo schermo tattile che proietta la tac della mummia di un coccodrillo.
«A che serve questo?». Lo leggiamo insieme: «Uncino in bronzo per agganciare ed estrarre, attraverso il naso, il cervello, dopo aver sfondato l’osso sfenoide». La cosa bella, aggiungo, è che il cervello non andava a finire nei vasi – come l’intestino, il fegato, lo stomaco e i polmoni – ma veniva buttato via perché gli Egizi credevano che la gente pensasse con il cuore e il cervello non servisse a niente.
Li perdo di vista, ricompaiono dietro un sarcofago dipinto, riscompaiono all’ombra di Nut, la dea del cielo che ingoiava le stelle al mattino e le risputava la sera. Io, indecisa se sia meglio lasciarli liberi di sparire o tenerli sempre a vista, mi distraggo leggendo dei “fanciulli di Kap”, una sorta di nursery reale che fu creata ai tempi di Amenofi II bambino per fare in modo che, fin dall’infanzia, il faraone fosse in relazione con la futura classe dirigente che l’avrebbe circondato. E funzionò, pare.
L’ultimo pezzo della mostra è dedicato all’archeologo francese Victor Loret che alla fine dell’Ottocento, bucando le pareti rocciose della Valle dei Re, trovò tutto quello che abbiamo visto finora; ma è anche l’Università degli studi di Milano che ne ha acquisito e studiato gli archivi: le mappe, le foto all’albumina delle mummie e degli scavi (in una l’archeologo si commuove davanti alle bende di una mummia), gli appunti giornalieri, i fogli su cui schizzò tutti i pesci visti nelle iscrizioni, gli acquerelli su cui li riprodusse e i calchi con cui li moltiplicò. Gli spiego che è importante vedere il lavoro di quell’uomo stempiato con il camice bianco che pensava con il cuore e che dovremmo ricordare anche il suo nome. Sono d’accordo con me, chiudono le palpebre come a custodirne la memoria e le riaprono davanti al video della mummy di Tutankhamon, per portarsi a casa anche lo spavento.
Attraversiamo indenni il bookshop, schiviamo il design store e ci troviamo presto in strada, con i cappucci tirati sulle teste e il buio sulle guance. Prima di riprendere l’autobus, riequilibrando spazio e tempo, ci fermiamo ai giardinetti per fare il nostro capodanno segreto. Abbiamo una confezione intera di stelletelle, l’accendino e il conto alla rovescia sulle mani. Le accendiamo una dopo l’altra, vorticose, e le vediamo spegnersi, furiose. Con l’intelligenza dei fuochisti piantiamo le ultime tre nella terra, queste le vogliamo solo guardare, a gambe incrociate, insieme. Il nostro fuoco notturno mi fa pensare ai cippi, i fucaracchi e i focarazzi di Sant’Antuono, ai culti pagani connessi al sole, alle questue o ’nferte dei bambini, accompagnate da canti e mascherate, in tutte le zone interne dell’avellinese, del casertano e in più punti del salernitano, che affondano le radici in culti arcaici connessi al mondo dei morti. A quant’è bello avere tante divinità, chiamarle per nome, da Osiride a Gesù, confonderle, tenere la vergine trafitta da sette spade accanto a un orixà che ama le conchiglie e i pop corn o non averne affatto, perderle una a una come a un gioco d’azzardo. Eppure proprio in Egitto, si legge in questi giorni, l’ateismo sta per diventare un crimine, perché conduce a “disturbi mentali e paranoia” e ad “atti di terrorismo”.
Una scintilla mi buca la giacca in poliestere, faccio finta di niente, voglio mi credano ignifuga, madre dei draghi, janara, politeista, mangiafuoco e sputastelle. (giusy palumbo)


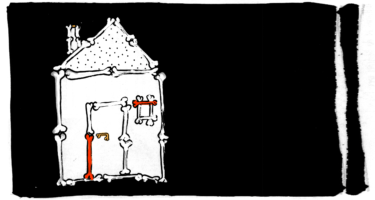
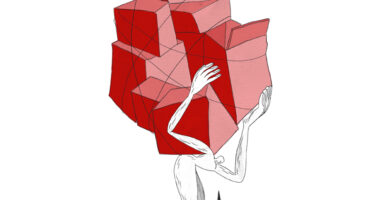

Leave a Reply