
Bologna è una città con poche finestre sul cielo. Nei cortili interni del centro storico le case sono accatastate come pezzi di montagna: case signorili, con stanze enormi, soffitti alti. Anche gli affitti sono altissimi, e si segue la linea dura delle grandi metropoli. Pochi sono i nuclei di resistenza. Bologna città aperta che accoglie e rifiuta i padri, ma che a volte ristagna in una conca senz’acqua. È anche una città senza mare. In via Oberdan, all’incrocio con via delle Moline, è però presente una piccola finestra, un ponte in miniatura, dal quale è possibile scorgere l’immagine vivente di un corso d’acqua: sembra Venezia senza barche.
Il cielo invece non si vede o va cercato accuratamente. Non si vede se si resta intrappolate tra le viscere cariche e potenti del ghetto ebraico, si vede nei viali, sui ponti, sui colli. Bologna città che vibra di cose strane, bizzarre, che a volte sembra una città del Mezzogiorno, un laboratorio poetico, pratico e teorico di costruzione di spazi di cura che attraversano il tempo. È più bella periferica. Ma laddove un tempo sorgeva Xm24, adesso c’è piazza Lucio Dalla e sorge, imponente, il palazzo vetrato del Comune. In questi mesi un’urbanistica feroce vuole costruire una scuola in un parco, cancellando il parco. È là che Bologna diventa deviazione infinita, ma anche capoluogo di regione come gli altri: tollerata nel circuito concettuale di una gentry liberal-democratica che richiama la nuova “appropriazione originaria” dei tardo-capitalisti, ma protetta dai manganelli. Le grandi imprese si incontrano ai margini e si allineano.
ALLEANZE
Il 13 aprile è un sabato di sole. Dietro al ponte Stalingrado, al circolo Arci Guernelli, con il collettivo Educatrici Arrabbiate ci incontriamo a un tavolo di discussione: quali alternative possibili allo sciopero? È un giorno di sole ma non siamo tante. A Roma, il 10 aprile, il sindacato SGB si era riunito in un presidio di piazza: era un giorno di sciopero. Ma il 13 aprile non c’erano bandiere sindacali. Soltanto il lancio di una scintilla. Intanto, dal 29 gennaio cinque educatrici della cooperativa Eufemia, a Torino, non si presentano a lavoro: è l’inizio di uno sciopero permanente.
Il tempo della memoria non si esaurisce nel tempo della storia: si parla in presente ma si pensa anche al passato. Un’educatrice al tavolo ricorda che quasi cinque anni fa, nel giugno 2019, la prefettura di Bologna decideva di chiudere l’Hub di accoglienza collettiva di via Mattei 60, nella prima periferia della città, oggi Cas, Centro di accoglienza straordinaria, che ospita più di ottocento persone. All’epoca, erano 183 i migranti che ci vivevano. La chiusura dello spazio era ufficialmente giustificata da “lavori urgenti di ristrutturazione e mantenimento”, ma in realtà si inseriva nella logica della dispersione e dello smistamento dei migranti sotto l’egida del Decreto Sicurezza di Salvini; in pratica, si trattava di uno sradicamento forzato dei richiedenti asilo da una città a un’altra, da Bologna a Caltanissetta, in Sicilia. La chiusura dell’Hub avrebbe portato al licenziamento immediato di più di cinquanta lavoratori e lavoratrici dell’accoglienza e non solo; un esempio calzante di frammentazione dello spazio e del tempo della cura: “deportazione” e “smaltimento”. Essi non difendevano le mura-tendopoli dell’Hub di via Mattei, uno dei molteplici campi periferici di questo paese, né l’accoglienza come momento retorico di un’espulsione definitiva, ma le relazioni che vi si erano create; forti dell’esistenza di un processo di auto-organizzazione, insieme ad altre forze solidali, si opponevano alle decisioni del governo centrale, estraneo ai percorsi di vita nel territorio.
Alla base della lotta delle educatrici di Eufemia a Torino vi è lo stesso rifiuto: da un’esperienza specifica, individuale, una risposta multipla. «Quello dell’Hub di via Mattei fu anche un’esperienza collettiva di resistenza – ci racconta C. –, ma ci trovavamo di fronte a un bivio: dovevamo difendere il lavoro ma volevamo che questo Hub chiudesse». L’Hub riaprì ma divenne Centro di accoglienza straordinaria. Nel 1999 si parlava di Cpt (Centri di permanenza temporanea), poi di Cpr (Centri di permanenza per rimpatri): la trasformazione di un termine non porta sempre con sé la trasformazione del concetto. Oggi, nonostante si parli di accoglienza diffusa, esistono ancora Cie (Centri di identificazione ed espulsione) in Italia. Sono cinque: a Torino, Bari, Roma, Trapani e Caltanissetta. Nel caso dell’Hub di via Mattei la battaglia fu vinta, dice C., perché ci fu un ricollocamento in provincia. Ma oggi l’ex Hub resta un centro di accoglienza ordinaria, in una struttura fatiscente, sporca e sovraffollata. Questo è un esempio di come un’alleanza collettiva possa produrre i termini e le condizioni di una lotta e vincerla, nonostante sia complicato abbattere un sistema, conoscerlo, negarlo. Ormai da anni si parla di una razionalità imprenditoriale interna ai tessuti statali e pubblici, che disossa ciò che resta del pubblico. Questa razionalità gestisce, taglia, unisce, rettifica, scompone, riunifica, espelle, garantisce, esporta, ricolloca quando vuole anche il lavoro di cura. È questo “quando vuole” (potestas sciolta da qualsiasi vincolo) che non può funzionare per chi vive del proprio lavoro sociale.
BURNOUT
Intanto una catena di operatrici e operatori si moltiplica. Gli anelli di questa catena sembrano intercambiabili. Non c’è rizoma: i servizi sono stabiliti e gestiti da enti delocalizzati, lontani. Una delle grandi paure delle piccole cooperative e associazioni di Bologna è quella di vedersi togliere lo spazio e il tempo della cura da un dominus che è assente, e che nelle scuole e nelle strade non c’è mai stato. La situazione è chiara: il meccanismo di appalti e subappalti alle grandi cooperative sociali è una piaga che si espande atrofizzando l’immaginazione collettiva di chi vive quei luoghi: inghiottire tutto, totalizzare lo spazio, possedere il tempo della cura.
La cooperativa sociale Quadrifoglio, per la quale molte delle educatrici e degli educatori di Bologna lavorano o hanno lavorato, nasce nel 1981 a Pinerolo, Torino, grazie a dei finanziamenti per lo sviluppo della cooperazione promossi dalla Comunità europea. Si afferma, nel giro di trent’anni, come una delle più grandi realtà nazionali del terzo settore, con un fatturato di circa 114 milioni di euro, e una compagine di lavoratori di circa 2.849 (dato che risale al 31/12/22, rintracciabile sul sito). Lavora con anziani, disabili e minori, sviluppa percorsi riabilitativi psichiatrici e di assistenza domiciliare. Da più di tre anni è attiva sul territorio bolognese nei servizi educativi e di integrazione scolastica di alunne e alunni con disabilità e neuro-diversità. Per molti è un luogo di passaggio, il primo approdo professionale; per altre resta il posto di lavoro a tempo indeterminato: tutto lo spazio per tutto il tempo della “cura”. Mi fermo e penso a Bologna, al fatto che non potrà mai essere del tutto città metropolitana e nonostante questo le piccole associazioni rischiano di scomparire, sostituite da grandi cooperative che operano a livello nazionale: imprese sociali nutrite dai bandi a ribasso, che rischiano di diventare la punta dell’iceberg del controllo e dell’assistenza, mascherato da “cura alla persona”, su un territorio sconosciuto.
Ci dividiamo in gruppi, a seconda del contesto di lavoro – scuola, comunità, strada, casa. Quali alleanze possiamo costruire? Molte educatrici vivono sulla soglia della povertà ma non lo riconoscono; se ne parla fuori, nei luoghi di incontro informali che non comprendono quelle pratiche. Un’educatrice scolastica della cooperativa sociale Orsa conia la giusta espressione: burnout dell’alleanza informale. La frustrazione è talmente alta che l’unico spazio di discussione diventa lo sfogatoio di un bar, dal quale si torna a casa ancora più frustrate, senza alleanze. All’interno del contesto scolastico – spazio complesso e stratificato – il conflitto non sempre è sostenibile. Si entra nelle scuole pubbliche e statali come operaie e operai sottopagati e sotto inquadrati di imprese private in appalto; si lavora e si vive nelle classi con mansioni che non vengono riconosciute; si propongono e progettano, spesso da sole, pratiche di inclusione che non sono realizzabili se il contesto-classe resta immobile.
«La dis-alleanza con le colleghe, in particolare con il corpo docenti, impedisce una visione unitaria che coinvolga tutta la scuola», afferma M., confermando la mia percezione. Il corpo docente, scampato alle cooperative, non può certo dirsi il braccio destro del settore pubblico o dello Stato: «Almeno noi educatrici abbiamo dalla nostra gli assistenti sociali!», afferma ironicamente un’educatrice. Per questo è arrivato il momento di riunirsi, educatrici e educatori, maestre e maestri, professoresse e professori. Ci ricordiamo del Movimento di cooperazione educativa, che si ritrova, come noi, al Guernelli. Sarebbe bello tessere un tavolo di discussione permanente su Bologna, che intensifichi i rapporti di critica e di cura, che crei cerchi concentrici, non gerarchie. Uscire dalla famosa guerra tra poveri. Le cooperative appaltanti si sono prese l’advocacy dell’educazione, della sua progettazione e gestione, ma nella finzione di un welfare che si è già sgretolato. La scuola risulta un puzzle infinitamente smontabile e rimontabile dal quale non emerge alcuna immagine. Chi fa da sé, non fa per nessuna. Nei contesti scolastici – a differenza dei contesti di strada e di comunità, dove si lavora in prossimità e dove le alleanze si creano stando sulla soglia, nella vicinanza, nel discorso – la natura di un’alleanza è spesso assimilabile alla mera tolleranza del contesto educativo tutto: il fine del lavoro educativo viene ottenuto con mezzi automatici, cioè con un aumento della forza lavoro precaria che risponda alla domanda della scuola e tappi i buchi. L’esternalizzazione dei servizi educativi è una delle cause del malessere salariale, contrattuale e in genere lavorativo di educatori ed educatrici, ma è soprattutto la veste formale di quel malessere.
Se le mancanze nelle politiche di welfare dipendono dall’assenza di investimenti, l’aridità del lavoro educativo è ben più profonda e radicata. Vige ancora un’avversione profonda al significato emancipatorio della cura. Una specie di negazione dell’emarginazione sociale, della sua causalità centrifuga ed escludente, generante ulteriore emarginazione. Al senso etico dell’educazione come pratica orizzontale e reciproca, si sostituisce il senso morale della cura. Cura è assimilabile ancora oggi alla carità e all’assistenza, alla colpa e al privilegio di essere neurotipici e abili, economicamente agiati, bianchi. È anche per questo che il lavoro di cura diventa volontariato e pazienza, mortificazione per redimersi. Oggi le educatrici hanno una mission che si sviluppa in projects, con i suoi manager e i suoi referenti aziendali. Alla base vi è la cura come sistema di assistenza verticale che decide e salva. Ma «se ti poni verticale non puoi sbagliare, devi aiutarmi. E allora perché non lo fai?». Dal cerchio materiale e immateriale nel quale ci troviamo a discutere, il 13 aprile, la voce di Z. si spezza e batte il tempo. Non si indirizza a nessuna in particolare: occupa spazio di parola e di azione.
Il richiamo di Z. è a quell’antica alleanza, dimenticata, con chi subisce il lavoro di cura. Alleanza che non è richiesta nei convegni accademici ed è invisibile nelle carte dei tribunali, ma che è necessaria nel lavoro educativo: quell’alleanza è nelle scuole, nelle comunità; comincia nelle strade e spesso finisce nelle strade: non è forse di questo che stiamo parlando quel giorno?
VIVERE DA JOLLY
Leggendo l’“organigramma generale dell’organizzazione aziendale” delle grandi cooperative di Bologna (Quadrifoglio e Orsa, Dolce, Open Group), mi appare concluso il progetto che le educatrici di Eufemia hanno denunciato in fieri: una struttura verticistica, dove la base – costituita da chi opera – è completamente recisa dal vertice, costituito invece da chi decide le strategie di azione. Un’astrazione. Essere atomi è necessario all’ordine del mercato, spietato nella gestione degli investimenti, delle risorse e delle alternative. Capiamo che è indispensabile anche all’imprenditoria della cura. Tra le variegate frontiere dello sfruttamento sul lavoro il lavoro di cura è lo spazio di un lavoro utile, necessario, ma per questo maggiormente sfruttato e sfruttabile, istituente spazi di dipendenza enormi e senza soluzione. Una cooperativa così “disorganizzata” e con così pochi fondi non può che soddisfare i criteri minimi dell’assistenza, vivendo alla giornata. Infatti, frasi come “cerchiamo di venirti incontro” si alternano a frasi come “così non va bene”. Toni paternalistici in entrambi i casi. In fondo, le cooperative sociali non sono dei mostri a tre teste che si sono impossessate del lavoro del pubblico e statale, ma si basano su un modello educativo assistenzialistico che ricalca lo Stato e lo sostituisce.
Se nel modello fordista del lavoro l’istituzione di gerarchie era funzionale a una classificazione inflessibile dei lavoratori, nelle cooperative sociali non vi sono propriamente capi né dipendenti: vi è il direttivo, un consiglio amministrativo, vi è la coordinatrice di quartiere, vi sono le operatrici che gestiscono le sostituzioni, burocrati della precarietà e dello smistamento. Al piano più basso, pullulano come mosche impazzite e confuse i jolly, piazzati da un contesto a un altro senza formazione, con giornate lavorative che raggiungono anche le dieci ore. La flessibilità del lavoro è in realtà il nuovo regime della “transumanza” dei lavoratori. La flessibilità dei contratti fa sì che essi mutino a seconda del mutamento delle esigenze dell’impresa. Essere flessibili, ci diciamo, significa adattarsi alle esigenze del lavoro di cura.
«Sei un jolly, non puoi non lavorare» e «sei un jolly, puoi anche non lavorare» sono le due facce della stessa perversione. Le ore fisse sono un premio e quindi il precariato è un presupposto. Per questo essere jolly è anche una punizione. Le cooperative sociali riproducono la logica del premio-punizione e su questa logica intessono la propria sopravvivenza. Attraversando le istituzioni scolastiche, dagli asili nidi alle scuole superiori di secondo grado, le comunità e i centri di accoglienza, fino alla strada e alle strutture residenziali, i jolly emergono come una categoria lavoratrice oppressa e non protetta, estranea non solo alla sfera pubblico-statale, ma anche ai piani di progettualità, al senso del lavoro come creazione e immaginazione della società: le lotte sono ai margini di chi lavora ai margini. Ognuno ha le proprie. Lo scontro è netto e chiaro: agli oppressi i propri oppressori, e viceversa. I jolly finiscono per essere il nulla assoluto. Nascono con un contratto da diciotto ore settimanali, finendo per farne anche trenta. Tutto questo avviene in funzione di una copertura costante ma discontinua. Sono erogatori subalterni di servizi nella miseria dell’occupazione e del lavoro precario della cura. «Pensavo che sarebbe stato solo temporaneo. Invece lavoro qui da sette anni – dice Laila – e non ho mai visto una crescita: né economica né professionale». «Ho una laurea in pedagogia ma mi hanno detto che hanno già una pedagogista di riferimento. Il mio lavoro consiste nella gestione del pre e post-scuola, e seguo due bambini certificati. Lavoro trentasei ore a settimana ma a volte faccio anche qualche sostituzione».
La pronta reperibilità è giustificata come la pronta risposta a un aumento della domanda, e in quanto tale nessuno gode di immunità. Jolly si può essere sempre. Il jolly in effetti ricorda moltissimo l’operaio non specializzato, il bracciante pagato a cottimo, lo studente con contratto a chiamata. Ma il jolly sociale è molto di più e molto di meno. Una delle affermazioni che più mi sono sentita ripetere è «siamo in una situazione di emergenza, ci sono troppe educatrici che mancano, abbiamo tante sostituzioni. Finisce che ti ci senti dentro».
I corpi senza cura che si muovono da un punto all’altro della cura quale alleanza possono creare? L’assenza di formazione, l’invisibilità, la non comunicazione dei passaggi di consegna, la precarietà assoluta nella quale vivono – anche per anni – è terrificante, ed è molto simile a quella di altre categorie di lavoro sfruttato e precario ben presenti in Italia (camerieri e baristi, riders, volantinai, operai agricoli, ma anche operatori sociosanitari e infermieri domiciliari). Dietro il lavoro ossequioso e instancabile della gerarchia cooperativistica è pur sempre il governo che detta il tempo, e dietro al suono di quel battito, come un’eco, suonano a ribasso le cooperative del momento. Capita però che la mano destra non sappia che cosa fa la mano sinistra: il lavoro educativo, come spazio di relazione e di liberazione, diventa il più delle volte controllo sociale e nel peggiore dei casi, contenzione; esso è proteso all’obbedienza di una gerarchia che dal governo va all’assistente sociale, e spesso mira al contenimento della disobbedienza, della devianza, del dolore, cioè al mantenimento – del tutto tautologico – dello stato di cose attuale. Con un salario statale forse il conflitto interno educatrici-insegnanti si abbasserà, ma non basterà a cambiare le dinamiche. La marginalità, questo deposito-metafora spaziale dove si concentra il lavoro educativo, resta senza spazio e senza tempo storico: le educatrici e gli educatori diventano “ammortizzatori” sociali, “assistenti degli assistenti sociali”, pezzi meccanici e automatici di una fabbrica sociale a carenza di forza lavoro e di soldi.
Ci salutiamo lanciando delle palline di carta al centro della stanza: ognuna e ognuno ha scritto il significato di quella giornata. Lavorando sull’affettività, spesso le cooperative falliscono la società, la mancano, o la cristallizzano. Non trasformano l’esistente, ma mantengono lo status quo. Questa è la loro natura conservatrice, non istituente. Gli affetti – come la paura e la speranza – giocano qui il ruolo di forze omeostatiche strumentali al mero mantenimento di un equilibrio precario, e la mortificazione è una delle forme affettive con cui si esprime la violenza che tante volte percepiamo lavorando in quegli spazi, l’assenza di alternativa. Violenza per lo più simbolica, che non si riduce all’utilizzo della forza né al monopolio di essa e per questo, nel peggiore dei casi, ego-sintonica, riconosciuta e accettata come baluardo della mission del terzo settore. La violenza simbolica della mortificazione serve a reiterare la dipendenza dell’educatrice e dell’educatore dalla cooperativa stessa. È questa dipendenza che dobbiamo spezzare. Cercando spazi di relazione, di conoscenza, di alleanza. (sara provenzano)

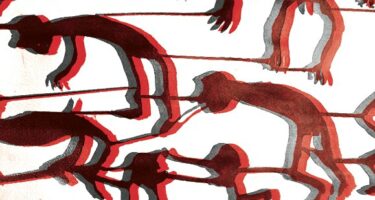



Leave a Reply