
Quella che segue è la versione integrale dell’intervista pubblicata da Il Corriere del Mezzogiorno del 26 settembre.
* * *
Lo scorso 12 settembre è stato presentato allo Zero81 di Napoli L’Armata dei Sonnambuli, ultimo libro di Wu Ming, uscito la scorsa primavera e arrivato alla sesta ristampa in meno di sei mesi. Ne abbiamo approfittato per incontrare Wu Ming 1, e parlare con lui, oltre che dell’ultimo lavoro del collettivo, del loro modo di scrivere, di storia e di letteratura, «che poi è quello che ci succede intorno ogni giorno».
Mi sembrava importante iniziare dal lavoro ricerca storica che c’è dietro i vostri romanzi. Sono incontri casuali quelli con il periodo storico a cui vi avvicinate, o avete in mente un piano preciso, un’idea di partenza?
Si parte sempre da una suggestione piuttosto vaga che il più delle volte è il ricordo di qualcosa che si è sentito a proposito di un macro evento o di un periodo che viene ritenuto stimolante, che esercita un richiamo su di noi in un particolare momento del nostro percorso. Per ricostruire come si è arrivati a L’armata dei Sonnambuli bisogna tornare a Manituana, perché mentre scrivevamo quel libro, che parla della guerra di indipendenza americana, c’era venuta la voglia di attraversare l’Atlantico e di raccontare la rivoluzione francese. Una rivoluzione che avviene anche per conseguenza di quella americana, perché c’è una ricaduta diretta della partecipazione francese alla guerra di indipendenza americana contro gli inglesi, e su quello che succederà dopo. Gli investimenti finanziari, i fondi che vengono spesi dal governo francese dell’Ancién Regime per appoggiare George Washington in funzione antibritannica hanno delle conseguenze devastanti sulle casse dello stato, e questo sarà uno dei fattori che porteranno a una turbolenza sociale, al compimento di un processo di delegittimazione della corona. Oltre al fatto che ci sono alcuni personaggi che fanno da ponte: Benjamin Franklin, Thomas Paine, lo stesso Jefferson. Insomma quello che era successo negli Stati Uniti fu fonte di ispirazione per tutta una serie di radicali francesi, come lo stesso Brissot che viene nominato molto spesso nel libro, ed era considerato una specie di Nando Mericoni dell’epoca: lo prendevano in giro perché era completamente intrippato con l’America, parlava sempre dell’America… Così mentre scrivevamo Manituana abbiamo pensato di proseguire questa esplorazione dei fermenti rivoluzionari settecenteschi e siamo andati dall’altra parte dell’oceano. Ma chiaramente la rivoluzione francese è una bestia molto più difficile da domare.
Anche l’approccio è un po’ diverso…
In un certo senso si. Considerando anche che la guerra di indipendenza abbiamo scelto di raccontarla dal punto di vista di chi l’ha subita, i nativi americani. Nel rovesciare quello sguardo abbiamo fatto vedere che quella che viene raccontata come una rivoluzione in realtà somiglia poco a una rivoluzione e ha degli aspetti anche mostruosi. Basta spostare il punto di osservazione e cambia tutto. In questo caso non bastava rovesciare uno sguardo, perché la rivoluzione francese è un processo molto più complicato, ma anche molto più documentato e raccontato. Su quegli eventi lì sono fiorite delle interpretazioni in guerra l’una con l’altra, Guerìn l’ha chiamata “la guerra civile tra gli storici”. In ogni momento, ad ogni nuova fase della modernità che ha vissuto l’Europa, è corrisposta una nuova interpretazione della rivoluzione francese, come se si dovesse tornare indietro per giustificare quello che si sta per fare.
Però in generale il programma che noi abbiamo è quello di usare sempre punti di vista dal basso e sghembi. Sempre spiazzati, da un margine, farli arrivare da direzioni imprevedibili. Poi bisogna di volta in volta capire cosa significa un punto di vista sghembo. Con la rivoluzione francese, dove tutto è mappato in scala uno a uno, era più difficile, anche per una sorta di timore reverenziale nei confronti dell’argomento. Oltre che per un po’ di spiazzamento nostro rispetto alla mole di materiali, reperti.
C’era già l’idea che diventasse un trittico, tutto questo materiale, o è arrivata dopo?
A un certo punto ci siamo detti che un libro non sarebbe bastato. Avevamo tre tipi di suggestioni, ma alcune le abbiamo fuse ne L’armata dei Sonnambuli, per cui non lo sappiamo se questo è il secondo libro oppure il secondo e il terzo insieme. Perché poi è lunghissimo, ci abbiamo messo sei anni. E in più vogliamo ora cambiare un po’ il passo, sviluppare narrazioni di tipo diverso, chiudere con questo tipo di romanzo storico, e infatti già L’armata dei Sonnambuli nella parte finale registra uno scatto rispetto ai libri precedenti.
Quali fonti utilizzate di solito per la ricerca?
Da Manituana in poi abbiamo molto frequentato uno storico americano che si chiama Robert Darnton, che è uno dei massimi settecentisti viventi, esperto di illuminismo e rivoluzione francese. Che ha un punto di vista molto interessante, anomalo. Si è dato come programma far vedere che il Settecento non somiglia per niente alla vulgata, alla narrazione che uno avrebbe in mente, per cui prima c’è stato l’illuminismo che ha rischiarato l’orizzonte della cultura europea e poi da lì è conseguita la rivoluzione. Un approccio che lui supporta con dati duri, praticamente è andato a vedere cosa si pubblicava e cosa si leggeva nei trent’anni precedenti la rivoluzione francese. Ha fatto un libro che si chiama L’intellettuale clandestino in cui ha constatato che nessuno leggeva i filosofi illuministi, che avevano delle tirature di stampa ridicole e non circolavano per niente. Mentre i grandi successi dell’epoca erano dei libelli clandestini pieni di maldicenze nei confronti della corte, e infatti lui parla del “potere sovversivo del pettegolezzo”, racconta di come l’istituzione della monarchia sia stata destabilizzata con un lungo lavorio sotto Luigi XV e poi Luigi XVI. Un lavorio di pettegolezzo, di giornalismo dal buco della serratura, che parlava del malcostume, della dissolutezza, e che ha preparato il terreno alla rivoluzione molto più delle influenze avute dall’illuminismo. Lo stesso Robespierre non riconosceva affatto il filum di continuità tra la rivoluzione e l’età del lumi.
Darnton è stato un riferimento anche nelle ricerche sul mesmerismo?
Assolutamente si. Lui fa un libro, nel 1968, che si chiama Il mesmerismo e il tramonto dei lumi, dove fa una ricognizione di questa voga che c’è stata a Parigi negli anni Ottanta del Settecento, sul magnetismo animale, che sono le cose che raccontiamo nei flashback: la grande influenza di Mesmer che arriva in Francia, fonda questa Società dell’Armonia e tutti cominciano a parlare di mesmerismo, tutti vogliono essere curati con quel tipo di approccio. La cosa interessante che fa Darnton è mostrare come questa sia una delle tante influenze non riconosciute nel processo rivoluzionario, la curiosità enorme che si accende nei confronti di una teoria che sovverte i parametri e la dottrina medica dominante. E infatti è una dottrina detestata dall’establishment, tanto che si forma una Commissione reale per combatterla. Una specie di contronarrazione del malessere, che in qualche modo ha istradato molti che poi diventeranno protagonisti della rivoluzione, e che erano membri della Società dell’Armonia, facendogli da scuola di pensiero sovversivo.
Un’altra posizione dal margine che utilizzate per la vostra narrazione è quella della pazzia.
Si, che poi è la posizione più dal margine che si può immaginare: la rivoluzione vista dai matti, dagli alienati, che sono rinchiusi nell’ospedale di Bicêtre. Che è un luogo importantissimo perché lì poi nascerà la psichiatria moderna, c’è questa scena un po’ mitologica in cui vengono tolte le catene agli alienati per la prima volta. Un’altra è quella delle donne, che erano state assolutamente protagoniste del processo rivoluzionario, sia quelle del proletariato parigino sia quelle borghesi che fondarono i club radicali.
A proposito del proletariato, nel libro c’è una voce fuori campo che è in qualche modo la voce del popolo. Come è venuta l’idea e come ci avete lavorato linguisticamente?
È nata perché in generale nel nostro lavoro ci interessa capire come e quanto circolano le voci, e questa volta abbiamo avuto l’esigenza di mettere in scena la voce della plebe. Una voce polifonica, un coro sgangherato dove ci sono anche interruzioni, battibecchi, e da cui è nato questo personaggio collettivo che ogni tanto è in scena e che è tutto il quartiere Sant’Antoine. Da un punto di vista linguistico il lavoro è abbastanza elaborato: era necessario che quel personaggio si esprimesse in una lingua sua, per potergli dare corpo, credibilità e far sentire anche l’umore popolare. Le fondamenta le abbiamo trovate nel gergo di strada, nell’argot che parlavano i sanculotti all’epoca, su cui ci sono studi linguistici molto precisi. Esiste addirittura un dizionario di cinquecento pagine di modi di dire sanculotti. E quella è l’architrave. Però per non fare una operazione fredda, a tavolino, abbiamo deciso di scaldare la materia, anche per poterci muovere a nostro agio all’interno. E quindi ci abbiamo messo dentro cose dai dialetti emiliani, dal ferrarese al bolognese, modi di dire molto bassi, molto carnali, molto plebei.
C’è un personaggio ne L’Armata dei Sonnambuli, Leo Modonnet, che pure rispecchia molto bene i sentimenti di quello strato sociale in quella fase storica. Ma forse è il ritratto di quello che è, storicamente, e anche nel presente, il sottoproletariato urbano.
Si, lui è la plebe bolognese portata a Parigi. Tra l’altro pensa in bolognese, ha tutti questi modi di dire che ci riportano proprio alla plebe di provincia… la commedia dell’arte anche, catapultata in un contesto dove il teatro sta diventando la vita reale. Lui dice una frase: “Oggi il teatro è a cielo aperto. La rivoluzione stessa è il teatro e le masse lo calcano”. Quello che lui si porta dietro è il suo patrimonio, le risse a Bologna, il teatro di strada, cose universali ma ritematizzate in un contesto diverso. È il discorso che coinvolge anche un altro personaggio, che è il cavaliere D’Ivers: con lui volevamo mettere in un racconto storico un personaggio totalmente anacronistico, un personaggio che è venuto direttamente dal Novecento, un teorico di estrema destra. Evola, Codreanu, un fascista praticamente. Lui di fatto non è un legittimista monarchico, fa dei discorsi che sembrano presi dalle edizioni AR di Franco Freda. È del tutto fuori da quella temperie, la guarda come se la guardasse da duecento anni dopo. Ed è un personaggio che al lettore appare vicino, magari durante la lettura non elabora il perché, ma è proprio una questione temporale, di familiarità del male, più che di fascino.
Prima si parlava di uno scatto, della necessità che sentite di andare verso una nuova narrativa. Quale sarà la direzione?
La direzione viene fuori già con il dittico Timira e Point Lenana. È un tipo di scrittura contaminata, ci sono cose del reportage, dell’inchiesta giornalistica, una fertilizzazione tra fiction e non-fiction scritta con tecniche letterarie, con sperimentazioni di montaggio particolari. Avevamo già provato a fare questa cosa nel 2000 con Asce di guerra ma non era riuscita bene, eravamo ancora impacciati. Mentre con questi altri due ci muovevamo più a nostro agio, perché nel frattempo avevamo accumulato esperienza su fronti diversi, dal blog fino alla sceneggiatura. Oggi cerchiamo di incrociare queste tecniche, forzarne l’utilizzo. È quello che facciamo nel quotidiano, anche con la scrittura del blog, che utilizziamo per sperimentare, per tentare certe occhiate che poi usiamo anche nei romanzi. A livello di tecnica, perché scrivere per il blog ti disinibisce di fronte a una certa testualità, ma anche a livello di montaggio di materiali. È una palestra incredibile da questo punto di vista, anche per i temi. Alcuni macrotemi di cui ci occupiamo da sempre e su cui periodicamente torniamo.
Per esempio?
Uno di questi è la falsa rivoluzione, la retorica del cambiamento, del nuovo, con tutte le articolazioni che vanno da Beppe Grillo ai “rosso-bruni”, fino alle allucinazioni No-Euro dove sono assieme fascisti, leghisti, ed ex compagni. Cose su cui proviamo a fare anche un lavoro di inchiesta. Oppure quello del “vittimismo italiano” come collante ideologico. Prendi il caso di Davide Bifolco, che è completamente permeato di questa roba. Cosa si intende quando si dice: “Se l’è andata a cercare”? Non vuol dire altro che: “Non è colpa mia”. E quel “non è colpa mia” è la nota tipica dell’ideologia che ci rappresenta sempre come vittime, come gente che si è trovata lì per caso. Tipo le foibe, o tipo: eravamo alleati di Hitler ma non eravamo poi cattivi. E questo caso mi è sembrata l’ennesima rappresentazione di questa cosa, per cui nessuno è mai responsabile di nulla, tutti sono vittime, mentre la vittima vera ha la colpa, se la va a cercare: perché era in motorino di notte, senza casco, o lo stesso essere del Rione Traiano, come scrive qualcuno, è una cosa da espiare con la pena di morte.
Per tornare alla domanda, diciamo che in un certo senso il romanzo storico ha cominciato ad andarci stretto, anche perché sono ormai venti anni che lavoriamo su questa direttrice, e quindi L’Armata è stato concepito come l’ultimo atto di questo tipo di romanzo. Infatti già nel quinto atto c’è una contaminazione tra archivio e fiction che è quello su cui probabilmente andremo a lavorare nei prossimi anni. Poi, da qualche mese, stiamo scrivendo un libro per bambini. Che è un tipo di scrittura difficilissima, solo in apparenza facile. È una raccolta di venti storie collegate da una cornice comune, che è il nostro primo esperimento di questo tipo. Siccome abbiamo tutti figli tra i sei e i dieci anni, la sfida è di raccontare storie anche dure, anche di conflitto, in maniera comprensibile, senza semplificarle o indorare le pillole. C’è la tragedia del Vajont, per dirti. Raccontata senza nascondere le colpe, senza manipolazioni della realtà.
Anche il tipo di letture che fate va in questa direzione?
Personalmente negli ultimi anni ho molto ridotto la quantità di romanzi contemporanei, che fino a qualche anno fa leggevo molto. Oggi leggo non-fiction, ma scritta comunque in maniera narrativa. Penso al libro di Alberto Prunetti, Amianto. E in generale a quella zona lì, quella terra di nessuno dove varie tipologie di testo si ibridano. Ci sono alcuni autori, per esempio Frank Westerman, che pubblica per Iperborea in Italia e che scrive reportage narrativi molto particolari. C’è un americano, pubblicato da Corbaccio, John Krakauer, che scrive inchieste giornalistiche con una capacità narrativa davvero forte. Una cosa che si è moltiplicata negli anni secondo me anche alla rete, e alle possibilità che questa dà anche di montare, di ibridare.
Scrittori con cui vi confrontate, in cui cercate una sponda rispetto al lavoro che fate?
Si, Alberto Prunetti è uno di questi, un compagno di strada. Poi Girolamo De Michele, Valerio Evangelisti, persone con cui c’è uno scambio proficuo di spunti, di idee. E poi una sponda naturale, da un altro punto di vista, nei territori, in aggregazioni di un certo tipo, basti vedere i posti in cui andiamo a presentare i libri, per scelta nostra: che può essere il comitato No Mous a Niscemi, i ragazzi della Val di Susa, i laboratori No-Expo.
Da questo punto di vista come hanno influito i cambiamenti degli ultimi quindici anni – Q è stato scritto più o meno all’apice del movimento No Global – sul piano narrativo, considerando anche gli interventi sull’attualità che fate attraverso il vostro blog?
Influiscono totalmente, perché il modo in cui ci muoviamo e andiamo a cercare la materia storica è condizionato da quello che ci succede attorno. L’Armata dei Sonnambuli l’abbiamo scritta in un periodo abbastanza lungo, ma che ha avuto come momento chiave, di inizio concreto della stesura, il 2011. Che è l’anno delle primavere arabe, di Occupy Wall Street, poco prima dei riots di Londra… un accrocchio di cose, durante le quali si è tornato a parlare del tema della rivolta come concetto, ed è tornato anche di attualità il tema della rivoluzione. Nel senso: quello che è successo in Tunisia, o in Egitto, sono delle rivoluzioni? Lo stesso per eventi molto più ambigui, come la guerra civile in Libia o in Siria, da cui però è emersa una rivoluzione come quella dei curdi del Rojava, che hanno fondato questa zona autonoma dove sperimentano forme di autogoverno e si difendono manu militari dagli attacchi dell’Isis. Oppure le false rivoluzioni, che in qualche modo sono solo semantiche, e che ti presentano come rivoluzionari dei miliardari, penso a quello che è successo con Steve Jobs. Noi diciamo sempre che siamo delle spugne: prendiamo ciò che ci è attorno e poi ci strizziamo sulla pagina. (riccardo rosa)


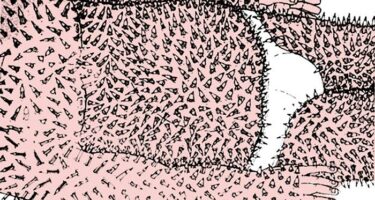


Leave a Reply