
Una sessantina di persone ascoltano e prendono parola al microfono sotto l’ombra lunga degli alberi di piazza Mengaroni, in un pomeriggio di inizio estate. Alcune donne anziane prendono il fresco, bambine e bambini che giocano a pallone, motorini sfreccianti e stereo a palla. È la stessa Tor Bella Monaca di cui leggiamo sempre e solo resoconti criminalizzanti, classisti, ma che vede un fermento di socialità popolare in continua evoluzione. A convocare l’assemblea è il Collettivo lavoratorə 21/07, formato da operatori e operatrici impiegati a vario titolo in un ente del terzo settore attivo da anni nel campo dei diritti umani, in particolare delle popolazioni rom e sinte. Fino a pochi giorni prima, per alcuni mesi, i lavoratori e le lavoratrici dell’associazione 21 luglio iscritti all’Unione sindacale di base erano in stato d’agitazione, durato fino all’ottenimento del rinnovo di alcuni contratti e l’inizio di un percorso di autoformazione e presa di coscienza sui diritti di chi lavora nel terzo settore. Sotto lo striscione del collettivo e una sventolante bandiera rom, prendono parola professioni e vertenze territoriali del mondo del lavoro di cura: badanti, insegnanti, operatori e operatrici della filantropia, Oepac (operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione), assistenti sociali, residenti del quartiere.
L’assemblea nasce dall’esigenza di creare connessioni tra chi lavora nei suddetti ambiti. C’è un intero sistema che coinvolge privato sociale, stato e finanziatori, lo stesso sistema neoliberista che produce le condizioni di sfruttamento delle professioni socio-educative e determina parte dei problemi nei contesti dove queste operano. Esternalizzando e tagliando risorse al welfare si facilita il proliferare di enti e progetti funzionali a tenere contenuti i salari e favorire la precarietà nel settore no-profit a fronte di un’emergenza perpetua, come se questi lavori debbano restare fisiologicamente temporanei. Di fatto si tratta dell’ennesima occasione di risparmio della spesa sociale pubblica sulle spalle di chi lavora. Gli stessi finanziatori difficilmente monitorano la condizione contrattuale e salariale di chi è chiamato a lavorare sui progetti. Spesso, anzi, soprattutto i bandi della filantropia privata sono tra i fattori di precarizzazione del lavoro sociale, vista la tendenza a sovvenzionare progetti brevi e attivare meccanismi che inducono gli enti a contenere i costi del personale per aggiudicarsi i finanziamenti. Ma l’odierno terzo settore sembra anche caratterizzarsi per alcune tendenze interne di sfruttamento capillare, tipico di ambienti lavorativi talmente intrisi di retorica familista da riuscire a riprodurne gran parte delle dinamiche oppressive. Pensiamo al cosiddetto mito della vocazione, ovvero l’ambiguità creata ad arte tra lavoro di cura e buon cuore dei singoli, con l’obiettivo di instillare senso di vergogna per il solo fatto di percepire (o pretendere) un salario mentre si fa del “bene al prossimo”.
Altra tendenza del sistema è quella di disinnescare la conflittualità nei quartieri. Con il Giubileo 2025 all’orizzonte – lo stesso maxi evento che sta determinando un’accelerazione nella trasformazione urbana a suon di cambi di destinazione d’uso per affitti brevi e conseguente impennata degli sfratti – e in concomitanza con la presenza di un’amministrazione di centrosinistra a Roma, il grande mondo del “capitalismo dei buoni” torna a farsi ingombrante in città. Gruppi industriali, banche, reti no-profit locali e filantropia globale, intenti a sostenere un gran numero di interventi rigorosamente “co-progettati” con istituzioni, accademia e pezzi di movimenti urbani capitolini. Sono programmi complessi – pensiamo a Periferiacapitale finanziato da fondazione Charlemagne – in grado di articolare un centinaio di enti e istituzioni attorno allo sviluppo non solo di progettualità sociali ma di vere e proprie agende politiche, miranti all’elaborazione di protocolli d’intesa con le amministrazioni, partnership pubblico-private, regolamenti d’uso dello spazio pubblico. Tra i partner di Periferiacapitale ci sono ben otto municipi romani su quindici.
Per uscire vivi da questo vortice, i livelli di azione potrebbero essere almeno tre: 1. pretendere pieni diritti per chi opera nel sociale e la più ampia reinternalizzazione pubblica di servizi e risorse; 2. supportare le forme conflittuali di mutualismo popolare a scapito della perpetuazione di modelli di mixed welfare neoliberista; 3. recuperare forme di lavoro autorganizzato e collettivo per le professioni della cura. Nel primo caso, c’è la consapevolezza che il percorso sarà lungo, ma questo non ci esime dal reclamare diritti e dignità qui e ora, organizzarci in ogni posto di lavoro, formare sindacati, collettivi, dialogare con le realtà di base e pretendere cambiamenti nell’atteggiamento di padroni, finanziatori e istituzioni pubbliche.
Per quanto riguarda il welfare nei quartieri, è legittimo dubitare che gli strumenti del privato sociale siano sufficienti. Faccio mie le parole di Juan Grabois, dirigente sociale della generazione delle lotte del 2001 in Argentina, fondatore del Movimento dei Lavoratori Esclusi, secondo il quale definizioni come “economia sociale” o “solidale” possono portarci “alla falsa convinzione che, come per magia, si possono integrare i lavoratori esclusi in imprese sociali orizzontali create in laboratorio. […] Questa fantasia può essere utilizzata come forma di legittimazione dell’ordine sociale, un rischio di fronte al quale dobbiamo stare in allerta. D’altra parte, la credenza nell’infallibilità della micro-impresa sociale è un modo anch’esso di scaricare sui lavoratori esclusi tutta la responsabilità per la propria situazione”. E più avanti mette in guardia da una serie di rischi a cui vanno incontro i movimenti: “Le organizzazioni popolari […] nella lotta per l’ottenimento delle risorse per portare avanti la propria funzione, entrano spesso in contatto con settori di potere come governi, imprese e finanziatori internazionali che impongono, direttamente o indirettamente, le loro condizioni per prestare aiuto […]. Altro rischio che sorge soprattutto quando l’organizzazione ottiene un certo riconoscimento è quello di convertirsi in una mera Ong al servizio del contenimento. In questo modo si smette di essere strumenti di lotta per la giustizia sociale” (Capitalismo de exclusión, periferias sociales y movimientos populares, 2013). Potrebbero essere parole scritte oggi, in una qualsiasi delle nostre città.
Come si evita allora di finire schiacciati nella morsa tra mercificazione e volontarismo? Uno stimolo interessante arriva dal dibattito interno alla Rete delle Scuole popolari di Roma, che ha presentato pubblicamente, nell’ultima domenica di giugno, la ricerca L’Altra Scuola (Donzelli, 2024) che indaga la Rete stessa attraverso le sue molteplici implicazioni sociali, educative e politiche. Alcuni capitoli forniscono una chiave sul possibile futuro di queste realtà, proprio nella loro relazione con il modello di terzo settore implicato nella ridefinizione privatistica del welfare propria dell’impianto neoliberista. Le scuole popolari stanno provando a tracciare una strada alternativa che però è ancora in divenire; molte di esse restano incastrate nel paradigma della sussidiarietà orizzontale, che diventa funzionale alla gestione volontaria di servizi un tempo afferenti al settore pubblico. Tuttavia il percorso di autoanalisi, di cui la ricerca rappresenta un punto di evoluzione, nonché la forte autonomia della Rete stessa pur nella sua trasversalità, lasciano intravedere prospettive incoraggianti. Essere un pungolo del welfare educativo, uno strumento combattivo, indipendente, né contro né dentro la scuola pubblica, ma come perno per scardinare le tendenze aziendaliste, performative, militariste, autoritarie, razzializzanti del sistema educativo ufficiale.
Questo ci porta alla terza questione, la necessità di organizzare in modo autonomo anche il nostro lavoro, quello delle professioni sociali e della cura. In Catalogna da molti anni esistono esperienze cooperative nate dalle lotte nel settore socio-educativo. Non sono strumenti perfetti e spesso sono soggetti a critiche interne allo stesso movimento, ma siamo già su un altro piano rispetto all’anno zero della discussione dalle nostre parti, complice soprattutto la natura padronale delle nostre cooperative sociali. Ma allora come miglioriamo i diritti delle professioni sociali smettendo di nutrire il sistema istituzionale pubblico-privato che crea esclusione nei quartieri popolari? Pensiamo alle decine di insegnanti, educatrici, operatori sociali che nel raro “tempo libero” fanno militanza politica, mettendo le proprie competenze a disposizione di esperienze mutualistiche proprio come le scuole popolari. Dovendo pagare affitti e bollette, tornano poi nei loro posti di lavoro, servendo gli stessi meccanismi che inibiscono l’autorganizzazione nelle periferie. Il circolo vizioso è servito: si lavora per la prosecuzione di un sistema che ci paga (poco), per poi andare a riparare (gratis) i danni fatti da quello stesso sistema. Alcuni provano a darsi un’alternativa, nascono realtà dentro gli spazi di movimento che tentano di portare avanti percorsi di autonomia lavorativa per le professioni sociali, ma si finisce sempre per restare incappati nella spirale del granting, andando alla ricerca di finanziatori il più possibile etici, dovendosi comunque adattare al modello di concorrenza nella corsa ai fondi per il no-profit.
Dopo la fine della seconda guerra mondiale, in alcune borgate romane e nelle campagne limitrofe, le organizzazioni proletarie realizzavano servizi basici, scuole, strade, ponti, terreni coltivati, per poi recarsi in massa a manifestare fin dentro gli uffici pubblici e reclamare un salario per i lavoratori che avevano realizzato quegli interventi. Brigate del lavoro, scioperi al rovescio, hanno rappresentato un momento breve ma significativo di un nuovo modello rivendicativo di mutualismo operaio. Il metodo funzionava e, anzi, fu una lotta necessaria a stimolare le successive mobilitazioni per la dignità delle borgate e per l’occupazione nell’ambito dell’espansione urbana capitolina. Ancora una volta, guardando alle nostre traiettorie storiche, possiamo ragionare sul momento nel quale ci troviamo. Sarà centrale la lotta per inchiodare lo Stato alle sue responsabilità, laddove siamo sempre noi a togliere le castagne dal fuoco a un settore pubblico evanescente e funzionale ai poteri privati. Sarà fondamentale dare dignità salariale e diritti al lavoro di cura informale nelle periferie. Sarà infine necessario dotarsi con la lotta di un potere contrattuale in grado di contenere le logiche di mercato nel privato sociale, se vorremo davvero contribuire a realizzare giustizia sociale nei nostri quartieri e con il nostro lavoro. (lorenzo natella)




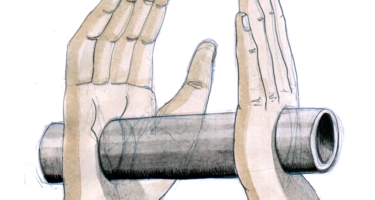
Leave a Reply