
L’appuntamento è quasi sempre a mezzanotte, non prima non dopo, nella piazza del centro storico che ospita la restaurata statua del Nilo. Ci guardiamo, qualche parola per capire che ci siamo capiti e via, inizia la ricerca. In realtà ho spesso pensato che non siamo noi a scegliere il luogo che da lì a poco sarà vandalizzato/valorizzato, ma viceversa. È come se il piperno del centro storico napoletano (che per caratteristiche storiche tipicamente meridionali tende più alla degradazione che alla autoelevazione a monumento) fosse stufo della sua immutabilità e ci invitasse a renderlo partecipe di un presente altrimenti solo osservato, dunque subìto.
Le mura dei quartieri centrali della città grondano di storia, non quella con la S maiuscola (per quanto questo possa far innervosire gli architetti), ma quella fatta di stratificazioni continue, quotidiani mutamenti. In ordine temporale le nostre pitture non sono altro che la più recente patina di modernità alla quale si vanno via via sovrapponendo inquietanti rivendicazioni di aspiranti V.i.p. / m.o.c. (magnateve ‘o cazz’) e di consolidati gruppi ultras.
Solo raramente, un massiccio quanto innocuo dispiegamento di forze dell’ordine, ti segnala con la sua bluastra presenza l’impossibilità di continuare qualunque attività illegale. Tutti se ne rendono conto (noi compresi) e si dirigono nell’oasi costituita dai vicoli bui, preservati dalle invadenti luci notturne. Quelle sono state messe nei centri storici affinché il consumo del giorno possa continuare indisturbato anche di notte, passando, senza soluzione di continuità, dal supermercato al locale notturno. Nulla si ferma, nel peggiore dei casi si rimanda al giorno dopo.
Fino a qualche anno fa, ci preoccupavamo di essere visti da meno gente possibile. Col tempo ci siamo resi conto che nascondersi ti rende più visibile. Ce lo hanno insegnato i nostri conviventi notturni: spacciatori, ladri, pali. L’odore di piscio dei vicoli, il dialetto deformato ma comunque vivo dei richiami notturni, i fischi che perpetuando antichi codici si adattano a nuovi e nichilsti commerci, gli sciami di motorini sfreccianti negli auto-imposti confini del proprio quartiere. È solo in questo humus che forme mostruose come quelle che tracciamo sui muri possono prendere vita. Non più dipinti ma scenografie dell’ennesima rappresentazione di “guardielladri”.
Dopo una breve ricognizione del territorio tiriamo fuori colori e pennelli. Bastano pochi minuti che qualcuno si accorge della nostra presenza. Si avvicinano, solitamente in gruppo e con la solita dolce aggressività. La gamma delle domande che ci vengono rivolte è assolutamente ristretta, una cartina al tornasole di un immaginario che potremmo eufemisticamente definire appiattito. «Ma ve pava ‘o comune?»; alla nostra risposta negativa parte il «Pecchè ‘o ffacite allora?». «Per passione», diciamo noi, paragonando il nostro desiderio di espressione al loro ardore per lo stadio e il Napoli, scatta un riconoscimento che rende più distesa la conversazione. Si passa da un auto-difensivo «Fratè famme scrivere ‘o nomme mje, fa’ ampress’», a un più rispettoso: «Ma comme aggià fa pe’ nun fa scorrere ‘a pittura?». Ma ciò che li induce a mettersi realmente sullo stesso piano è la repressione. Tra le domande più gettonate ci sono quelle sugli articoli del Codice Penale che ci contestano se ci beccano “le guardie”, le pene che eventualmente dovremmo scontare.
Intanto li guardo. Negli occhi, uno a uno, immaginando le case dove al termine della notte andranno a dormire. Nella maggior parte dei casi sono vasci. Case simili a tane. I tentativi di personalizzazione fatti con mille diverse rivestiture di marmo o riggiole colorate non fanno altro che rendere ogni basso uguale all’altro: nonostante tutto impermeabile alla luce solare.
In estate andammo a dipingere al pallonetto di Santa Lucia. L’andirivieni di motorini era incessante, minuscole bambine passavano e spassavano nel vicolo. Sapevamo che non ci avevano ignorato, infatti dopo un po’ si fermarono. Stavolta fummo noi a fare le domande. La prima cosa che chiedemmo fu l’età. Avevano una nove, l’altra dieci anni. Le loro gambe non toccavano terra, per fermarsi e scendere dal motorino dovevano accostare al muro. Dopo aver chiesto loro se avevano voglia di aiutarci a finire il nostro disegno, le invitammo a dirci cosa vedevano in quella figura rossa che stavano contribuendo a completare. Le loro risposte avevano inevitabilmente a che fare con il mondo della televisione. «È ‘o Gabbibbo», disse una. «È chillu cartone là… comme se chiamma?… marò nun m’arricordo», fece l’altra. Sembravano escludere il fatto che qualcuno potesse permettersi di inventare, immaginare, creare qualcosa dal nulla. Intanto era arrivato anche il fratello più grande, poteva avere al massimo quindici anni, il suo tatuaggio recitava: don’t touch my sisters. Quando si rese conto che a differenza dei suoi coetanei non lo avremmo preso in giro ci confessò la sua nascosta passione per il disegno. Ma non voleva farlo con noi, qualcuno avrebbe potuto vederlo. In questo caso vederlo sta per “sfotterlo”.
Finito di colorare la nostra creatura, la più piccola delle bambine ci chiese se poteva fare una scritta sul muro accanto. Noi acconsentimmo. Quella scritta è ancora là: il suo cognome (quello di un clan della zona) scritto maiuscolo, e sotto “siamo i più forti”. (cyro)


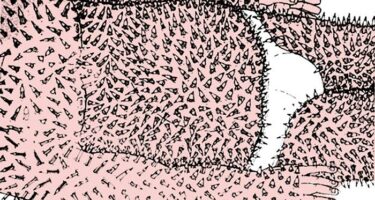


Leave a Reply