
C’era una volta la città teatrale di Napoli, col suo fermento nelle periferie e negli spazi occupati, i laboratori nelle saittelle, i suoi luoghi d’avanguardia in dissolvenza, lo Stabile (nazionale) alla mercé dei potentati, con gli attori e i registi che ormai distinguono – senza neanche troppe remore – tra il “lavoro” e il “teatro”. C’era una volta il Napoli Teatro Festival, che alla sua ottava edizione è un ricordo di se stesso. Nel 2007 si era partiti con l’idea di Edimburgo e di Avignone e invece ora, dopo De Fusco, vi beccate Dragone. C’era una volta il Comune che ha sempre una parola buona per tutti, mentre la Regione mette le mani dove e come può. C’erano una volta sei milioni di euro di fondi pubblici da “investire” per il festival. C’era una volta il pubblico. Quello che, se indovini chi vince gli Europei hai uno sconto sul (considerevole) prezzo del biglietto. C’era una volta il giovane pubblico e il giovane teatro. C’era una volta il teatro, ma in fin dei conti, a luglio, chi se ne importa più del teatro? Intanto noi stiamo andando troppo veloce, e forse ci conviene rallentare un po’.
Vi sarete accorti, chi più chi meno, che il Napoli Teatro Festival si è concluso. Ora, mentre sugli spettacoli di questo mese di programmazione poco o nulla è stato detto, molti s’impegnano a sindacare sullo sfacelo di questo festival. Come se le edizioni immediatamente precedenti fossero state le più riuscite, le più strabilianti mai viste in questa città. Questo festival non è stato poi così diverso dalle scorse edizioni e sicuramente non è stato peggio. Biglietti cari con un notevole numero di non paganti – fermo restando che in tutti i festival gli addetti stampa e i giornalisti non pagano, non è una novità. Come pure non lo è stata la definitiva chiusura della rassegna a spazi non convenzionali in favore di luoghi canonici: i soliti teatri (Mercadante, San Ferdinando, Teatro Nuovo, Galleria Toledo, Augusteo, Politeama, cui quest’anno si sono aggiunti il Bellini e il Diana) che hanno prolungato la loro stagione, mentre gli spettatori sono letteralmente morti – con gente che nel mezzo degli spettacoli lasciava la sala – di caldo. In questo tran tran, con un programma troppo lungo, troppo fitto, e orari incastrati tra loro in maniera meno che pratica, è mancato un punto nevralgico, un luogo fisico dove semplicemente fermarsi, incontrarsi, chiacchierare; e dove potrebbe formarsi o ritrovarsi quella cosiddetta “comunità teatrale” fatta di pubblico, addetti ai lavori, compagnie che è poi l’anima di un festival; ma questa mancanza, ancora una volta, non è una novità.
Una novità, invece, è che quest’anno, almeno in parte, il programma aveva un minimo di senso. Da Black Clouds del trentaduenne belga Fabrice Murgia, dedicato a Aaron Schwarz, giovane hacker americano suicidatosi sotto la minaccia dell’FBI; a Ubu and the truth commission, lavoro ancora oggi attualissimo che il regista sudafricano William Kentridge mise in scena a soli tre anni dalla fine dell’apartheid; a Flexn con cui il coreografo americano Peter Sellars porta sul palco la street dance della sottocultura afro delle periferie di New York; al Machbeth africano di Brett Brailey: tutti lavori legati da un filo rosso politico piuttosto evidente. Allo stesso tempo, si è trattato di messe in scena “spettacolari”, come per la gran parte del programma: con allestimenti sontuosi o macchinosissimi – penso a Les anguilles et l’opium di Robert Lepage o allo stesso Flexn – e abbastanza datati (ma questa nemmeno è una novità). Non ci sarebbe, del resto, niente di male nel fatto che il cospicuo budget su cui il festival può contare possa essere usato anche – ma non solo – per allestire spettacoli che normalmente sarebbe impossibile vedere (se c’è una cosa di cui il teatro in tempi di crisi fa a meno è proprio l’allestimento). È il caso de Le grenouille avait raison, uno sconfinamento onirico e semplicemente meraviglioso nella danza e nella fantasia, tra trapezi altissimi e una vasca in scena ideato e interpretato, tra gli altri, da James Thierrèe, danzatore e acrobata nipote di Charlie Chaplin. Come pure, parlando di danza, forse il lavoro più notevole di tutto il festival è stato presentato al Teatro Nuovo da Ali e Hedi Thabet, due fratelli di origine tunisina che, con la musica dal vivo di una piccola orchestra greco-tunisina, hanno sorpreso i pochissimi spettatori (e zero giornalisti della carta stampata) con narrazioni danzate estremamente emotive e carnali.
Il punto, a parte una questione di gusti, è che sul territorio cittadino di tutto questo non rimane nulla; se consideriamo anche la presenza in città di un teatro stabile nazionale che tutto fa tranne il lavoro di un teatro pubblico, il festival rafforza un grave paradosso: i soldi ci sono, resta da capire come vengono utilizzati. Un’altra novità è stato il tentativo di allargare il festival al resto della Campania con alcuni progetti di residenza; anche qui il nodo è lo stesso: manca una progettualità che incida sul territorio, che getti dei semi che vadano oltre lo spostamento tout court dello spettacolo e poi, a lavoro finito, arrivederci e grazie.
Mettendo da parte i big della programmazione nazionale – Emma Dante (lavoro importante il suo Verso Medea ma più che datato nella vasta produzione della regista siciliana), oppure la letterale presa di fondelli di un Eugenio Barba ormai stanco e imborghesito che, piedi scalzi e camicia di lino, ci tiene a specificare che il motivo principale per cui ha accettato di partecipare al festival (ancora non abbiamo capito bene per fare cosa) è stato il cachet – un appunto di interesse va su parte della programmazione nostrana: al di là degli esiti – si tratta di debutti assoluti e di lavori che inevitabilmente devono rodare – la programmazione presenta tre delle realtà più rappresentative del panorama napoletano: Lello Serao, Imma Villa e Carlo Cerciello con Animali Notturni; Il cielo in una stanza, nuovo lavoro di Punta Corsara, compagnia ormai affermata anche sui palchi nazionali; Il servo, in cui notiamo il curioso sodalizio Teatri Uniti/Casa del Contemporaneo con la regia di Pierpaolo Sepe e in scena, oltre agli ormai consolidati Tony Laudadio e Andea Renzi, Lino Musella, forse una delle più valide promesse napoletane in circolazione. Con questi fanno il pari il debutto di Alessandra Asuni e Marina Rippa con La casa di Bernarda Alba in residenza a Sant’Angelo dei Lombardi e Frankenstein ‘o mostro di Sarasole Notarbartolo e i Posteggiatori Tristi. Ma, tanto per dirne giusto altri tre, dove stanno Moscato, Borrelli, Latella? Dei giovani – penso alla sezione fringe – anche quest’anno si sono perse le tracce, fatta eccezione per l’improbabile show dei Foja diretti dallo stesso Dragone al San Carlo. Tra i pro e contro, forse la vera differenza sta proprio nel modo di raccontare tutto questo: botta e risposta tra Dragone e Grispello a mezzo stampa, voci incontrollate, lettere alla città, interviste di servizio, articoli accusatori che francamente sorprende vedere pubblicati solo oggi, mentre magari Mr. De Fusco se la ride sotto i baffi, sfregandosi le mani.
C’era una volta il teatro, quella specie di rito strano che chi pratica veramente non vuole troppo spiegare. C’era una volta Napoli e il suo Teatro Festival che, sia per capitale economico e soprattutto per capitale culturale, potrebbe eguagliare, forse superare, tutti gli altri festival che affollano la stagione estiva italiana. E invece la realtà è che pure quest’anno è andata così, con i soliti signori di turno che dall’alto delle loro poltrone si rimpallano le responsabilità, mentre noi con il lanternino cerchiamo le migliori combinazioni tra quello che passa il convento. Il vero teatro è (anche) questo. (francesca saturnino)


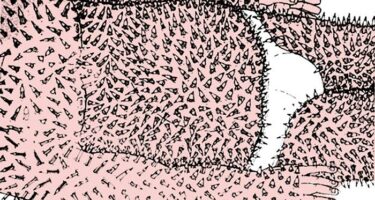


Leave a Reply