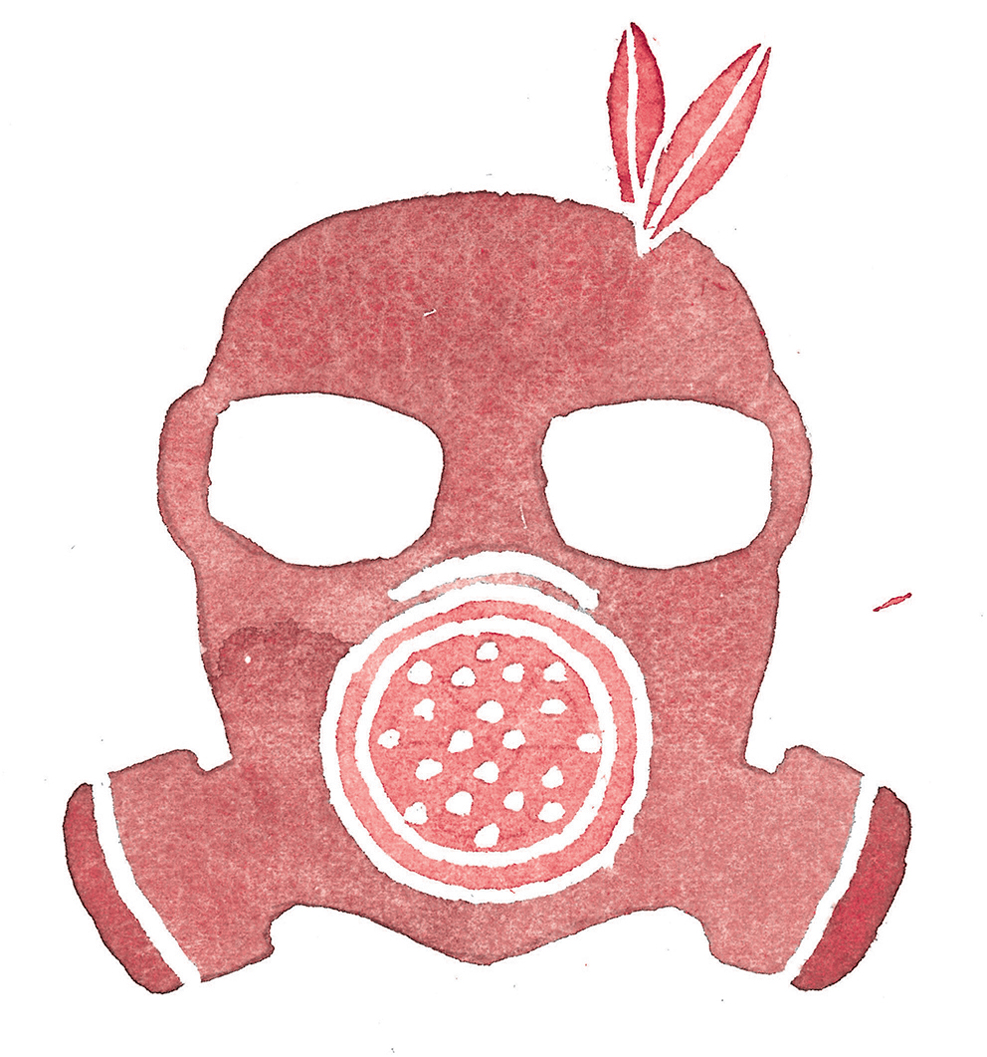
Sentiremo dire che la COP28 appena conclusa a Dubai è stata un successo. Che gli impegni presi sono ambiziosi, che la politica di negoziazione multilaterale basata su contributi volontari funziona, che i timori per una Conferenza diretta da un petroliere in un paese a trazione petrolifera erano infondati. Gioite, cittadini del mondo, un altro accordo globale sul clima è stato consegnato alla storia. Ora tornate a lavorare. O al massimo a consumare.
La COP28 era chiamata ad approvare il global stocktake, una componente fondamentale dell’Accordo di Parigi che ne monitora l’attuazione valutando i progressi collettivi. E su quella base, il mandato della COP era di rilanciare e di aumentare l’ambizione degli obiettivi, fornendo indicazioni chiare sui paletti e sviluppando efficaci meccanismi per convogliare le risorse economiche necessarie. Ma a Dubai, più che il clima, è stata al centro la geopolitica.
Il braccio di ferro tra paesi ricchi e impregnati di combustibili fossili e paesi poveri, che quei combustibili vorrebbero usarli per sviluppare le basi minime di vivibilità ha attraversato la Conferenza fino ai minuti finali. La pressione continua di società civile e governi progressisti ha messo al centro dei negoziati la causa principale della crisi climatica, e nel documento finale si menziona l’obiettivo condiviso dell’“abbandono dei combustibili fossili nei sistemi energetici”. Tuttavia, il banco di prova consisteva non solo nel menzionare i combustibili fossili per la prima volta dopo trent’anni di omissioni, ma di progettarne la fine in maniera puntuale, consegnando un impegno collettivo senza equivoci, sotterfugi o scappatoie che aprano a ritardi e inazione. Si doveva assicurare che i paesi inquinatori più ricchi – Stati Uniti in testa, seguiti da Canada, Australia, Norvegia e Regno Unito, responsabili del cinquantuno per cento dei nuovi progetti di estrazione di petrolio e gas pianificati entro il 2050 – fossero anche quelli più rapidi nel conseguire la fuoriuscita dal fossile, obbligando allo stesso tempo tutti i paesi sviluppati – storicamente i più responsabili della crisi climatica – a elargire risorse economiche concrete a favore della transizione nei paesi in via di sviluppo. Non è accaduto. Il successo tanto millantato è stato un fallimento.
Come spesso accade alle COP, pochi paesi insieme all’industria fossile tengono il pianeta in ostaggio. L’accordo è semplicemente il minimo comune denominatore per farli contenti e al contempo illudere la società civile di progressi inesistenti. È un compromesso al ribasso tra il preservare la vita sulla Terra e i profitti che ancora si possono spremere dalle sue viscere. Il rifiuto di fornire i finanziamenti pubblici necessari per realizzare una giusta transizione energetica e la continua espansione ed esportazione di combustibili fossili è schizofrenia, o malafede. Senza dimenticare come le “grandi democrazie” spendano miliardi in guerre e militarizzazione che rendono il mondo ancora più instabile, e rimarcando come si siano prodigate di generoso supporto al genocidio in corso in Palestina. Con tali presupposti, quale fiducia si può concedere a questi “bravi ragazzi”?
Almeno i mercati di carbonio – quelli dei permessi a inquinare, dei crediti e delle compensazioni, una maledizione inefficace dal punto di vista climatico che precipita violentemente nei territori di popolazioni indigene e comunità rurali – non sono stati assimilati alla finanza climatica. Ma era il minimo. Banalmente, non importa quanto le compensazioni di carbonio verranno “migliorate” per assicurare i risultati di assorbimento dei progetti. Fintantoché verranno utilizzate per “compensare” la produzione e l’uso dei combustibili fossili non aiuteranno mai a ridurre le emissioni globali.
Non c’è alcun impegno per raggiungere il picco delle emissioni entro il 2025. Gli obiettivi di triplicare le energie rinnovabili e di raddoppiare l’efficienza energetica sono un timido progresso, ma richiederanno un duro lavoro per essere implementati e rischieranno di essere controbilanciati se la spinta per il gas continua. Nel documento finale è stata riesumata la frottola dei “combustibili di transizione” per far piacere ai produttori di gas fossile. Questi combustibili dovrebbero “facilitare” il cambiamento dei sistemi energetici. Come se si volesse liberare dalla dipendenza un alcolizzato facilitandogli l’accesso all’alcol. Il governo Meloni, pur nella sua insignificanza nei dibattiti alla COP, avrà preso nota della riabilitazione del gas, ora che è alle prese con piani energetici che puntano a trasformare l’Italia in hub del gas e con il piano Mattei per appropriarsi del gas africano, autorizzando al contempo trivellazioni nei nostri mari e finanziamenti a progetti estrattivi all’estero.
Le tecniche di geoingegneria – modificazioni su larga scala del sistema climatico – hanno il loro momento di gloria nella dichiarazione finale: ora diventano “strategie di intervento climatico”. Ne sentiremo certamente parlare quando i piani di mitigazione approntati finora mostreranno tutti i loro limiti. E poco importa che manipolare la stratosfera o gli oceani non tocca le cause strutturali della crisi, ma ne aumenta a dismisura i rischi.
E non potevano mancare i riferimenti multipli alla cattura e allo stoccaggio di carbonio, un altro regalo all’industria fossile per farla rimanere a galla, dispositivo tecnologico per mantenere in funzione non solo le fonti fossili tradizionali, ma anche tutta una serie di nuovi aggeggi come l’idrogeno “pulito”, l’ammonia “blu”, il gas “a bassa intensità di carbonio”.
Ogni nota positiva sembra stonare nel confronto con la realtà. Il fondo Loss & Damage (per le perdite e i danni inevitabili causati dal riscaldamento climatico) è stato approvato il primo giorno della COP, tra pacche sulle spalle e sospiri di sollievo. Bene. Però, i milioni impegnati da (pochi) paesi sono una goccia nell’oceano, insufficienti per compensare i disastri che si moltiplicano sotto la spinta degli eventi estremi, e per fronteggiare le violazioni dei diritti umani che le comunità soffrono a causa di decenni di inazione climatica. Male. Mancando meccanismi che obbligano i paesi a elargire risorse per il fondo, finanziarlo è assimilato a un gesto di beneficenza di cui ci si può vantare. Anche se il fondamento della sua esistenza è una questione di giustizia: ripagare il debito che i paesi piú responsabili della crisi devono al mondo, e ai paesi poveri in particolare, per aver occupato lo spazio atmosferico comune piú e prima degli altri.
Me se neppure il massimo organo di negoziazione globale per pianificare il percorso verso la stabilità climatica in spirito di giustizia riesce a liberarsi dalla morsa di potenti interessi nazionali e di gruppi di lobbisti dell’industria fossile, è forse arrivato il momento di mezzi alternativi per gestire il declino e la fuoriuscita dai combustibili fossili, liberi da tali influenze. Un accordo vale quanto la sua applicazione, ha ripetuto Sultan Al Jaber, il presidente della COP. Vero, e se l’accordo è diluito e sgangherato, non all’altezza, figuriamoci le mezze misure e i timidi passi che ne conseguiranno, nell’assenza di meccanismi obbligatori di implementazione.
Un altro dato rilevante è che le libertà della società civile durante il summit sono state pesantemente limitate. Un nuovo processo collettivo a detenuti politici degli Emirati è iniziato proprio durante i giorni di apertura della COP, sotto il naso della comunità internazionale. La polizia delle Nazioni Unite, responsabile per la sicurezza alla COP, ha minato la libertà di parola dei gruppi della società civile, soprattutto in relazione alle proteste per la guerra a Gaza e per la questione dei diritti umani nei paesi del Golfo.
È stata una COP delle pubbliche relazioni, in cui il paese ospitante doveva uscirne positivamente, sia con i paesi ospitati sia con le aziende petrolifere interne ed esterne. E ci è riuscito. L’ipocrisia la fa da padrona. Emergono tutti i limiti nel trattare il finanziamento per le perdite e i danni inevitabili come beneficenza piuttosto che come obbligo. La stessa ipocrisia ha minato ogni possibilità di ottenere un risultato ambizioso sull’eliminazione dei combustibili fossili. Senza supporto economico per i paesi in via di sviluppo, la governance globale del clima diventa un ulteriore strumento di dominio del Nord verso il Sud, attraverso obblighi di disciplinamento fiscale e politico simili a quelli esercitati dal fondo monetario internazionale e dalla banca mondiale negli anni bui degli aggiustamenti strutturali, un altro nome per le politiche neocoloniali.
Come hanno ricordato le manifestazioni nei padiglioni COP, prontamente sgomberate dalla polizia delle Nazioni Unite, non vi è giustizia climatica senza rispetto dei diritti umani. Uno dei pochi momenti di verità è stata la chiamata dei gruppi della società civile per un cessate il fuoco immediato e permanente, e per la fine dell’occupazione israeliana e del regime di apartheid che ha istituito in Palestina, urlata in faccia a quegli stessi paesi ricchi che hanno difeso unicamente i propri interessi alla COP, e che stanno limitando il diritto di protesta e di critica nei loro regimi nominalmente “democratici”, che sia verso la gestione del clima o verso il fascismo di Israele.
Ma il vero pericolo dell’esito “positivo” finale della COP28 per come viene raccontato è che sembri che qualcosa sia stato raggiunto. Dopo ventotto anni, si è semplicemente riconosciuto l’ovvio: che dobbiamo abbandonare i combustibili fossili.
La COP, nella sua forma attuale, non affronterà mai in modo efficace questa situazione che va oltre la semplice emergenza. L’atto più trasformativo che i delegati della COP potrebbero fare lasciando Dubai è ammettere, anzi proclamare, esattamente questo. Le COP sono seconde solo agli incontri di Davos per numero di miliardari presenti, e ciò vorrà pur significare qualcosa. Per contrastare l’impressione che nella frenesia delle pubbliche relazioni questi vertici siano in qualche modo un successo, vanno delegittimati per aprire altre strade. (salvatore de rosa)





Leave a Reply