
È morto ieri a Napoli, a novantaquattro anni, il pittore Armando De Stefano. Nel 2011 l’avevamo incontrato, pubblicando poi l’intervista sul cartaceo n.43 di Napoli Monitor, in concomitanza con l’inaugurazione della sua mostra “L’urlo del Sud” al museo Madre.
* * *
Abbiamo fatto visita a uno dei pittori più importanti che la nostra città abbia generato, Armando De Stefano. È stato in una mattina di inizio luglio. Poi abbiamo lasciato sedimentare tutta l’estate e, caso vuole, la scadenza di consegna è coincisa con l’arrivo delle piogge. Così, mentre stiamo per rincasare e metterci al lavoro con i libri che De Stefano ci ha regalato dopo l’intervista, il cielo inizia a tuonare e a illuminarsi di fulmini, l’acqua arriverà da lì a poco. Per ripararci – non vorremmo che i libri si rovinassero – ci avviciniamo a un palazzo che dà su via Medina e come per magia si apre una porta automatica. È l’area prelievo di una banca chiusa, ma le porte di vetro permettono di vederne l’interno illuminato. Un luogo desolato come una tela di Hopper, dal quale anche gli ultimi avventori sono fuggiti. Fuori la pioggia insiste e allora, sfruttando la lampadina del bancomat, sfogliamo ancora una volta i cataloghi. Alcuni contengono lavori degli anni Sessanta, altri opere più recenti fino all’ultimo Chameleons. Lo scroscio di una pioggia ormai in dirittura d’arrivo accompagna il nostro silenzio estasiato.
Quando non riesci a trovare le parole significa che sei di fronte a una poesia compiuta, quella cosa a cui non potresti aggiungere o sottrarre nulla. Per questo preferiamo rimandare il lettore alla visione diretta delle opere di De Stefano, in una di quelle troppo rare occasioni che la città offre ai suoi artisti, anche a quelli migliori o, a prestare attenzione a quanto qui da noi trascritto, rubando impuniti dalla sua voce.
«Io sono nato nel 1926. Ho avuto una formazione un po’ diversa da quelli della mia generazione, non parliamo di quelli venuti dopo. Quando ero alle scuole elementari avevo uno zio che era un bravo scultore, si chiamava Francesco Parente, e mi seguiva ogni tanto. I disegni che fanno i bambini non li ho mai fatti; mi sarebbe piaciuto fare la casetta, la luna, e invece no, mi hanno messo davanti i calchi di gesso classici, la testa di Bruto… fin dall’infanzia il mio rapporto con l’arte è stato questo. Ho avuto una grande passione per pittori come Morelli, Toma, e poi un grande amore, che è stato anche formativo, per Vincenzo Gemito. Ho amato molto il disegno, inteso come indagine dello spazio, rapporto tra vuoto e pieno, architettura dell’umanità… Quando insegnavo all’Accademia, ai miei ragazzi facevo disegnare i capelli, ma non in senso naturalistico; facevo tutto uno schema architettonico e geometrico, e infine arrivava l’immagine. Di un carro che passa sulla neve, lascia la traccia e se ne va, per me è più importante la traccia del carro.
«Le scuole elementari le ho fatte a piazza Mercato, poi quando ci siamo trasferiti da via De Pretis a piazza Dante mio padre mi ha iscritto all’istituto magistrale Margherita di Savoia, a salita Pontecorvo. La mia ambizione però era iscrivermi al liceo artistico, allora c’era il mito di queste scuole, da questi istituti uscivano ragazzi con certe barbe, con un’aria bohemien… Per fortuna mi accettarono al liceo artistico, eravamo una trentina di ragazzi divisi in due classi. In tutto questo era in corso la guerra. Con la mia famiglia eravamo sfollati ai Camaldoli, in mezzo alla campagna. C’era bisogno di soldi, si comprava tutto in nero, così ci ricordammo che un amico di mio padre era copista della Tate Gallery. Mi prese a fare disegni e mi insegnò delle tecniche sofisticate. Inoltre mi ripeteva sempre che gli inglesi, gli americani amavano il ritratto. Così un giorno dissi a mio fratello, che parlava un po’ d’inglese: “Stammi a sentire, prendiamo un po’ di carta, le matite e andiamo dove stanno le batterie, dove prima stavano i tedeschi e mo’ ci stanno gli americani”. Non l’avessimo mai fatto! Ci prendevamo cinquanta lire a ritratto, ci facemmo un sacco di soldi, la situazione economica della mia famiglia cambiò.
«Tornai a Napoli che la guerra era finita, ma c’erano i bombardamenti tedeschi che erano peggio di quelli americani. Volevo andare all’Accademia, che però era stata requisita dagli americani e tutti quei corridoi erano diventati corsie d’ospedale. Un colonnello americano mi vide disegnare e mi invitò alla Standa, a via Roma, che era stata requisita: “Ti diamo uno studio e trecento hundred lire”, perché gli americani stampavano i soldi. Mi pigliai il cavalletto e me lo portai alla Standa. Poi ebbi una chiamata per fare il ritratto al comandante della V Armata che stava al fronte di Cassino. Prendemmo il cavalletto, la tela e tutto, salimmo su una camionetta e andammo a Cassino. Le bombe scoppiavano da tutte le parti. Mi portarono sotto la tenda del generale. Io avevo solo diciassette anni. Il generale mi fece dire dall’interprete: “Guardi, adesso le lascio la mia giubba, lei comincia a fare la giubba”, prese la giubba e la buttò sulla sedia; e come faccio con la giubba sulla sedia, se dovevo farla addosso a lui? Per fortuna c’era un soldato che somigliava al generale, gli misi addosso la giubba, il soldato mi fece da modello per la parte di sotto… La ricompensa fu di mille hundred lire. Un ritratto a olio. Dopodiché gli americani cominciarono ad andare verso la linea gotica e il lavoro finì.
«A quel punto mi ricordai di saper suonare il pianoforte. Una sera, in un locale dove mancava il pianista, mi proposi: “Io non sono granché però se volete sono a vostra disposizione”. Mi misi al pianoforte e andò benissimo. Da quel momento cominciai a guadagnare facendo il pianista e questo durò fino al 1950, data in cui ebbi l’assistenza al liceo artistico. Dopodiché incontrai un gruppo di giovani, che poi si chiamavano Renato De Fusco, Raffaele Lippi, e demmo vita al Gruppo Sud, aiutati da una rivista che si chiamava Sud, diretta da un nostro compagno che si chiamava Pasquale Prunas.
«A via dei Mille c’era un bar che si chiamava Moccia, la sera ci riunivamo pittori, scrittori e registi, c’eravamo noi del Gruppo Sud, poi venivano Vittorio Viviani, La Capria, Ortese. Abbiamo avuto in quel periodo l’illusione che Napoli potesse avere un avvenire di grande evoluzione, questo rapporto tra pittori e scrittori faceva pensare alla Parigi di fine secolo. Ma tutto finì molto in fretta, la rivista di Prunas chiuse, tra di noi ci fu una scissione, perché nel ’46 io e Lippi ci iscrivemmo al partito comunista, gli altri invece andarono nel Mac, si diedero all’arte astratta.
«Il partito comunista si è suicidato, non c’è stata nemmeno una guerra come per il fascismo, è stata proprio una mancanza di ossigeno, ed è finita così. Però, per noi ragazzi di quell’epoca lì, è stato un grande partito: ci ha insegnato a vivere, ci ha insegnato a parlare, ci ha insegnato a stare tra la gente, noi andavamo nelle risaie a disegnare, tra i contadini della Calabria, c’è stato il rapporto con questa umanità che poi nel nostro lavoro si riconosceva, insomma per me è stato formativo in maniera eccezionale, non lo rinnegherei per nessuna cosa al mondo e ne parlo con molto entusiasmo.
«Nel 1962 avemmo l’occasione di incontrare il pittore inglese Francis Bacon, che esponeva alla biennale di Venezia, senza successo peraltro, perché gli inglesi avevano il culto di Henry Moore e di Sutherland. Andammo a mangiare insieme e lui ci disse: “Guardate ragazzi voi avete sbagliato con il neorealismo, perché voi credete che l’uomo abbia una sola faccia ma non è vero, oggi l’uomo ha un’infinità di sfaccettature, di contraddizioni, anche dal punto di vista sessuale, per cui bisogna indagare in profondità, ma non in relazione alla politica e alla società, voi dovete indagare l’uomo per quello che è”. Questa fu una lezione enorme. Da quel momento abbandonammo il neorealismo e trovammo una strada che chiamammo neofigurazione. L’immagine esisteva sempre, ma non era definita in maniera realistica, era appena suggerita. Questa è stata, per la mia generazione, la spaccatura tra arte concreta e neorealismo. Tutti noi amavamo la pittura, c’era lo scontro, ma non c’era nessuna ragione di odiarsi. Lippi era il più grande, aveva diciotto anni più di me, veniva da una famiglia tragicamente povera, mentre io venivo da una famiglia piccolo borghese. Lippi per dipingere faceva i guanti, così un giorno dissi al professore Brancaccio, che allora era il direttore dell’Accademia: “Professore noi non possiamo permettere che un artista come lui stia in mezzo alla strada a fare i guanti, se abbiamo la possibilità di dargli uno stipendio come assistente, lo dobbiamo fare”. Brancaccio, da uomo di destra quale era, mi disse soltanto: “Ma non è che mi stai facendo la cellula comunista dentro all’Accademia?”. “Professore, questi devono mangiare, quale cellula comunista”. E così Raffaele Lippi entrò al Liceo artistico. Poteva diventare titolare, ma rimase assistente tutta la vita. Era una persona adorabile, fu un’amicizia vera.
«Negli anni Settanta io a Napoli non c’ero, me ne andai a Milano. Ebbi una sala alla Quadriennale di Milano, i galleristi videro questa sala e mi fecero il contratto. È durato fino alla fine degli anni Ottanta. Lavoravo per una galleria che si chiamava Trentadue, in via Brera. Il mio ambiente era quello dei “guerreschi”, pittori figurativi espressionisti. Poi la galleria chiuse, per poco tempo andai in un’altra galleria a Monza, ma capii che non era il caso e me ne tornai a Napoli.
«Nonostante l’esperienza milanese devo riconoscere che oggi Napoli è importante quanto Milano, forse più importante. Ci sono gallerie di livello internazionale, che io non condivido ma non posso rinnegare. Poi un critico come Bonito Oliva, discutibile quanto vuoi ma senz’altro uno dei più importanti al mondo, viene da Salerno, è meridionale. Tutte queste cose hanno fatto si che l’atteggiamento verso la nostra città sia cambiato. Non è più la Napoli degli anni Cinquanta. Questa città disprezzata, oggi ha una sua identità dal punto di vista delle arti figurative. La Napoli di ogni giorno fa schifo, è abominevole, però la classe intellettuale e artistica si salva, è fuori da questo schifo. Non mi sentirei di dire che Napoli è arretrata, con tutte le carenze che ha ci sono persone di prim’ordine».
Ci parla delle sue opere, in particolare dei cicli dedicati a personaggi storici?
«Quando dipinsi il ciclo di Marat avevo già fatto quello di Masaniello, che rappresentava un rivoluzionario che era stato assorbito non dai nemici, ma dalla stessa rivoluzione; lui fu ammazzato dai suoi stessi compagni, nel cortile della chiesa del Carmine. Da qui arrivai a Marat, con un livello diverso perché Masaniello era un pescatore e Marat era una persona coltissima, che fu ammazzato da Carlotta Corday, non un’amica dei monarchici ma una rivoluzionaria anche lei; insomma volevo indagare su questi personaggi che erano stati assorbiti dalla stessa rivoluzione.
«Il ciclo sulla rivoluzione del 1799 è nato negli anni Settanta, studiando Croce e Cuoco. È stato il momento più importante della storia di Napoli, coevo alla rivoluzione francese e a quella americana, solo che i giacobini ebbero il torto di usare un linguaggio che non era quello del popolo, ma quello aulico del Settecento. La povera Eleonora Pimentel de Fonseca, scrittrice e giornalista di grande valore, diceva: “Dovete parlare il linguaggio della gente, la gente non ha capito niente, i lazzaroni non hanno capito”. Nel 1999, durante un convegno sulla rivoluzione napoletana, uno storico francese diceva che i francesi quando hanno fatto la presa della Bastiglia con la ghigliottina in mezzo alla piazza, odiavano sia Luigi XVI sia Maria Antonietta; allora la rivoluzione fu possibile, ma come poteva avvenire in una Napoli che amava Ferdinando IV, amava Maria Carolina, amavano perfino Nelson…
«Il ciclo intitolato l’Eden degli esclusi, esposto a Palazzo Reale a Napoli nel 1997, si riferisce invece all’umanità rifiutata, non solo ai poveri, ma anche a quelli che volontariamente si escludono da questa società, perché rifiutano un ordine sociale e preferiscono dormire coi cani, stare in strada…».
Ci sono artisti con i quali ha affinità?
«Io voglio molto bene a Mario Persico. È una persona colta, intelligente e lavora seriamente, anche se non facciamo cose che hanno un rapporto fra loro, ho per lui una grande ammirazione. Lo conosco da più di cinquantacinque anni. Non è uno snob, è uno che ha sofferto e questo gli conferisce una grande umanità. Uno che dipinge è importante che studi, che legga, perché c’è in giro una massa di ignoranti… Tra gli artisti viventi, l’unica persona con cui mi sento di parlare serenamente e sinceramente è Mario Persico, per il resto sono una massa di ipocriti e di falsi, non mi interessa nessuno, non artisticamente, ma umanamente».
Lei pensa di aver avuto un riconoscimento adeguato dalla sua città?
«A dire la verità io me ne sarei potuto andare in Germania, in Spagna, in America, ma non mi sentivo di lasciare questo paese, perché avendo questa visione così legata all’umano, realistica, avevo bisogno di incontrarmi con questa gente che trovo solo qua: ai Tribunali, a Sant’Antonio Abate, a Forcella. Io mi sono trovato all’estero e le facce non mi interessavano proprio. Ho bisogno di avere i volti di questa terra. Infatti lavoro a un ciclo che si chiamerà Terronia. Avrei potuto fare tanto di più andando all’estero, in Spagna soprattutto, perché ho delle affinità con gli spagnoli, ma voglio stare qua e morire qua. Questa terra, con tutti i difetti che ha, la sua storia la tiene sulla strada, nelle altre città tu devi andare nelle biblioteche, invece qua la storia è stratificata, come se stesse nel sottosuolo, tutto quello che è accaduto lo avverti agli angoli delle strade. Il problema è che molti napoletani si sentono ospiti, e questo ti spiega perché sporcano, scassano… Credono di fare danno al potere, perché il loro potere sono stati gli angioini, i francesi, i tedeschi, gli spagnoli, loro non hanno mai sentito questa città come propria, sono come ospiti in una città che apparteneva ad altra gente».
Quante ore al giorno lavora?
«Mi alzo alle sei e mezza, faccio colazione e lavoro fino a mezzogiorno, l’una; poi mi riposo e se necessario continuo il pomeriggio. Naturalmente quando ero giovane lavoravo molto di più, ora ho una gamba che mi fa male e l’ortopedico mi dice: “È colpa sua, lei ha lavorato una vita intera in piedi”, ma io non so lavorare seduto. Poi quando lavoro devo avere i dischi che suonano, mi danno suggerimenti, perché è la stessa cosa, sono differenze di linguaggi, di strumenti, ma le emozioni sono sempre quelle. In questo periodo ascolto musica del Settecento, Scarlatti, Bach, ma di solito ascolto jazz, sono molto legato a Evans, Jarret, all’amico che suonò alla mia mostra, Enrico Pieranunzi…». (cyop&kaf / luca rossomando)


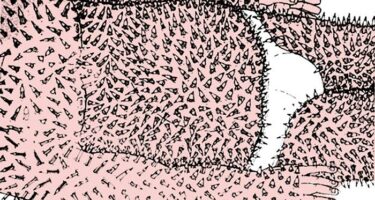


Leave a Reply