
Il caso Embraco è sulla bocca di tutti. Nell’ultimo mese la decisione dell’azienda brasiliana, società controllata dalla multinazionale Whirlpool, di chiudere lo stabile di Riva presso Chieri, in provincia di Torino, ricorre nei notiziari, nei dibatti pubblici e nell’agenda del governo uscente. Questo clamore, questo interesse mediatico per la disperazione di 497 famiglie ha qualcosa di buffo. Fa sorridere che una catastrofe annunciata, l’ennesima, venga raccontata dai più come un fulmine a ciel sereno. Al contrario, la vicenda di Embraco ha radici lontane, a partire dal 2001, anno della prima “razionalizzazione” per delocalizzare la produzione in Cina e in Slovacchia, dove la manodopera costa meno. Per la Slovacchia, la ragione della svolta è indicata esplicitamente nella possibilità di usufruire di incentivi e sgravi fiscali messi in campo da Unione europea e Slovacchia stessa al fine di accelerare il processo di industrializzazione.
Inizia così, morbidamente, il progressivo smantellamento dello stabilimento italiano, attraverso chiusura di linee, cassa integrazione e mobilità con accordi firmati da gran parte dei sindacati confederali. Una prima resistenza vede la formazione nel 2001 di un coordinamento di cassintegrati. Nel luglio 2004 la prospettiva di nuovi tagli conduce i lavoratori, ormai ridotti a 924 unità su 2500, al blocco degli straordinari e a una giornata di sciopero con picchetti ai cancelli. Nei mesi successivi gli operai bloccano il trasferimento dei macchinari dall’azienda.
Allora la crisi fu gestita più sobriamente, accompagnata dal clamore solitario di quotidiani locali e chiacchiere di paese: l’azienda ridusse al minimo i licenziamenti grazie all’esito “positivo” di una trattativa lampo, due settimane, con il governo. Alla Embraco furono concessi copiosi finanziamenti regionali, quasi otto milioni di euro includendo l’acquisto di una parte dello stabile; statali, cinque milioni di euro; e provinciali, cinquecentomila euro, per ammortizzare la crisi continuando la produzione, seppur dimezzata, auspicando così di poter garantire salari e tutele. Il risultato di questa prima grande crisi è già paradossale considerando i circa tredici milioni di euro di finanziamenti pubblici: 420 esuberi e cicli di cassa integrazione per tutti i dipendenti “salvati”.
Da questo momento in poi l’utilizzo di ammortizzatori sociali e di turnazioni tra cassa integrazione e lavoro saranno la quotidianità della fabbrica. Il gioco per la multinazionale è vincente: fare leva sull’imprescindibilità dei propri mezzi di produzione per la stabilità economica del territorio al fine di ottenere con facilità finanziamenti pubblici utilizzando il ricatto dello smantellamento.
Nel 2014 il copione si ripete identico e l’azienda a fronte di una minaccia di licenziamenti collettivi ottiene due milioni di euro dalla regione Piemonte per continuare a rianimare la produzione. In questi tredici anni, al di là delle due grandi crisi, i dipendenti sono diminuiti fino a 537 unità, circa un quinto di quelli assunti in periodi di pieno regime.
Nel novembre 2017 la controllata Whirlpool annuncia un ulteriore blocco di licenziamenti. Un crescendo di comunicati che tocca il suo culmine all’inizio del 2018 con l’intento di formalizzare cinquecento esuberi tramite licenziamento collettivo. Da questo momento in poi si crea una narrazione dicotomica della vicenda: da una parte l’Embraco, impersonificazione industriale del male, carnefice inarrestabile, dall’altra i dipendenti in attesa della lettera di licenziamento circondati da una schiera di solidali appassionati, vittime impotenti del massacro.
Arriva prima la gara di solidarietà di partiti ed esponenti politici, seguita dalla cronaca personalista e vittimizzante dei media che incentrano la questione sulle storie private delle famiglie coinvolte facendo a brandelli la loro dignità, per giungere infine alla discesa in campo del governo.
Intanto i lavoratori della fabbrica provano ad arrivare dappertutto, dal Papa a Sanremo, da Salvini a Di Maio, bramosi della visibilità come se questa potesse ribaltare le loro sorti, genuinamente convinti di vivere in un paese capace di difendere e dare giustizia a chi ha ragione davvero. Instancabili sono presenti in presidio a quasi tutti i tavoli e le trattative, iniziative che spesso si trasformano in cortei spontanei nella città. In ogni apparizione nessuno si lascia andare a espressioni di angoscia o a grida di sconforto, la dignità che alcuni vogliono rubare la custodiscono come possono, senza stare al gioco del dramma provano a dare testimonianza con i mezzi che hanno a disposizione.
Nel frattempo si susseguono trattative con l’azienda, vertici, incontri, chiamate a Bruxelles riportate poi da ministri, funzionari e rappresentanti sindacali ai microfoni con occhiaie, sudore visibile e facce angosciate. L’altra faccia della testimonianza che annuncia con cordoglio la fermezza da parte di Embraco nel non ritirare i licenziamenti. La situazione sembra sostanzialmente immutabile.
Solo ora i sindacati ritengono che ci siano le condizioni per lanciare uno sciopero generale il 15 marzo, ora che i giochi sembrano fatti e uno sciopero previsto fra tre settimane non farà tremare di certo i dirigenti dell’azienda. Allo stesso tempo le istituzioni italiane chiedono affannosamente all’Europa di intervenire controllando bilanci aziendali e diseguaglianze salariali nell’Unione che renderebbero alcuni stati più competitivi di altri per attirare le multinazionali. Trapelano poi voci speranzose di possibili ricollocazioni di una parte dei licenziati in aziende non meglio specificate.
«Non si molla di un millimetro. Se non prendono sul serio le trattative ce ne andiamo. Irresponsabili». Queste sono le posizioni corali e battagliere, ripetute ossessivamente, ma si possono assolvere istituzioni e organizzazioni sindacali da questo disastro? Basta dirsi indignati, in campagna elettorale per di più, per purificarsi dalle proprie contraddizioni?
Governo e Unione sono le stesse che per decenni hanno incentivato la deregolamentazione del mercato e garantito alle multinazionali agibilità massima in Europa, le stesse che finanziano senza fiatare multinazionali con bilanci a dieci cifre. L’Europa che per permettere a tutti gli stati membri di rientrare negli standard di crescita facilita la delocalizzazione in stati sottosviluppati per poi condannarla è la stessa che può evitare la chiusura dello stabile? È davvero la delocalizzazione delle multinazionali il problema per il futuro degli operai metalmeccanici? Il ministro Calenda riterrà irresponsabile anche il Jobs Act, decreto che ha stabilizzato e legittimato precarietà, mancanza di tutele e soprattutto licenziamenti senza giusta causa? Le stesse istituzioni che per anni hanno finanziato l’azienda sono quelle che restano sbigottite perché realmente non avevano previsto un simile epilogo.
I sindacati incapaci di opporsi allo smantellamento del lavoro a livello nazionale, e al contrario tendenti a mediazioni al ribasso, possono essere determinati nel portare avanti una lotta sfibrante? Per quale assurda strategia agli operai dell’Embraco continua a essere consigliato di restare cauti e cercare visibilità? Cosa ci può essere di peggio che essere licenziati in tronco a cinquant’anni? Qual è la ratio nel non considerare lo sciopero uno strumento efficace privilegiando tavoli di trattativa con l’azienda assolutamente inconsistenti? Perché continuare a utilizzare forme di sciopero bianco o parziale contro un’azienda che si rifiuta di trattare con le istituzioni statali? È davvero questo il modo giusto per ribaltare i rapporti di forza e salvare 497 famiglie?
La partecipazione simulata dai sindacati è quella che paga i pullman per portare i dipendenti alle trattative per lasciarli fuori ore, la stessa capace di comunicare senza vergogna che l’azienda ha preferito un incontro a porte chiuse con il ministro senza rappresentanze sindacali. Il modus operandi dei confederali è ormai quello di raccogliere le briciole: qualche mese in più di disoccupazione, contratti part-time a tempo determinato e promesse di reintegri in aziende da creare. La sensazione è che ci sia in atto un collaudato gioco delle parti a vuoto, consapevole sin dall’inizio dell’irreparabilità della situazione, dove quello che conta è salvarsi la faccia, non la coscienza, e svincolarsi da eventuali responsabilità. Una spietata arte dello “storytelling”.
Eppure le vittime, le uniche, la forza per resistere l’avrebbero ancora, dopo una vita passata in catena di montaggio aspettando la ricompensa, una resistenza placata da chi ha l’autorità per dire loro cosa è giusto o non giusto fare. È semplice per istituzioni e sindacati giocare sulla presunta inferiorità intellettuale ed esperienziale degli operai, sulla loro umiltà e sugli strani scherzi che la disperazione, che la prospettiva di vuoto, possono fare al carattere e all’anima. Persone, famiglie che perversamente trovano le luci della ribalta raccontando la grottesca sfortuna di essere marito e moglie, padre e figlio, cugini o amici tutti assunti nella stessa fabbrica che sta per chiudere. Operai ai quali è stato detto di aspettare pazienti, tanto male che vada una buonuscita e qualche mese di disoccupazione “la otteniamo”, ai quali tutto è raccontato con il noi fino a quando i tempi saranno maturi per tramutarlo in un distaccato loro. (ilaria magariello)


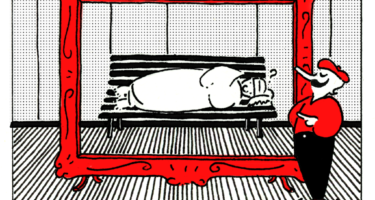


Leave a Reply