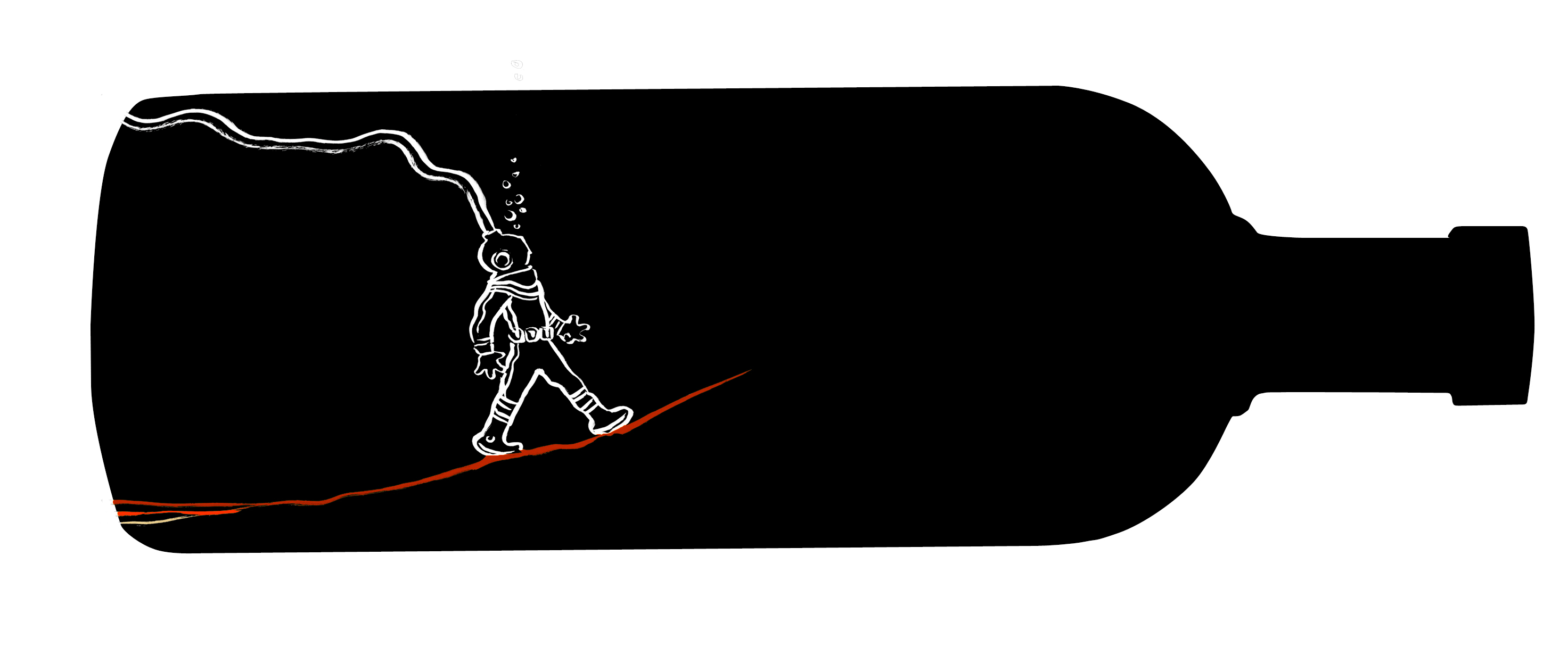
«Avevo circa vent’anni, volevo disegnare piastrelle in Emilia Romagna, la culla della ceramica artistica europea. Cinque anni dopo avevo realizzato tutti i miei sogni». Ma il miracolo della piccola e media impresa del Nord ha anche i suoi lati oscuri
Sono uno di quei giovani fortunati (pochi nella mia generazione) che non hanno dovuto fuggire da questa terra avara di occasioni, accontentandosi di svolgere la prima mansione che capita. Sono partito anch’io, è vero: ma sono partito alla ricerca di un sogno, e ho avuto la fortuna di realizzarlo. Avevo circa vent’anni, volevo lavorare nel mondo della ceramica, disegnare piastrelle e farlo in Emilia Romagna, la culla della ceramica artistica europea. A venticinque anni avevo completamente realizzato i miei intenti.
Al primo tentativo entrai in una nota accademia statale per il design e la tecnologia ceramica (a numero chiusissimo già dagli anni Ottanta). Dieci giorni dopo aver dato l’ultimo esame fui assunto (a tempo indeterminato) dall’azienda dei miei sogni. Quando misi piede in quello studio la prima volta, con la mia cartellina di disegni sotto braccio, pensai che quello era il posto migliore dove vivere e lavorare, ma che avrei dovuto sgobbare parecchio prima di essere degno di farlo. E invece no. Sei giorni dopo il primo incontro mi telefonò il signor Fabrotti (i nomi sono di fantasia) e mi disse di andare da lui per un colloquio. Mi trovai di fronte a un omone robusto e impomatato. «Facciamo un giro», mi disse. Mi accompagnò a visitare il primo capannone, un reparto di serigrafia industriale con grandi forni a tunnel nel quale si affaccendavano una serie di operaie in camice verde, quindi la smalteria (dove invece lavoravano tutti uomini senegalesi) e poi il cuore dell’azienda, il laboratorio tecnologico, dove una serie di ragazze (quasi tutte giovani e belle) lavoravano alla sperimentazione di nuove segretissime formule di smalti e rivestimenti. Dopo di ciò un giro in auto sportiva decappottabile per visitare gli altri due stabilimenti. Il tono era quello del «figliolo, un giorno tutto questo sarà tuo».
Nel secondo capannone, una batteria di donne di tutte le età, ciascuna con il suo torniello, decorava a mano servizi da tavola in maiolica; al piano di sotto c’erano i reparti di foggiatura, con i maestri tornianti e gli stampisti. Mi trovavo nella ex cooperativa degli artigiani ceramisti di quella città, rilevata dopo il fallimento di qualche anno prima. Il terzo stabilimento era il posto dove avrei lavorato, una palazzina di uffici con il reparto grafico e il laboratorio di prototipazione. Fabrotti mi presentò i miei futuri colleghi: Claretta, una signora sui quarantacinque anni; Luana, una procace e truccatissima mora sui trentacinque, e Sandro, un ragazzo sui trent’anni, di cui avrei preso il posto dopo una settimana di training. Sulla decappottabile, tornando al suo ufficio, Fabrotti mi illustrava le condizioni contrattuali. Mi trovavo di fronte il miracolo della piccola e media impresa del nord est. Non avrei lavorato per una mastodontica e alienante fabbricona, in cui la produzione è talmente standardizzata che del disegno se ne occupano i geometri, ma per una rete di piccole S.r.l., in realtà tutte con gli stessi proprietari, ma ciascuna con una sua autonomia produttiva. Mi sarei occupato non solo di serigrafie industriali, ma anche di decorazioni da eseguire a mano libera o in bassorilievo: l’intero ventaglio delle possibilità ceramiche era a mia disposizione. In più, essendo terzocontista, realizzando cioè solo i pezzi più complessi delle linee di altre aziende più grandi, avrei potuto lavorare con tutte le griffe più importanti del mercato ceramico.
Tornati nel suo ufficio, Fabrotti solennemente mi fece firmare il contratto e iniziò a parlarmi in tono confidenziale. Regola numero uno: di arte ne parliamo volentieri a cena io e te, qui ci occupiamo di produzione. Regola numero due: non venire mai a dirmi che non vuoi lavorare con Luana. Luana lavora perchè è buona… e brava. Tornai a casa, un po’ stupito ma contento. Il discorso sull’arte a cena e sul gusto della casalinga di Voghera non mi stupiva, anzi ci ero abituato; provenendo da una scuola dal solido impianto razionalista e tecnologico, ero avvezzo alle minchiate fordiste del marketing. Rispetto alla seconda regola ero un po’ perplesso; effettivamente Luana era buona, ma perchè mai avrei dovuto desiderare di non lavorare con lei? Poi il capoufficio sarà sicuramente la saggia Claretta…
La prima settimana di lavoro mi chiarì le idee. Il capoufficio era Luana, che un tempo, nella vecchia cooperativa, era stata l’apprendista di Claretta, ma la nuova gestione aveva invertito i ruoli. L’allieva non aveva affatto superato la maestra né per talento né per creatività, ma si era conquistata la sua piccola fetta di potere sulla collega. Sandro aveva mal digerito la palese ingiustizia, schierandosi dalla parte di Claretta, e aveva deciso di cambiare lavoro: sarebbe andato a disegnare lampade a Bologna. L’azienda aveva quindi bisogno di me dato che Sandro era l’unico del reparto capace di usare i computer e gestire le fotounità digitali. Nel corso del training Sandro si rivelò simpatico, ma mi diede l’impressione di lavorare in modo svogliato. Aveva nel suo computer una serie di stilemi preimpostati che mescolava in modo diverso. «Tanto – diceva – i “tralci classici” sono sempre gli stessi, qua una S, là una foglia, là un pallino». Rimase colpito dal fatto che usassi la matita: «Ma disegni davvero a mano!», mi disse compiaciuto. La cosa mi parve un po’ strana detta da un disegnatore. In seguito capii che i veri creativi non sono affatto i disegnatori, che sono il più delle volte semplici esecutori delle idee che vengono ai commerciali, ai quali è affidato tutto il potere decisionale. I commerciali, avendo scarsa immaginazione, ritengono che il mercato vada mantenuto stabile e sicuro: non pensano mai a niente che non hanno già visto. La soluzione è quindi la copia all’infinito degli stessi tipi di prodotti, che il più delle volte altro non sono che il frutto della ricerca delle generazioni che furono, e che, con ben altra libertà, esportarono l’ingegno italiano nel mondo.
Quasi tutte le mattine la solfa era la stessa: «Fammi questo, però uguale-non-uguale». I ritagli di giornale e i cataloghi altrui si affollavano sulla mia scrivania insieme ai pezzi della concorrenza, che poi a sua volta attingeva dallo stesso calderone nostro, anzi ogni tanto il commerciale lavorava sia per noi che per loro. Eravamo noi a copiare loro o viceversa? A quelli per cui lavoravo non interessava cosa potessi disegnare, bensì quanti disegni fossi in grado di produrre e in quanto tempo. Ogni quindici minuti dovevo compilare delle schede in cui risultava ogni mia azione, rendicontando il numero di bozzetti e i metri di pellicola stampati: la catena di montaggio applicata alla creazione artistica. E poi c’era Luana: l’assurdo fatta persona. Passava il tempo a cercare di dimostrare che i computer non erano abbastanza precisi. Iniziò a contestare interi lavori (centinaia di euro di pellicola) sostenendo che vi fossero errori dell’ordine del millesimo di millimetro e che il suo occhio fosse più preciso della taratura (al millesimo) di una fotounità digitale. In breve, tentava di diminuire la produttività delle macchine digitali per dimostrare che non servissero.
Ogni tanto, come unico capace di usare una comune stampante, mi toccava lavorare sul computer di Fabrotti. Il suo archivio, oltre alle foto di lavoro, comprendeva alcune foto della moglie chiattona e una serie di pose della cara Luana… Claretta invece aveva un gran stile. Ci metteva molto di più di me a farle, però produceva cose di un altro livello. Peccato che Fabrotti la ritenesse improduttiva. Mi diceva: «Se compro una macchina da taglio, sono sicuro che guadagno duecento lire al minuto. Se invece faccio disegnare voi non sono sicuro di vendere quello che fate. Quindi, non fate niente che non sia stato già venduto». Il risultato è stato che, in quattro anni di lavoro, solo per quattro volte mi è stato detto: «Fai tu». Tutte e quattro le volte i clienti erano stranieri. L’Italia no. L’Italia è prigioniera del “tralcio classico padano”. E dei Fabrotti di turno. Basta andare a una delle tante mastodontiche fiere campionarie per accorgersene. Per Fabrotti l’unica cosa che conta (oltre alla topa) sono i numeri. Aumentare la redditività e risparmiare. E fare contento il Piercarlo. Perchè il vero padrone di tutte le fabbrichette è il Piercarlo, o più probabilmente qualche anonimo per cui il Piercarlo lavora a sua volta.
Piercarlo (lampadatissimo e con Porsche) passava il tempo ad aggirarsi per i capannoni dispensando pacche comprensive sui culi delle giovani addette al colaggio o alla rifinitura. Andava spesso alle Maldive, e portava con sé una delle ragazze dell’amministrazione, che avrebbe ovviamente comandato l’ufficio per la stagione successiva (leadership a rotazione). A capo delle quattro S.r.l., oltre al Fabrotti, sedevano la convivente del Piercarlo, la sua seconda amante ufficiale modenese, e il fratello di sua moglie (per tenerla buona). Lo stile di gestione dell’azienda era tipo esercito prussiano. Ogni tanto trovavo cartelli nei capannoni in stile: “Essere sorpresi tre volte a parlare sul lavoro sarà motivo di licenziamento con giusta causa”. “Se arrivi alle otto e trentuno per noi sei arrivato alle nove”. L’abbrutimento era generalizzato, la delazione regnava sovrana nei ranghi più bassi. Una volta una fiera caporaluccia (ho lo stesso stipendio degli altri però comando) per un eccesso di zelo si fece saltare un dito tra i cingoli di un muletto. Avrebbe potuto restare a casa in infortunio (a stipendio pieno) per sei mesi. E invece no. Nel timore di perdere il suo piccolo dominio conquistato in anni di dolorose delazioni, continuò a venire in azienda. Tutti i giorni, con la mano bendata appesa al collo, arrivava puntuale, non timbrava il cartellino, e iniziava a ruggire all’indirizzo delle malcapitate colleghe. Con me invece erano tutti molto amichevoli. Il mio ruolo di unico depositario del verbo informatico (sembrerà assurdo ma è così) mi metteva in una posizione notevole. Fabrotti mi chiamava “il suo maghetto”. Quasi ogni cosa che si doveva stampare passava dalle mie mani. Ogni tanto le operazioni erano non dico illecite ma quantomeno di dubbio gusto. Fabrotti brevettava (pagando) qualsiasi cosa, anche l’acqua calda; tanto, diceva, i fondi europei per ricerca e innovazione vengono dati in base al numero, e non alla qualità dei brevetti acquisiti.
Un giorno squillò il mio telefono, era il Piercarlo: «Ti posso lasciare la Deborah per un quarto d’ora?» Deborah, pensai, e chi è? Sarà sua figlia piccola… «Si, certo», risposi. Dopo qualche minuto un’avvenente signorina con minigonna ascellare fece capolino nel mio ufficio, osservò per circa un quarto d’ora, parlando al cellulare in modo civettuolo con qualcuno. Poi si avvicinò alla scrivania, con un biglietto in mano: il suo numero di cellulare. Rimasi colpito, anche se non era il mio tipo, dalla corte di una simile stangona. La sera raccontai al mio amico Francesco, disegnatore dei servizi da tavola fatti a mano, quello che era successo. Francesco iniziò a ridere. Deborah era stata anche da lui, e anche a lui aveva lasciato il numero di cellulare.
Il giorno dopo Deborah entrò molto contrariata nel mio ufficio. Era offesa perchè, diceva, non le era mai successo che qualcuno si permettesse di non telefonarle dopo che lei gli aveva, addirittura, lasciato il suo numero. Francesco invece l’aveva chiamata. Dopo qualche giorno Deborah tornò con Fabrotti. Era stata assunta. In che ruolo? Commerciale, naturalmente: colei che deve dire a me cosa disegnare e cosa no. Debbi era una vera artista. La sua prima idea geniale fu portarmi una serie di cartoline raccolte all’Ikea e costringermi a tramutarle in ceramica…
Pur nelle condizioni descritte il lavoro nell’ufficio procedeva abbastanza bene. Fabrotti decise di ampliare il reparto: voglio che tu abbia un’apprendista, disse. Trovami una ragazza, entro i ventiquattro anni, che abbia fatto la tua stessa scuola, e che sia buona! Il terzo anno di lavoro io e Claretta (e la giovane Manuela, buona e ventiquattrenne) eravamo quello che si dice un team vincente. Riuscimmo a mandare in produzione ben sei nuovi prodotti in un anno. Il Fabrotti venne a darmi una paterna pacca sulla spalla, e in busta paga trovai un premio produzione. Il quarto anno di nuovi prodotti ne facemmo dodici, il doppio, ma le cose cambiarono improvvisamente. Fabrotti iniziò a dire, agitandomi davanti un foglietto, che le cose per l’azienda non andavano tanto bene; se prima gli ordinavano diecimila pezzi per volta, adesso gli ordini erano diventati di due, tremila pezzi.
L’azienda era in rosso. Io ho i miei dubbi rispetto a tutto questo. So per certo che la mole di lavoro era raddoppiata, e il fatto che poco tempo prima il parlamento avesse approvato la legge sul falso in bilancio mi diede da pensare. Prima del falso in bilancio il parlamento aveva approvato anche una legge sulla “cessione di ramo d’azienda”. E Fabrotti non se l’era fatto dire due volte: aveva ceduto uno dei suoi rami rigogliosi, creando una nuova azienda, in cui aveva spostato (la legge glielo consentiva) tutti i dipendenti più anziani. Compresa Claretta. E una serie di maestri artigiani della ex cooperativa. Insomma tutti quei dipendenti, intorno ai cinquanta anni, che avevano più esperienza, ma anche gli stipendi più alti, e in più, essendo in azienda da ben prima di lui, meno timore reverenziale nei suoi confronti. Completavano l’organico una serie di giovani interinali (nel frattempo era entrata in vigore anche la legge Biagi). Fabrotti si diceva vicino al passivo, eppure assumeva ancora, nel nuovo ramo. Come per magia in poco tempo il nuovo ramo si seccò. La nuova S.r.l. dichiarò fallimento. Claretta (quarantacinque anni e una figlia di sedici) e gli altri finirono in cassa integrazione per qualche anno, prima di doversi inventare qualcosa per arrivare alla pensione.
Fabrotti si liberò, senza toccare la sua azienda, di tutti quelli che costavano di più e rompevano di più le balle, secondo lui. Secondo me semplicemente aveva buttato nella pattumiera tutto il tesoro di conoscenze della sua azienda, al quale ogni giorno attingevo per imparare a fare il mio lavoro. A me venne a proporre un “contratto verticale”, così lo chiamava, per metterlo in culo all’Inps, disse. Come collaboratore coordinato e continuativo, secondo lui, avrei guadagnato molto di più e non avrei avuto vincoli di orario. In realtà mi offriva il lordo complessivo del mio stipendio. Invece che un milione e settecentomila lire, circa due milioni e mezzo al mese. Su cui però avrei pagato le tasse e i contributi autonomamente, tornando al punto di partenza. L’idea del “contratto verticale” (dal basso verso l’alto) non mi rassicurava molto. Decisi di andare a parlare con un delegato sindacale. Il signore in questione confermò in pieno i miei dubbi. Tornai a casa pensando ai personaggi del grande Altan, con un ombrello installato posteriormente in modo “verticale”. E presi la mia decisione: Basta. Mi licenzio. Emigrerò a sud. Quando gli consegnai la mia lettera di dimissioni, Fabrotti ebbe un sussulto isterico. Secondo me in realtà pensò solo che sarebbe stata una gran seccatura trovare un altro ragazzino che gli accendesse i computer (la giovane Manuela era già scappata).
Ormai vivo a Napoli da cinque anni, sono povero ma ho ancora i capelli. E il profumo dei pomodori mi consola. Sono passato da poco per la cittadina dove ho vissuto per quasi nove anni. Dove lavoravo adesso c’è una caserma dei carabinieri, pare che le ceramiche locali stiano franando. Sono tutti in cassa integrazione. La colpa, mi dicono al bar, è dei cinesi. Io penso che è vero. Quei maledetti cinesi, a differenza di noi, disegnano. E lo fanno anche bene. Sia chiaro: non nego che la storia che ho appena raccontato possa essere un singolo episodio di sfiga personale. E che nel nord est ci siano alcune fra le migliori aziende del mondo. Ma una cosa rimane: della qualità e della ricerca a queste persone non importava assolutamente nulla. Quello che gli interessava era sopravvivere nelle pastoie di un’economia provincializzata. Molte delle nostre commesse non dipendevano affatto dalla nostra bravura, ma dalla nostra presenza su quel territorio, e spesso dal fatto che i nostri committenti fossero in realtà i nostri proprietari occulti. Non sto a discutere se tutto questo sia lecito o meno, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. A un certo punto i mercati si aprono, si fanno i conti con le competenze altrui, e vince semplicemente chi è più bravo. E, mi dispiace dirlo, ma questi non eravamo noi. (peppe cerillo)



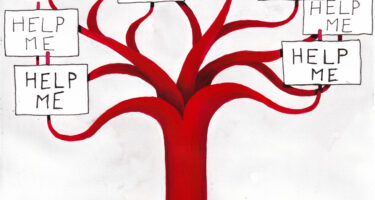

Leave a Reply