Era la fine degli anni Novanta quando, fra gli eventi che popolavano la notte, cominciarono anche a Napoli a fare capolino le dancehall. In realtà alcuni fermenti del roots erano già germinati in città all’inizio del decennio, quando una serie di trasformazioni sociali e politiche ne avevano cambiato il volto. Ma è a partire dal Duemila che in tutta la Campania comincia a diffondersi un nuovo modo di dar vita a una serata danzante. Montagne di casse autocostruite erano comparse già da qualche tempo nelle città italiane, cambiando il panorama delle “piste da ballo”. I sound system – in linea di connessione diretta con quelli inglesi e, a ritroso nel tempo, con quelli giamaicani di alcune decadi prima – portarono in Italia la possibilità di costruire uno spazio per la musica, il ballo e la socialità alternativo ai club. Nonostante alcuni locali proponessero già da tempo i ritmi in levare, lo scenario rappresentato da quegli impianti autocostruiti, intorno ai quali si stringeva una crew, una famiglia che viveva la sua vita intorno a quel progetto di discoteca popolare ambulante, era qualcosa di differente. Di radicalmente nuovo.
Con Erbapipa nasceva, dopo i primi esperimenti in giro per lo stivale, la scena dei sound system campani. Una storia che ha avuto vita lunga, attiva ancora oggi, e che è nata quasi per caso dalle intuizioni di un gruppo di ragazzi di Salerno, che a metà degli anni Novanta incrociarono passione politica, amore per il reggae e la sua cultura.
La scena dei sound system in Italia ha, ormai, più di vent’anni. All’interno del panorama delle culture underground è una presenza che, al di là degli alti e bassi e di una capacità di radicamento inferiore rispetto all’hip hop, risulta stabile e consolidata. Erbapipa è all’origine di questa scena. Come vi è venuto in mente, nel bel mezzo degli anni Novanta, di mettere in piedi un progetto simile a Salerno?
È nato tutto da un gruppo di amici poco più che adolescenti che militavano al centro sociale Asilo Politico e dalla passione smodata per la musica che ci univa e ci unisce tuttora. Intorno a noi c’era la scena delle Posse, le lotte per gli spazi sociali, la “rinascita” delle città, e un fermento culturale complessivo che ha caratterizzato gli anni Novanta. Era il 1995 e mettemmo in piedi questo progetto. Ci chiamammo Skang Sound System, non sapevamo neanche scrivere “skunk”! C’erano Uru, Billyman, Papa Manolo, Radadub, Gennaro e tanti altri compagni di strada. All’epoca cantavamo in freestyle sul lato B dei vinili che avevamo, pochi e di generi diversi. In seguito fondammo un gruppo dub in stile Massive Attack, che si chiamava D.A.B. Noise e che aveva come base il garage di Radadub a Sant’Eustachio, alla periferia di Salerno. Ai tempi dell’università, quando eravamo dentro il movimento studentesco nato sull’onda della Pantera, la buonanima di Marco Contieri, a.k.a. Kapa, insieme a Uru, si convinsero che un impianto sonoro sarebbe stato un buon sistema per amplificare la voce del movimento e la nostra presenza sul territorio. E allora ci venne in mente di costruirlo. Gli stessi Uru e Kapa si tirarono dietro Paoletto, Billyman, Radadab e Youthman. Era il 1997. Questa è solo l’estrema sintesi di una lunga storia che, però, non ci interessa nemmeno idealizzare troppo.
Lo spunto per la nascita di Erbapipa viene da quello che stava accadendo in Italia in quegli anni. In giro si vedevano sempre più dancehall reggae. Voi che non siete mai stati discotecari, cosa avete trovato in quel modo di mettere in piedi una “pista da ballo”?
In realtà nessuna riflessione troppo approfondita. Siamo amanti da sempre della musica giamaicana e “black” in generale. All’epoca nei locali questa roba non si ascoltava. Ci siamo innamorati proprio andandoci, alle dancehall. Ce ne sono alcune che ricordiamo come fondamentali per il nostro percorso. La tre giorni alla Masseria del Capitano a Melendugno, in Salento, organizzata dal Sud Sound System. Poi una serata dei romani One Love Hi Powa, fra i pionieri della scena, invitati da noi a Salerno all’Asilo Politico. In quella occasione Joao e Lampa ci diedero i progetti per costruire i nostri primi “scoop binz”, la casse per i bassi che sono il cuore di un sound. Poi una serie di dancehall romane in gemellaggio con il Baracca Sound con cui abbiamo vissuto in simbiosi in quegli anni. E sound system come Lionheart (ex Sattamassagana), i baresi I&I Sound System, attraverso cui abbiamo conosciuto i ragazzi che compongono una famiglia sparsa tra le Murge e la Lucania: Murgia Connection, Brigante Sound, Krikka Reggae.
C’erano già, però, all’epoca, serate reggae in alcuni locali. Perché costruire un sound, dal momento che la gente tende ad andare a ballare in posti già attrezzati?
Principalmente, all’inizio, per una questione di libertà. Per avere un impianto da portare in tutte le situazioni che ci piacevano, dato che il nostro progetto era legato al movimento e quindi veniva usato in azioni di lotta, magari in strada. In seguito è diventata anche un’esigenza legata al gusto sonoro, perché gli impianti audio classici non hanno il taglio di frequenze che noi amiamo e che sentivamo nelle dancehall dei primi sound italiani. E noi invece volevamo quel suono.
Una dancehall reggae è qualcosa di molto distante dal mondo dei locali notturni. Costruire il proprio impianto vuol dire avere a disposizione una propria “discoteca” mobile. È la possibilità di creare, ovunque ce ne sia la possibilità, uno spazio per ballare e stare insieme, sovvertendo moltissimi aspetti di quel mondo. Ponendosene, anzi, in vera e propria antitesi.
Le discoteche sono aziende che lavorano nel campo dell’intrattenimento. La differenza fondamentale è nella coscienza e nel messaggio, oltre che nei fini con cui si affronta la cosa. Noi, in verità, di certi ambienti non ne sappiamo molto e non ci possiamo esprimere.
A un certo punto del vostro percorso avete cominciato a fare dischi. È affascinante questa idea di un lavoro a tutto tondo che comprende il sound, la selezione, il ragamuffin al microfono, i vinili stampati.
Forse sarebbe stato meglio nascere negli anni Cinquanta per avere vent’anni nei Settanta, quando proliferavano una miriade di piccole etichette indipendenti. All’inizio è nato tutto come gioco, per emulazione dei giamaicani. Poi ci siamo accorti che era un completamento logico del lavoro che stavamo facendo, anche perché oltre che selecters molti di quelli passati per il nostro progetto sono musicisti e dj, o cantanti. Ci è sempre piaciuta l’idea di continuare a fare musica anche quando il sound è spento, e ci abbiamo dedicato la nostra vita e il nostro tempo. King Jammy’s, Studio One, ma anche Blood & Fire, sono progetti che nascono con l’esigenza di diffondere il messaggio e il suono a tutto tondo e in tutte le forme dovute, e a questo stile di vita e musicale ci siamo sempre ispirati anche noi. Da Erbapipa sono nati tanti progetti, il metodo di lavoro era più simile a quelli di un “collettivo” che a un sound system. L’obiettivo non era solo la musica, ma anche un modo di vivere e condividere le proprie idee. La ricerca di una progettualità che ci aiutasse a vivere insieme e ad affrontare “Babylon” tutti i giorni.
Che tipo di legame avete con la Giamaica? Non siete rastafariani, ma siete rimasti attratti da una cultura musicale in cui, comunque, la componente religiosa ha un ruolo predominante.
Uru è calvo solo in apparenza, in realtà ha i dread ma non si vedono. Inoltre non mangia maiale da vent’anni ma non ha capito ancora se è rastafariano o musulmano. Se è vero che non siamo rastafariani, comunque, è anche vero che amare una cultura e una musica significa innanzitutto amare e rispettare le filosofie che la fondano. Secondo noi tutte le religioni sono indicazioni etiche e morali metaforiche, nate dalle esperienze individuali e collettive dei popoli. Noi, come i ragazzi giamaicani delle periferie, abbiamo bisogno di un veicolo per diffondere delle idee, per allontanarci dalla violenza, dalla povertà, dallo sfruttamento, dal ghetto. Il ritorno a Zion per loro e per noi è un movimento di emancipazione dalla schiavitù mentale ed è totalmente diverso dalla musica reggae. Ma grazie a persone come Bob Marley e tanti altri, questi concetti hanno viaggiato e viaggiano in parallelo. Dovremmo capire dentro di noi cosa potrebbe significare il ritorno a Zion, e quindi cantare e suonare della realtà che ci circonda.
Sono passati vent’anni dall’inizio di questa storia. Sulla vostra scia sono nati altri sound, con molti dei quali avete avuto rapporti di collaborazione. Oggi, a differenza di qualche anno fa, il “fenomeno” conosce un periodo di ripiegamento. Da dove bisogna raccogliere un’eredità per continuare questa strada?
Sono passati vent’anni, è vero. Ma in questi anni abbiamo sempre collaborato con quelli che abbiamo incontrato sulla nostra strada. Abbiamo amici in tutti i posti del mondo, grazie al reggae. Oggi ci sono un sacco di sound system, il che è positivo. Il problema, forse, è che molti sono più affascinati da un Jah Rastafari di plastica o dalla ricerca di uno stile e una visibilità mainstream, piuttosto che dai problemi veri che li circondano nei loro quartieri. Qualcuno si prende troppo sul serio, poi, e si allontana dal vero messaggio che porta questa musica. Lo sappiamo anche noi che è più facile dimenticarsi dei problemi e non affrontarli quotidianamente, ma prima o poi i nodi arrivano al pettine. Verrà l’Armagiddeon time, il tempo dell’Apocalisse. Ed è necessario che tutti, e noi stessi per primi, muoviamo le nostre coscienze. E non i nostri ego. (antonio bove)
PUNTATE PRECEDENTI:
Disco devil. Un’inchiesta a puntate sul mondo delle dancefloor
Disco devil #1. Da Calvizzano a Berlino: c’era una volta la Love Parade
Disco devil #2. Chi ha paura della Tekno? I Nameless raccontano il mondo dei free party
Disco devil #3. Napoli psichedelica. Una tribù aliena nel cuore della città
Disco devil #4. Ballando fuori dalla mappa. Il Free party prima dello smartphone

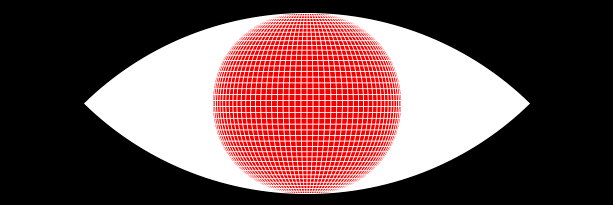




Leave a Reply