
Oggi pomeriggio alle 18 a Bologna, in piazza del Nettuno, la Rete D(i)ritti alla città presenta alla cittadinanza una proposta di delibera di iniziativa popolare sugli spazi pubblici. Questa delibera obbliga il Comune a mettere in discussione il modello con cui attualmente centinaia di edifici e spazi pubblici rimangono chiusi o vengono ceduti a enti privati. Per raggiungere l’obiettivo sarà necessario raccogliere almeno duemila firme. Abbiamo rivolto alcune domande alla Rete nata un anno fa per capire a che punto è la loro battaglia.
Quando è nata e perché la Rete “D(i)ritti alla città”?
D(i)ritti alla città è nata circa un anno fa, nel corso di un’assemblea pubblica che era stata convocata dopo che il Comune aveva siglato un accordo con Cassa depositi e prestiti per la trasformazione di tre aree militari dismesse. Il consiglio comunale lo aveva ratificato in fretta e furia senza neanche avere il tempo di esaminare l’enorme mole di relazioni tecniche allegate. Monitor lo ha raccontato nel dettaglio in un articolo comparso in quei giorni. Questa vicenda ha favorito l’incontro tra realtà che da anni si occupano del tema degli spazi pubblici e che hanno condiviso la necessità di dare vita a una rete in grado di proporre alla città uno sguardo critico sulla gestione dello spazio pubblico, supportandolo con azioni e proposte. È una rete molto eterogenea, che sfugge (per fortuna) a schemi usuali di intervento politico.
Il nostro atto fondativo è rappresentato dalla scrittura del Manifesto per gli spazi pubblici dismessi pubblicato nel settembre scorso, nel quale mettiamo in fila i problemi aperti e proponiamo una visione radicalmente diversa rispetto a quella dell’amministrazione comunale. Se questa persegue la privatizzazione degli spazi, la realizzazione di edilizia privata, alberghi, centri commerciali e parcheggi, la distruzione del verde pubblico, noi rivendichiamo che i beni dismessi rimangano di proprietà pubblica e vengano adibiti a funzioni pubbliche, che il verde ora nascosto e inaccessibile venga preservato e aperto alla fruizione di tutte e tutti. Con il Manifesto abbiamo disegnato un’idea di città pubblica, nella quale gli spazi non vengano monopolizzati dal mercato e dove sia possibile praticare forme di produzione culturale indipendente e di intervento sociale autogestito. Abbiamo anche riaperto le porte di due ex caserme, per mostrarle alla cittadinanza che – altrimenti – non può avere alcuna percezione della vastità dei luoghi, della loro bellezza e potenzialità, di ciò che la città intera si appresta a perdere una volta che le ruspe entreranno in azione.
“Diritti alla città” ha appena presentato una proposta di delibera di iniziativa popolare. Di cosa si tratta, e quali sono gli obiettivi?
Lo statuto del comune di Bologna prevede una forma di partecipazione che si chiama “iniziativa popolare”, a quanto ne sappiamo mai utilizzata prima. In sostanza, si tratta di presentare al consiglio comunale una proposta di delibera, supportata da duemila firme. Il consiglio è obbligato a discuterla e a metterla ai voti. Ci è sembrato una buona occasione per creare una forma di azione in grado di rompere gli schemi della partecipazione addomesticata che il Comune utilizza per creare consenso. Le forme istituzionalizzate di partecipazione che si sono accumulate nel tempo sono completamente prive di poteri decisionali. Con la delibera di iniziativa popolare mostriamo come sia possibile costruire dei saperi “dal basso” e portarli nel cuore della decisione politica, mettendo al tempo stesso l’amministrazione di fronte alle proprie contraddizioni e costringendola a venire allo scoperto.
Però per noi la delibera non è un fine. È uno strumento attraverso il quale vogliamo dialogare con la città, costruire alleanze sociali. Il contenuto della delibera è molto più importante della forma in cui viene presentata. La delibera è il frutto di un processo di scrittura collettiva che è durato circa sette mesi. Il risultato è un atto che ha l’ambizione di governare il patrimonio dei beni pubblici dismessi (che conta almeno 180 immobili) in modo organico, tenendo insieme tutti gli aspetti. C’è il tema del patrimonio: come conservarne la proprietà pubblica e destinarlo a funzioni pubbliche. C’è il tema della gestione degli spazi, e su questo abbiamo dato grande rilievo agli usi collettivi a titolarità diffusa ispirati agli usi civici, che rappresentano lo strumento più idoneo per realizzare forme di autogestione basate sulla cooperazione e il mutualismo. E infine ci sono le norme urbanistiche, perché altrimenti tutto poggerebbe sulle sabbie mobili: è fondamentale individuare strumenti per mettere al riparo i beni pubblici dagli appetiti degli speculatori e governare i processi di trasformazione senza subire passivamente l’iniziativa privata.
L’attuale amministrazione comunale bolognese rivendica una gestione dei beni pubblici innovativa e all’avanguardia rispetto ad altre realtà. Cosa c’è di vero, dal vostro punto di vista?
Le politiche della partecipazione del Comune sono sorrette da un discorso retorico che ne occulta la sostanza. La cronaca degli ultimi anni è fatta di sgomberi, una politica autoritaria ben poco innovativa. Per cercare di rispondere alle critiche diffuse in città rispetto alla gestione dei beni pubblici, il Comune ha avviato un processo di revisione dei propri regolamenti per dimostrare la propria disponibilità ad ampliare la tipologia delle forme di concessione. Ma le linee di indirizzo approvate dalla giunta affermano che per quanto riguarda l’uso prolungato degli spazi la concessione è possibile solo per “soggetti formalmente costituiti”. Quindi siamo daccapo. L’amministrazione comunale non riesce a concepire il fatto che la società è articolata e si auto-organizza in forme disparate. Pretende di ricondurre tutto a uno schema uniforme, che non lascia spazi alle differenze, al dissenso, al conflitto, e quindi non è in grado di contemplare le organizzazioni informali e autogestite.
Finora il Comune si è trincerato dietro la legalità formale dei bandi. Ma i bandi sono uno strumento legato alla scarsità di un bene: se una risorsa è scarsa, tutti vengono messi in competizione per accaparrarsela. Ma se i beni pubblici dismessi fossero recuperati e restituiti alla città, come noi proponiamo, ci sarebbe posto per tutte e per tutti. Qualsiasi apertura sul piano delle forme di gestione (aperture per ora solo fittizie) si scontra con il fatto che gli spazi dismessi rimangono inaccessibili e vengono progressivamente svenduti e privatizzati. Quindi di quali forme di gestione parliamo, se vengono a mancare gli spazi da gestire? La sostanza sta qui, ed è ineludibile.
Nelle ultime settimane abbiamo rivolto pubblicamente al Comune una serie di domande, ma nessuno si è degnato di rispondere. Tra le altre cose chiedevamo perché lasciasse andare in malora una parte del proprio patrimonio immobiliare. Si tratta di una gestione corretta della “cosa pubblica”? La “legalità” tanto invocata ogni volta che viene occupato un immobile abbandonato non vale quando la pubblica amministrazione anziché curare i beni della collettività li lascia deperire fino alla distruzione? Noi vogliamo agire dentro queste contraddizioni e farle esplodere per affermare un’idea dello spazio pubblico che il sistema politico locale non è in grado né di comprendere né di governare.

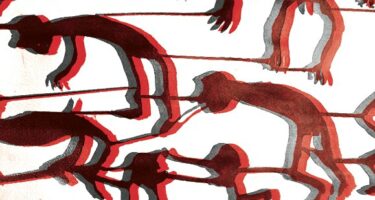



Leave a Reply