
È in corso in queste settimane a Napoli, nell’ambito del Maggio dei monumenti e della rassegna “Napoli in vetta”, la prima retrospettiva integrale sull’opera di Antonio Capuano (qui il programma completo), realizzata in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli e l’Università Federico II.
La rassegna è curata da Armando Andria, Alessia Brandoni e Fabrizio Croce, con la co-curatela di Anna Masecchia.
Proprio da un incontro tra Andria, Branconi, Croce e Capuano, estratto dal volume Una prospettiva eccedente. In dialogo con Antonio Capuano, pubblichiamo il testo che segue.
* * *
Dall’introduzione al volume
Questo libro nasce e si articola intorno a qualcosa che riguarda non solo il pensiero e la riflessione su un autore e il suo cinema, ma anche il processo che ne ha accompagnato la realizzazione. Perché Antonio Capuano, nel tempo che abbiamo avuto la possibilità di trascorrere insieme, ci ha toccato, e si è fatto toccare, nell’esplicarsi di un dialogo denso e articolato intorno a molti aspetti della sua vulcanica personalità di cineasta e di uomo.
Ripercorrere la sua filmografia ci ha messo in contatto, in un’indissolubile commistione tra la dimensione artistica e quella personale, con la sua storia, il suo mondo di appassionate preferenze e altrettanto radicali rifiuti, il suo singolare, irripetibile sguardo sulla vita e sul cinema. E ci ha confermato il motivo per cui abbiamo amato i suoi film e abbiamo deciso di scrivere su di lui (e in qualche modo con lui): ovvero quel coraggio selvatico e quell’autenticità materica che alimentano costantemente il bisogno di andare alla ricerca di una verità delle cose, dentro e fuori di sé; salvo poi metterla continuamente in discussione, portarla sull’altare di una chiesa sconsacrata o nel tempio di un rito arcaico e riformularla, sempre, in una maniera problematica e perturbante, e mai consolatoria e compiaciuta. Tutto questo lo abbiamo ritrovato, amplificato dall’esperienza concreta dello spazio e del tempo in cui ci siamo visti con lui, nella sua presenza fisica e tangibile, nel suo far trasparire quelle contraddizioni che poi esplodono nel suo cinema. Dopo esserci imbattuti in un “soggetto” così potente e totalizzante, ci siamo ritrovati tra le mani il materiale emerso dalle cinque sessioni in cui si è articolata l’intervista (le prime quattro più ravvicinate, l’ultima a distanza di anni, riconoscendoci nei segni lasciati da questo tempo faticoso), punto di partenza e ripartenza, ma inevitabilmente non di arrivo, di questo volume. E ci siamo resi conto di quanto questo materiale fosse stimolante e originale nella forma e nei contenuti ma anche altrettanto caotico. Abbiamo così deciso di procedere con un “montaggio”, vale a dire di strutturare il testo per via di alcune correlazioni e interventi tramite cui riportare non certo a unità – impresa che non solo non sarebbe stata coerente con quanto accaduto, ma che avrebbe soprattutto tradito lo spirito entropico e recalcitrante del nostro interlocutore –, quanto piuttosto a ipotesi di racconti possibili, il vortice di esperienze, pensieri e aneddoti riportati, non per forza in quest’ordine, da Capuano.
Dal capitolo Tra solitudine e partecipazione
(AC: Antonio Capuano, AA: Armando Andria, AB: Alessia Brandoni, FC: Fabrizio Croce)
AB: Da dove è nato il desiderio del primo film?
AC: Ho scritto una sceneggiatura, che è passata al Solinas. Ho avuto un finanziamento di ottanta milioni, e dovevo farmeli bastare, poi mi hanno dato un’integrazione per la post-produzione. Era il periodo della moviola.
AB: Quella sceneggiatura era Vito e gli altri…
AC: Sì. Lo sapevate che Vito… cioè Nando… è uscito dal carcere quindici giorni fa? Un giorno mi chiama e mi dice: “Anto’, sto agli arresti domiciliari”. Ma ve lo immaginate lui costretto dentro casa? Ora avrà trentasei, trentasette anni…
FC: Avremmo pensato a questa struttura di massima: una prima parte di ogni incontro dedicarla alla tua storia, da dove vieni, qual è stata la tua formazione, il tuo percorso, la tua vita, tutto quello che ritieni importante per conoscerti anche come essere umano…
AC: Io non voglio più sentirla questa espressione, “essere umano”. Subito dopo La guerra di Mario, per dire, ho fatto uno spettacolo a teatro in cui la protagonista era una barbona su un palcoscenico fatto di immondizia. Mentre la barbona sta con le buste di plastica in mezzo a questa immondizia, ecco che entra un guaglione di prima generazione, una specie di punk, che viene ad ammazzarla e, a proposito di umanità, lei dice: “L’umanità la tene in bocca nu cane!”. E così è.
AB: Vero, “essere umano” e “umanità” sono ormai termini complicati da usare…
AC: L’umanità è anche quella feroce, quella che fa le guerre, è quella che odia, è uno che ti spara: non è umanità anche quella? Anzi, forse è ancora più interessante di questa umanità facile, no? “L’umanità la tene in bocca nu cane!”, come diceva Angela Pagano, la barbona… Vallo a acchiappa’ nu cane, va’.
FC: Quali sono le tue origini?
AC: Da bambino ero molto legato ai fumetti, li compravo al mercatino delle pulci di Agnano, erano gli anni Cinquanta. Erano delle strisce, una si chiamava Piccolo sceriffo. Provengo da una famiglia proletaria. Vivevo a Posillipo, zona mare, e ci vivo ancora. Papà era un contadino, poi divenne tranviere. Quand’ero bambino mi portava con lui sul tram. Mi diceva: “Vieni, ti porto a faticare con me”. Noi eravamo tanti e facevamo casino, quindi mamma gli diceva: “Salvatore, portatene qualcuno”. Quindi facevo un giro, due, tre, quattro e poi tornavamo a casa… Di quella cosa lì, che cazzo mi sarà rimasto?
Dal capitolo Sogni, realtà e simultaneità
(AC: Antonio Capuano, AA: Armando Andria, AB: Alessia Brandoni, FC: Fabrizio Croce)
AC: Molto del movimento e dell’intensità che dici avviene effettivamente mentre giriamo, e questo mi piace, mi diverte, anche se è vero che l’uso del piano sequenza a trecentosessanta gradi lo programmo prima. Spesso lo uso perché mi pare la forma più adatta con cui tenere insieme le cose…
AB: Che altrimenti esploderebbero? Che si perderebbero?
AC: Forse. È un modo anche un po’ architettonico, quello che mi muove. Giro sempre come se quel momento fosse nuovo. Cioè non mi pongo nessun tipo di limite, e questa è una cosa che non mi so spiegare bene…
AB: Certi tuoi film mi fanno pensare a Francis Bacon, in particolare il cerchiare e isolare le figure mettendole dentro un campo di tensione…
AC: Perché mi hai portato Bacon? Mi vuoi uccidere! [intanto sfoglia Francis Bacon. Logica della sensazione di Gilles Deleuze]. Ho tanti libri su Bacon, grandi, piccoli, di tutti i formati… Però ora che lo sto rivedendo, mi attrae di nuovo!
AB: Mi è venuta questa associazione per il tuo modo di fare piani a trecentosessanta gradi…
AC: Forse sì, forse sì. Ma tu guarda ’sto giallo che cazzo è! Devi per forza amare Van Gogh per fare quel giallo là. E infatti noi sappiamo che Bacon amava Van Gogh. Che bellezza. E questo? Erano delle facce un po’ picassiane, un Picasso però reinventato. E comunque sarei felicissimo se i miei film potessero far pensare a Bacon! Madonna, guarda qui! Van Gogh è questo… viscerale e vero. I mangiatori di patate… E io ho anche la moglie olandese…
AB: Hai visto L’enigma di Kaspar Hauser di Herzog?
AC: Sì bellissimo, hai capito? Quelle robe là.
AB: Il linguaggio è reso materia, in quel film.
AC: Chi era l’attore?
FC: Bruno Schleinstein.
AC: Vi ricordate quell’immagine di lui con la testa sul muro? A un certo momento lui sta così, appoggiato [mima la scena, nda], poi si alza e cammina e mentre cammina si mette così, ad ascoltare… Perché aveva delle frequenze extraterrestri, per così dire, aveva delle frequenze altre che noi tutti, di solito, squalifichiamo come pazzia. Accade qualcosa di straordinario, invece.
AA: Rispetto alla narrazione, al racconto, qual è il rapporto che il quadro intrattiene con il raccontare una storia?
AC: Non è così esplicito, è proprio il non detto e il non scritto, l’essere e l’esserci, senza aneddoti, che evita la spiegazione e rende l’enigma. È il tutto-pieno. Lo vedi e lo senti, che è così denso di cose. E spesso il racconto non lo rintracci, specialmente in un certo tipo di pittura. La pittura astratta, insomma da Kandinsky in poi, ecco da lì si è aperto un modo di raccontare completamente nuovo, con una sintassi e un alfabeto diversi da quelli precedenti. Nel cinema c’è la drammaturgia, che se troppo rarefatta rende il film quasi incomunicabile.
AB: Il cinema è più vicino alla fotografia, contiene sempre elementi di realtà, tra i quali il tempo, che difficilmente può diventare puro segno…
AC: Il cinema è temporale. C’è un inizio e una fine. E quindi un film deve per forza possedere un arco di racconto che appunto si chiama drammaturgia. Puoi trovartene una nuova, se hai coraggio. Ma comunque ci deve essere, anche se il film dura un minuto. C’è un inizio e una fine. Nel quadro, meno male, questo non c’è. Il quadro non ha bisogno di tutto questo portato, di questi sotterfugi, di questo mestiere… Il quadro ha un impatto molto più forte, molto più profondo, e tu non ti devi fare tutte queste domande, devi solo… Non lo so, devi essere in grado di riuscire a godertelo. Cioè non ti chiedi se quella è davvero la casa di Van Gogh, non ti chiedi perché Van Gogh va di qua mentre l’ombra sta di là, se cominci a pensare tutte queste cose appesantisci la visione, l’esperienza, ci metti dentro una roba che la pittura non deve avere. La pittura deve essere estremamente libera, estremamente toccante, deve arrivare subito all’osso. C’è tutto in un’unica scena: la scena che vedi è la scena iniziale e quella finale.
AB: C’è un rapporto diverso col tempo, è vero. Si potrebbe immaginare – ma forse non sarebbe interessante – un film, per esempio, fatto di soli istanti? Un film che ha un arco temporale fatto di soli istanti come potrebbe risolversi?
AC: Niente. Fai un’immagine che dura tutto il tempo, come si faceva una volta.
FC: Non so se hai visto Blue di Derek Jarman…
AC: Jarman è superiore… Io veramente lo adoro! Lo adoro proprio. E come diceva anche il nostro Carmelo [Bene, nda], è proprio quello che vale la pena di raccontare… Non il cinemino che ormai siamo costretti a fare. È come se ci stessero veramente dei livelli…
AA: Mi viene in mente L’anno scorso a Marienbad di Resnais: un film fatto di sequenze in cui, come diceva Alessia, ognuna, presa singolarmente, ha un valore assoluto, rappresenta un’unità; e al tempo stesso, prese tutte insieme, queste sequenze danno vita a un legame narrativo enigmatico…
AC: Sì, ma quello è originato da un legame narrativo che parte da una drammaturgia, da un racconto, quindi è già viziato. Non è l’immagine blu di Jarman che dura dall’inizio alla fine del film.
AA: Tu fai cinema e dipingi. Però il cinema lo mostri e la pittura no…
AC: Oh, il cinema lo mostro ma mica tanto! Bagnoli Jungle praticamente non si è visto nelle sale… Non è che questo mi abbia molto turbato… però mi rompe il cazzo. È un po’ come con i quadri. I quadri li faccio, mi piacciono, li vedo per un po’ e poi basta. Certo la comunicazione è importante. Passarsi le esperienze con gli altri. E poi a me in questo momento interessa di più il cinema, e mi diverte farlo. Quando giro mi diverto come un pazzo, come se fosse un gioco, non provo nessuna fatica, zero, lo faccio come se fosse la mia acqua, come se nuotassi… Quando nuoto non faccio fatica perché ormai nuoto in una sorta di surplace… Però nuoto, cammino, non è che sto fermo. Ed è un po’ come con il cinema, il momento di girare è anche una cosa di divertimento… Ed è divertente mettere insieme attori, luci, materiali, mi piace assai!
Dal capitolo Ritrovamenti
(AC: Antonio Capuano, AA: Armando Andria, AB: Alessia Brandoni, FC: Fabrizio Croce)
AC: Anche questo è umano, cercare la sopravvivenza. Però poi cerchi anche la relazione, che è un’altra cosa molto umana. Non c’è un cazzo da fare… Siamo talmente tanto complicati che ancora non ci conosciamo. Infatti gli psicologi annaspano e anch’io annaspo. Mi pare che più il tempo passa, più non capisco niente… Però sono sicuro che tutto è perfettamente umano, di quello ormai ho coscienza.
AA: Ne Il buco in testa il treno riveste un senso e un ruolo particolari…
AC: Quando vedi un treno che arriva pensi all’origine del cinema. È qualcosa a cui personalmente sono molto legato perché il cinema dei Lumière è parte della mia memoria. Si può dire che quando riprendi l’arrivo di un treno in fondo li stai copiando… È bello ricordarsi dei fratelli Lumière. L’inizio è in bianco e nero proprio in omaggio loro.
AB Il treno è rappresentazione del tempo, come un fiume, e siccome, come dicevamo prima, il tempo è fondamentale ne Il buco in testa, a noi che guardiamo ci sembra di stare a contatto con la configurazione che può prendere la memoria, l’interiorità…
AC: Il film inizia con il treno e finisce con il treno… Sai che ormai io prima della proiezione non dico più “buona visione”? Dico “buon viaggio”… Perché secondo me tu paghi il biglietto, si spengono le luci e cominci il tuo viaggio. Sei lì bello comodo, quando viaggi bene, e il film può durare tre ore ma non è mai lungo… Ed è come se diventasse parte del tuo organismo.
AA: Bella questa percezione del film! Come se fosse parte di un’esperienza del corpo….
AC: È un viaggio, è qualcuno che ti prende per mano e ti porta, e tu non lasci la sua mano fino alla fine… è pazzesco! Stai comodo, dovunque tu sia, stai da Dio.
AB: Perché risuona in te, non c’è niente che stona.
AC: Ti dimentichi di te, quella è un’altra cosa meravigliosa. Come quando leggi un buon libro, fai un po’ pace con te stesso.
AB: Da una parte c’è il meccanismo dell’identificazione, però allo stesso tempo non sei tu, sei l’altro.
AC: Esatto. Per me anche quando scrivo è così: quando scrivo i dialoghi di Maria è come se diventassi Maria.
AA: E quando scrivi un personaggio che “non ti piace” come funziona, che succede?
AC: Ti identifichi ugualmente. Shakespeare secondo me si identificava anche in Riccardo, che pure è un uomo di merda su tutta la linea… In quel momento ti appassioni alla vita del personaggio, anche solo per un attimo. E se non ti appassioni rimarrà sempre estraneo a te… Come faccio? Non lo so.
AB: Probabilmente questo ha a fare anche con un’energia … Uno è curioso di quello che accade… E poi c’è la questione della simultaneità di cui abbiamo già parlato, ti piacerebbe stare contemporaneamente in tanti posti… e in tante persone, aggiungo!
AC: Sì, avere continuamente uno sguardo su tutto.
AB: …e con l’arte ricreare i luoghi attraverso il proprio sguardo, superare la limitatezza…
AC: …la limitatezza del reale, che però diventa più del reale: tu capisci che è trasfigurato, ma allo stesso tempo è reale.
AB: … è eccedente!


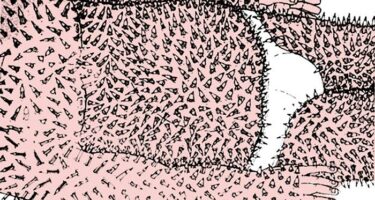


Leave a Reply