
Pull factor. Risuona negli ultimi mesi con frequenza nei contesti più disparati questa definizione, composta da due paroline inglesi che hanno iniziato a essere usate come manganelli da uno schieramento sempre più agguerrito. Fino a poco tempo fa si trattava di una categoria di ambito scientifico, utilizzata prevalentemente nella letteratura sociologica, economica e storiografica. Dalle riviste accademiche e dalle aule universitarie il pull factor è stato repentinamente catapultato sulle bacheche più frequentate dei social network. Si tratta di un passaggio che può sorprendere solo in apparenza, motivato dalla centralità del dibattito sulle migrazioni. Quella di pull factor è infatti una categoria adottata nello studio dei contesti migratori locali e internazionali. Più precisamente, viene utilizzata per descrivere tutti quei fattori che si rivelano determinanti nell’orientare i movimenti di popolazione verso certi luoghi che, proprio per quei motivi, sono più attrattivi di altri.
Già sul finire dell’Ottocento, gli osservatori dei movimenti migratori avevano enfatizzato alcune costanti nei flussi, focalizzando così l’attenzione sui territori di destinazione, sia su scala locale, sia intercontinentale. Il geografo Ernst Georg Ravenstein formulò nel 1889 le sue “leggi”, che cercavano di individuare dei modelli generali con cui interpretare i movimenti di massa che stavano cambiando il volto del pianeta. Successivamente, nel 1966, Everett S. Lee propose una ulteriore sistematizzazione, dividendo in fattori push e fattori pull le ragioni che spingono gruppi di persone a stabilirsi in alcuni territori piuttosto che in altri. Da lì in poi nel mondo scientifico si è avviato un ricchissimo dibattito sulla legittimità e i limiti di queste categorie, sull’importanza delle scelte dei soggetti coinvolti e la conseguente difficoltà a costruire modelli che tenessero insieme le differenze tra i singoli: di genere, generazione, classe, motivazione. Fino a oggi, momento storico in cui il pull factor è tornato in auge e sembra avere spianato la strada a una immensa semplificazione del discorso. Usata in modo superficiale tale categoria perde infatti di significato. Anche volendola accettare (e ci sono decenni di letteratura a contraddire questo presupposto), essa perde totalmente di senso se privata della sua naturale controparte: il push factor.
Per capire meglio di cosa stiamo parlando, limitiamoci a trarre spunto dall’attualità prendendo tre casi in cui è stata tirata in ballo la vicenda del pull factor.
A Roma, alcuni mesi fa, un assessore comunale ha contestato le attività di supporto, assistenza e consulenza organizzate alla stazione Tiburtina dall’associazione Baobab Experience. L’assessore ha sostenuto le sue tesi definendo le attività del Baobab un pull factor per le migrazioni internazionali. Allargando lo sguardo, negli ultimi due anni, le organizzazioni non governative impegnate nelle attività di soccorso nel Mar Mediterraneo sono state accusate da giudici, giornalisti e politici di innescare un processo di pull factor: le attività di salvataggio costituiscono un elemento determinante nella definizione dei flussi di richiedenti asilo verso l’Europa. Espandendo ulteriormente la visuale, in Niger il governo ha tacciato di essere un pull factor il campo profughi dell’Unhcr allestito al confine con la Libia perché incentiverebbe i profughi in fuga dalla Libia a dirigersi verso il Niger.
In tutti e tre i casi siamo di fronte a un’evidente forzatura.
Pensare che ci siano persone che si muovono dalla Siria, dall’Iraq, dalla Libia, dal Mali, dal Sudan alla volta della stazione Tiburtina poiché nel piazzale antistante è attivo un presidio di medici e avvocati è un abbaglio colossale. Lo stesso abbaglio che acceca quanti credono che quattro o cinque navi – piccole e poco equipaggiate – operanti nell’ottavo mare più grande del mondo rappresentino la motivazione decisiva che spinge migliaia di persone a lasciare le proprie case, i propri cari, le proprie terre e rischiare la vita. A quanto pare, anche le classi dirigenti di alcuni stati africani condividono questa lettura delle migrazioni, se in Niger si arriva a sostenere che la presenza di un campo profughi costituisca da solo un elemento in grado di orientare verso sud la fuga da un paese dilaniato come la Libia.
È sufficiente guardare con un briciolo di razionalità alle migrazioni internazionali per liberarsi della pervasività di simili abbagli. Per riuscire a recuperare uno sguardo lucido occorre essere disposti a contestare alla radice le basi su cui si sviluppa l’attuale dibattito pubblico sulle migrazioni, partendo proprio dall’utilizzo di alcune categorie che potrebbero sembrare neutrali ma che nascondono una lettura strumentale e lontana dalla realtà e dalla complessità dei fenomeni in atto. Senza questa accortezza può succedere di tutto. Addirittura può succedere che una categoria interpretativa venga brandita come un capo di accusa sui giornali, sui social e nei tribunali.
I fenomeni migratori sono legati all’azione delle persone che ne sono protagoniste e agli scenari globali che favoriscono la mobilità. Inoltre, in tutti e tre i casi brevemente descritti siamo di fronte a migrazioni forzate, che nello scenario più recente sono in aumento per le motivazioni più diverse: ricondurli in modo coatto a una spiegazione deterministica è fuorviante e ridicolo. È una pratica sguaiata, utile forse a regolare i conti con qualche soggetto sgradito o per acchiappare una manciata di visualizzazioni in più, ma è del tutto inutile se si vuole davvero arrivare a cogliere la dinamica strutturale dei movimenti di popolazione. (michele colucci)


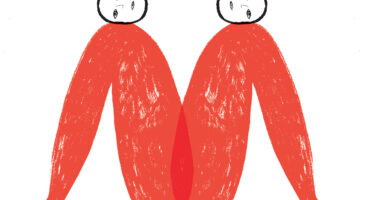


Leave a Reply