2016, poche ore all’avvento della primavera. Tra merci cigolanti, trolley di fortuna e uomini sfiniti intravediamo la M/V Catania. O meglio, solo la sagoma, tracciata dalle luci del porto di Salerno quando la città già dorme. Questo traghetto merci e passeggeri, varato nel 2003 dai cantieri Visentini di Rovigo, ha una stazza lorda di ventiseimila tonnellate, viaggerà in direzione Tunisi con una velocità di ventitre nodi, è lungo centottantasei metri e può ospitare fino a mille passeggeri. Le operazioni di imbarco, gestite con piglio da un addetto alla sicurezza, procedono regolarmente, ma è la smania della “sistemazione”, con il vento che non dà tregua, a rendere interminabile l’attesa. I compagni di viaggio sono soprattutto tunisini.
Hanno i panni addosso di chi il passaggio sulla nave lo vive come condizione perenne, non come viaggio. Lavorare e tornare a casa. A loro non capita ogni sera, se va bene una volta ogni tre mesi. Al ponte sei, alla cabina 6120, ci accompagna Juan. Ha i tratti garbati del centro America. Carlos il barista, invece, proviene da Tegucigalpa, Honduras. Lo incrociamo tante volte nel corso del viaggio. Eppure mai sfuggente è il suo sguardo, sfodera il suo sorriso sincero invitandoti a fare due chiacchiere. Mi dice che l’equipaggio è in gran parte composto da honduregni, filippini e italiani. Uno di questi, Luigi, fa il commesso nella boutique. Vende felpe, souvenir, sigarette esentasse. Prima d’imbarcarsi faceva il lavoratore stagionale a Lignano Sabbiadoro. Sei mesi all’anno ad assecondare i bisogni dei turisti tedeschi. I nervi di Luigi che non reggono più a furia di vederli sempre ubriachi nei giorni di Pentecoste. Ripercorro i corridoi, le indicazioni mi riconducono in cabina. L’oblio penetra dall’oblò. Senza stelle è oscura la notte in mare, le palpebre s’abbandonano e naufrago nel sonno.
Il risveglio. Dal ponte Sole si vede Palermo. Comincio a intuire l’architettura della nave. Un carretto siciliano è posto all’ingresso di un cantiere. La strada che conduce al porto è in rifacimento. Dal ponte sei la si vede in tutta la sua lunghezza, oltre le macchine disposte sul ponte levatoio. Alcune automobili hanno i tetti traboccanti di casalinghi, c’è chi porta tavolo e sei sedie, chi un divano. Una pinza stretta al cerchione tiene ferme le auto in caso di mare agitato. O meglio, in caso di “mare”. Il comandante dice «c’era un po’ di mare», riferendosi al rollio di qualche viaggio memorabile. Il mare è assente quando non brontola.
Ci sediamo ai margini dell’elisuperficie. Sarà un viaggio d’attesa più che d’azione, di lunghi minuti d’osservazione. Bisognerà calibrare ogni passo, ogni sigaretta, ogni parola. In Italia, dove ancora siamo, è il giorno del papà. E a dieci metri da noi padre e figlio, con gli stessi occhi, guardano Palermo come s’assiste a uno spettacolo. Il figlio parla in napoletano ad alcuni suoi coetanei, dichiarando il suo culto per i jeans stretti al polpaccio.
Alla reception il baffuto Giuseppe spiega che la durata dell’imbarco dipende dal grado. Solitamente gli allievi restano un paio di mesi. Il commissario di bordo, il messinese Alessio, invece, soffre di quella che lui chiama “malattia dell’acqua salata” o “malattia del ferro”. Sulla terraferma, insomma, diventa irrequieto, ha bisogno del mare come condizione necessaria e sufficiente. Evita i contatti fugaci con i parenti al porto di Palermo perché non faranno altro che alimentare la sensazione di assenza, di precarietà, di distacco. Il padre lavora ancora a bordo, è comandante per un’altra compagnia. Quando Alessio era piccolo i genitori sognavano per lui un mestiere diverso: «Non ti imbarcare. Troppo tempo lontano dalla famiglia!». E il ragazzino diventava competitivo, più gli parlavano di terraferma più sognava il mare aperto. «La responsabilità è mia, è il lavoro che ho scelto di fare. Di aspetti negativi ce ne sono, eccome. Incrociare mio padre in porto e potergli parlare solo via radio. Ma è il mio mestiere, nessuno mi ha obbligato a farlo. Ho la laurea in giurisprudenza, ma la considero una forma di rispetto verso i miei genitori. In realtà avevo già scelto di passare la mia vita su una nave. Fuori dal porto mi sento libero e incatenato».
Nella sala comune i tunisini hanno trovato la qibla, la direzione della preghiera, e c’è la fila per andare al bagno. Prima di genuflettersi ci si lava. Ricopio gli appunti e noto che tra le formule di rito c’è un segno di pace, un uomo si volta verso l’altro e gli dice qualcosa di beneaugurante. Alcuni intorno a me dormono sul fianco, dietro di loro buste rigonfie che sembra stiano per esplodere. Provo anche io a scrivere in quella posizione, sotto di me la nave si distende e si contrae come un muscolo. Uno sconosciuto che t’accarezza. Eppure ci si abitua. «Oggi sorpresa!», esclama il ragazzo al di là della tavola calda. Ha la tendenza a curvare la schiena, l’andatura dinoccolata, come per dosare le forze in vista dei tanti giorni da passare a bordo. Timballo alla siciliana, nasello e patate, lasagna al pesto, qualcuno comincia a riempirsi i vassoi.
Ci sono cinquantaquattro marittimi sulla M/V Catania. Sul ponte di comando gli ufficiali più alti in grado controllano le loro apparecchiature. Ogni strumento, spiega il comandante genovese Antonio Fina, ha un proprio “doppione”, per legge. Il radar indica che stiamo per superare le isole Egadi, a sinistra s’intravede il Monte Falcone di Marettimo, davanti a noi s’apre il canale di Sicilia. «È il punto più pericoloso del Mediterraneo. Qui si ripercuotono le perturbazioni del golfo del Leone». Il mare oggi è mansueto. La vedetta scruta l’orizzonte con il binocolo. Chiedo del marconista: dov’è, cosa fa?: «Forse hai visto troppe volte Titanic. È una figura che non esiste più da decenni. Ormai si fa tutto con il telefono, internet, whatsapp». Scendiamo nella sala principale. La tv accesa cattura gli sguardi.
Arriva a noi un coro di voci siciliane. Un gruppo di pescatori discute a voce alta, due si sfidano e gli altri ridono, rinfrancati dal vino in cartone con il quale hanno accompagnato le sardine. Anni fa hanno aperto una piccola ditta mista, italo-tunisina. Pescano i gamberi reali, che nei golfi tunisini abbondano, e sono d’una specie pregiata. «I tunisini hanno visto noi pescarli, hanno capito che per un chilo di quelli ti pagano quanto la pesca di un mese intero e hanno cominciato a pescarli anche loro. Costruiscono le reti osservando noi». I gamberi vanno all’indietro e indietro andiamo pure noi, capaci di alzare muri dove qualcuno, millenni fa, immaginava ponti. «Ma lo sai che da Mazara del Vallo, di sera, si vedono le luci di Kelibia?». (testo di davide schiavon, disegni di diego miedo)

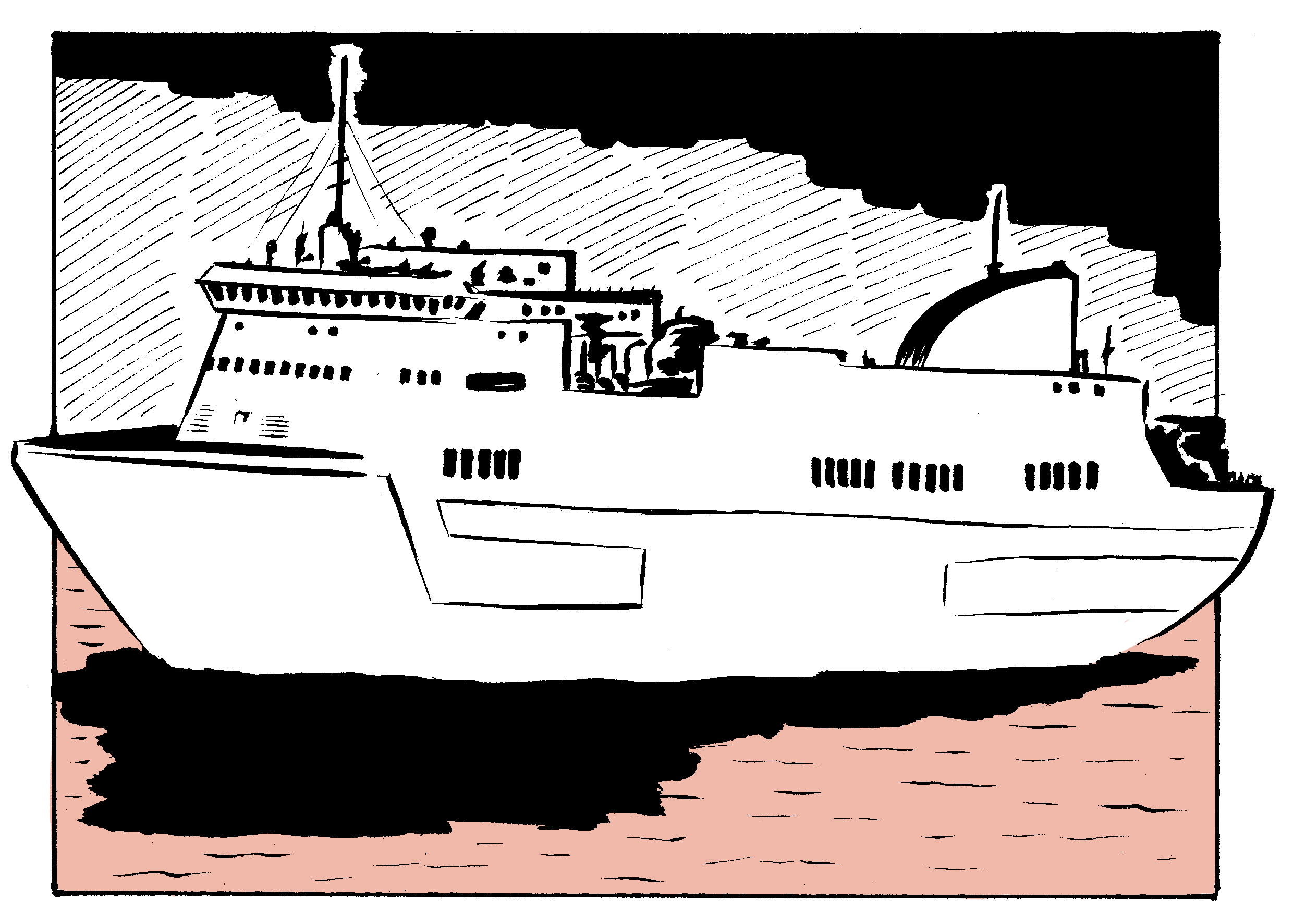










Leave a Reply