
“Sono vivo, ma non sto vivendo”, scriveva Ray Osheroff durante il periodo di cura trascorso negli anni Settanta al Chesnut Lodge, un istituto psichiatrico di élite situato nella zona più ricca del Maryland. Osheroff, un frenologo affermato, vi fu condotto al seguito di sintomi depressivi e idee suicidarie. La seconda moglie minacciò di lasciarlo e il suo socio in affari, con cui gestiva tre costosi centri per la dialisi, gli fece capire che se non si fosse fatto ricoverare per i suoi disturbi lo avrebbe allontanato dal lavoro. Osheroff, dotato di una non banale cultura musicale e letteraria, lesse in un libro del Chesnut Lodge, una clinica avanguardistica che prometteva di psicanalizzare ogni paziente, trattandolo come un membro di un’ideale famiglia, e di guarirlo senza il ricorso agli psicofarmaci. Al Lodge Osheroff peggiorò sensibilmente. Anche se la filosofia della clinica prevedeva di instaurare un rapporto empatico di mutua comprensione con il paziente, nei referti desecretati emerge un chiaro fastidio degli psichiatri nei confronti di Ray, il quale risultava semplicemente troppo complesso per adattarsi ai metodi del Lodge, oltre che poco collaborativo. “Se resta in cura dai cinque ai dieci anni potrebbe avere buoni risultati”, chiosava al margine di una riunione il suo medico di riferimento. Dopo quasi un anno la madre, accortasi del deterioramento delle condizioni del figlio, decise di trasportarlo di forza in un’altra struttura, dove iniziarono a somministrargli un antipsicotico e un antidepressivo. In pochi mesi Osheroff sembrò stare decisamente meglio, riprendendo interesse per la vita. Una volta fuori dalla clinica scoprì che la moglie si era trasferita con i figli in Europa e che il socio, dopo un breve periodo di prova in cui manifestò la sua insofferenza nei confronti della fragilità e delle stranezze di Ray, aveva aperto un centro concorrente, portandosi con sé clienti e dipendenti. Nella mente di Osheroff si fece sempre più pressante un’idea: che il Lodge gli avesse rovinato la vita e che la sua malattia consistesse in un semplice scompenso biochimico. Decise di fare causa all’istituto. L’udienza preliminare durò due settimane ed è entrata nella storia americana della psichiatria. Gli esperti chiamati al processo dal Lodge sottolineavano che l’insistenza di Ray Osheroff sulla natura biologica del suo male fosse solo una forma di deresponsabilizzazione. Uno psichiatra convocato da Ray, Frank Ayd, che aveva condotto le prime sperimentazioni sul farmaco antidepressivo da lui assunto, si scagliò invece contro i metodi del Lodge: “Non si ottiene nessun vantaggio da una comprensione intellettuale degli aspetti psicologici del male”. Gli avvocati del Lodge decisero di patteggiare, versando una cospicua cifra a Osheroff. Per evitare altre cause, iniziarono a prescrivere farmaci a tutti i loro pazienti. L’approccio neurobiologico, rafforzato dalla più recente versione del DSM (il manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, che a partire dalla sua terza edizione aveva ripulito le malattie dai loro aloni psicanalitici trasformandole in una lista di sintomi), sarebbe stato per lungo tempo l’unico ammesso.
Negli anni Ottanta negli Stati Uniti era iniziata una rivoluzione che da qualche anno tocca anche noi europei da vicino, soprattutto dopo l’ampia diffusione degli SSRI, gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina. I fautori della visione fisiologica parlarono di “un trionfo della scienza sull’ideologia”, ma sembravano dimenticare quello che lo stesso Schildkraut, l’inventore della così detta teoria dello squilibrio chimico (oggi parecchio ridimensionata se non del tutto confutata stando alla stessa letteratura scientifica), aveva detto: “La mia è una semplice ipotesi […] si tratta, nel migliore dei casi, di un’ipersemplificazione riduzionista”. Nonostante ciò, tutt’oggi si è soliti parlare dei propri disturbi mentali come di fluttuazioni di sostanze chimiche nel cervello. E su questa ipersemplificazione riduzionista la psichiatria contemporanea ha costruito per lungo tempo, spalleggiata dall’ontologia aziendale neoliberista, il proprio fortino. Dopo il processo Ray Osheroff è stato a lungo disoccupato, prima di finire invischiato in un caso di truffa aggravata ai danni della sanità americana. È invecchiato solo, deluso tanto dalla psicanalisi che dalla psicofarmacologia, anch’essa alla lunga dimostratasi incapace di curarlo. Per i figli, verso i quali non è mai stato capace di provare un reale interesse, era sostanzialmente un estraneo. Le circostanze della sua morte, avvenuta nel 2012, non sono state mai chiarite.
Quella di Osheroff è una della cinque storie ricostruite e raccontate, attraverso un minuzioso lavoro documentario e investigativo, da Rachel Aviv (già autrice di numerose inchieste per il New Yorker) nel suo Stranieri a noi stessi, libro portato in Italia da Iperborea nella limpida traduzione di Claudia Durastanti, che testimonia il sempre maggiore interesse della saggistica generalista verso il disagio psichico. Negli ultimi anni il discorso sulla salute mentale è entrato di prepotenza dentro i nostri feed, nelle riviste, negli articoli che leggiamo e nei podcast che ascoltiamo. Ma la qualità di questi contenuti è ancora molto discutibile, il più delle volte basandosi su un tono sensazionalistico, su una regressione emotiva (il malato come oggetto di compatimento) o su un intento terroristico-cospiratorio (i big pharma con il consenso dei nostri psichiatri ci stanno avvelenando). Manca ancora cioè, in materia, una vera e propria educazione. E una solida stigmatizzazione prospettica risulta difficile da smaltire. Anche se ormai, per quanto detto sopra, si tende in parte a deresponsabilizzare il soggetto affetto da disturbi e la sua famiglia, attribuendo l’origine del male molto spesso a fattori fisiologici e altre volte (meno) a ragioni contestuali e sociali (ci torneremo), l’atteggiamento tipico di fronte alla malattia mentale rimane ancora misterico ed elusivo, reticente.
Certo, sempre più celebrities denunciano di aver sofferto di depressione o di altri disturbi, ma, anche quando lo fanno con buone intenzioni, le loro dichiarazioni sembrano rilasciate più che altro per generare consenso, e si amalgamano nella macchina informe dell’infotainment, diventando di fatto inerti, quando non vogliono esplicitamente rafforzare uno stereotipo edonistico (il male chic). In generale, c’è qualcosa che ancora impedisce il riconoscimento dell’altro (il malato) come il medesimo (almeno sotto a un certo livello di censo o di credito sociale). Se dei passi avanti si stanno facendo è grazie a dei contenuti autoprodotti dal basso, profili social e video Tik Tok dove ragazze e ragazzi appena maggiorenni offrono la loro testimonianza di periodi trascorsi in cliniche psichiatriche, descrivendo i loro disagi, le loro abitudini, in una maniera asciutta e priva di retorica, offrendo sostegno a tante persone che si riconoscono in quelle storie. Se questo articolo ha una tesi è la stessa del libro che sta recensendo: ascoltate quello che i malati hanno da dire. Riscattate tutte le ore passate a studiare Freud nella biblioteca di dipartimento leggendo le Memorie di un malato di nervi del presidente Schreber. Ma ricordate un avvertimento molto prezioso che più volte Aviv ripete: molto spesso la fabulazione della malattia è parte stessa del suo estrinsecarsi. Ci sono storie che salvano, e storie che condannano.
Filosofi, sociologi e studiosi di psichiatria, appoggiati da grafici, sondaggi e una pletora di dati, ci suggeriscono che sia in corso una vera e propria epidemia che riguarda la nostra salute mentale. Sintomi ansiosi e depressivi sono parte integrante della società della performance e dell’apparire, del mondo atomizzato e iper-competitivo in cui viviamo. Ogni prospettiva di futuro (vuoi per la catastrofe climatica, le condizioni lavorative sempre più castranti, la povertà dilagante e un’insostenibile ingiustizia sociale) si sgretola in un presente invivibile che cede sotto i nostri piedi, viscoso, nebulizzato e ineludibile come un sogno.
I primi diagnosti dell’individualismo contemporaneo (Lasch, Sennett, Lipovetsky e altri) vengono trattati dai ricercatori di cultural studies come oracoli (in parte non a torto). In un saggio dello scorso anno (Soffro dunque siamo. Il disagio psichico nella società degli individui, minimum fax) Marco Rovelli riconosceva come questa condizione endemica fosse ancora incapace di creare una comunità su larga scala basata sulla solidarietà reciproca (soluzione che si auspicava). Sulla scia di Fisher, Rovelli interpreta il disturbo mentale come il costo del nuovo spirito del capitalismo (Boltanski-Chiapello), il quale, come già tempo addietro è stato detto, introietta all’interno della soggettività attitudini schizofreniche e patogene (Deleuze-Guattari, Jameson), o bipolari (Marazzi), mentre per lo psicanalista lacaniano Marco Lolli è il disturbo borderline la figura che contraddistingue l’era iper-moderna. La malattia mentale viene trattata da questi studiosi come un fenomeno sistemico e strutturale. E del resto fu lo stesso Freud a riconoscere come i disturbi psichici nascessero dalle difficili condizioni di mantenimento dell’entropia della Zivilisation, e non a caso, Fisher ritorna in più punti su un testo determinante come Il disagio nella civiltà, dove la svolta inaugurata con Al di là del principio di piacere approda a una soluzione apocalittica e nietzschiano-leopardiana.
Se il picco dei disturbi mentali è confortato dai dati, questi vanno però interpretati al netto del massiccio intervento di medicalizzazione a cui la società fa sempre più ricorso, dovuta da un lato alla pervasività dell’approccio scientista neurobiologico e della pressione sociale (bisogna essere sempre sul pezzo, e ciò a lungo andare diventa insostenibile; la sofferenza o un tono dell’umore fiacco non sono compatibili con ciò che ci è richiesto dall’ecosistema con cui interagiamo), dall’altro all’aziendalizzazione della sanità, costretta dai governi a ragionare anch’essa in termini di costi-benifici (naturalmente in Nord America ciò risulta molto più visibile); motivo per cui appare più conveniente fare diagnosi affrettate e prescrivere farmaci a persone che non hanno nessun disagio grave e si rivolgono a degli specialisti in un momento di difficoltà. È un’esperienza che facciamo anche in Italia, e credo che ognuno di noi abbia un conoscente a cui è stata consigliata una cura farmacologica che al posto di risolvere i problemi li ha invece cronicizzati, causando alterazioni sostanziali della plastica neuronale e, talvolta, finendo per generare effetti collaterali che devono essere trattati con altri farmaci, configurando il tristemente noto effetto a cascata. Piuttosto che intraprendere un gravoso percorso di cura e di analisi (che del resto non tutti possono permettersi privatamente, mentre le strutture pubbliche sono al collasso – almeno nel Sud Italia, che è l’unico contesto che conosco da vicino), si ricorre sempre più facilmente ai farmaci per alleggerire le pressioni a cui sono sottoposti gli operatori sanitari, trasformati ormai in burocrati per i quali i pazienti sono sempre più simili a clienti da “correggere” e congedare nel minor tempo possibile, senza tener conto della loro storia personale (numeri e sintomi da medicalizzare). Il sostegno principale è sempre la diagnostica classificatoria del DSM, che ha infinitamente allargato e depersonalizzato lo spettro della malattia mentale. Di fatto, la stessa esistenza del manuale ha trasformato casi di normale, umana tristezza in disturbi gravi, per il semplice motivo che molto spesso i sintomi sono gli stessi. Certo, risulta sempre più difficile capire dove finiscano la sofferenza, il carattere, le inclinazioni personali, le idiosincrasie, e dove inizi la patologia. Ma questo sembra un lavoro che molti psichiatri semplicemente non vogliono più fare (o non hanno il tempo di fare). Il risultato è che se riduciamo la malattia a un elenco di sintomi privato di un ambiente, di un contesto e di una storia individuale, tutto può essere malattia.
C’è una cosa che rileggendo gli scritti di Fisher e di Rovelli (e uno dei loro riferimenti, Il capitalista egoista di Oliver James) e confrontandoli con il libro di Aviv credo sia urgente specificare. C’è un che di deterministico nel collegare univocamente la malattia mentale alle condizioni di esistenza e di produzione nella società neoliberista. Nelle pagine di Realismo capitalista Fisher afferma che il problema dell’ansia e della depressione va reinquadrato e generalizzato, e che la risoluzione dei problemi psicologici non possa gravare sulle spalle del singolo. Il disturbo mentale non va privatizzato, e il focus deve spostarsi dall’individuo a un mondo che trova normale che tante persone, soprattutto giovani, soffrano. Difficile essere in disaccordo con l’ultima affermazione, ma c’è un che di meccanicistico nella visione di fondo. A ben vedere, come detto più sopra, la stessa svolta neurobiologica che ha contribuito alla crisi attuale insisteva sulla deresponsabilizzazione dell’individuo – spostando la colpa della malattia su agenti chimici malfunzionanti nel nostro cervello. Porre in risalto il ruolo dell’ambiente (famiglia) e del contesto sociale nell’eziologia del disturbo è fondamentale, ma a patto che la riflessione metta al centro la storia personale del soggetto (che certo, è frutto della relazione con ambiente e contesto). La malattia mentale è sempre unica, personale, privata – consistendo appunto nella reazione dell’individuo all’esposizione a queste forze, dovuta tanto a fattori biologici quanto al vissuto materiale e alla sua enciclopedia emotiva (del resto l’interrelazione tra genetica e fattori sociali è comprovata dalle ricerche scientifiche più recenti: il disagio psicosociale cronico comporta una modificazione epigenetica sensibile, un marcatore capace di trasmettersi da generazione in generazione). Essa è la reazione cifrata ma razionale (Freud) alle condizioni e ai traumi a cui il soggetto è sottoposto. È una metafora. Un linguaggio privato che chiede ascolto. Questo non vuol dire che chi è malato scelga di essere malato, o che vada colpevolizzato per essere malato o incapace di guarire, tutt’altro. Temo che cose come la volontà c’entrino molto poco con la malattia. Riassumo con le parole di Aviv: “La teoria dello squilibrio chimico, che si era diffusa negli anni Novanta, è sopravvissuta così a lungo forse perché la realtà – cioè che la malattia mentale sia causata da un’interrelazione tra fattori biologici, genetici, psicologici e ambientali – è più difficile da concettualizzare. Così niente ha preso il posto di questa teoria” (mi rendo conto che il discorso andrebbe smussato, e che il recente modello bio-psico-sociale si propone proprio di affrontare un simile tipo di malattia, attraverso un approccio integrato farmaci più psicoterapia o riabilitazione psichiatrica. Ma Aviv non vi fa riferimento).
Il principale merito di Stranieri a noi stessi è perciò proprio quello di analizzare la malattia quasi in termini narratologici, mostrando come essa si basi su una storia – autoprodotta o indotta – capace in alcuni casi di diventare un carattere, permeando ogni settore dell’esperienza e calcificandosi nei casi peggiori in un destino (in una mitologia). Che il disagio mentale dipenda (anche) da un processo ermeneutico, e che questo sia al centro delle reazioni con cui il singolo metabolizza il prodotto delle circostanze, è una verità banale, ma che il più delle volte sfugge. Aviv non riporta, come nella letteratura psicanalitica o psichiatrica, casi clinici, bensì racconti di vita, vere e proprie novelle, redatte attraverso interviste, documenti e memorie prodotte dagli stessi soggetti in gioco (tutti i personaggi del libro hanno affidato alla scrittura, a veri e propri memoriali, il decorso narrativo del loro disturbo). Bapu, Ray, Hava, Naomi e Laura compaiono con i loro nomi e cognomi, si trovano su Google, ascoltiamo la loro voce, non quella di un mediatore: “‘Un depresso non mette solo in atto i sintomi. Fa un’esperienza diversa del mondo. Usa il linguaggio in maniera diversa. Sperimenta le emozioni in maniera diversa’. […] I dottori rischiano di fraintendere perché la malattia mentale sa isolare così tanto chi ne soffre, alterandone la vita in modi che non possono essere evinti solo dai sintomi. Le vite delle persone con disturbi mentali sono state cancellate dai racconti ufficiali […], ma ‘nello scrivere la storia e le storie personali, ci facciamo sentire’” (i virgolettati sono di Bhargavi, la figlia di Bapu).
Se il caso di Ray è servito all’autrice per discutere dell’avvicendamento tra l’approccio psicoanalitico e quello neurobiologico, la vicenda di Bapu, discendente di una famiglia braminica di Chennai, nell’India del Sud, serve a denunciare il bias coloniale (e le discriminazioni di genere) nel trattamento della malattia in un sistema di valori che non è quello Occidentale. Nelle storie per certi versi speculari di Naomi e di Laura è mostrata invece in maniera palmare l’incapacità degli psichiatri di intrecciare i dati e le letture, finendo, con le loro diagnosi, a censurare l’individualità del paziente. I medici che prendono in cura Naomi si rifiutano di dare ascolto alle rivendicazioni etniche e di classe della donna, non considerandole elementi intrinsechi alla malattia (e ciò permette ad Aviv di tracciare una vera e propria storia del razzismo nella psichiatria). Ugualmente nel caso di Laura, appartenente a una delle famiglie più facoltose degli Stati Uniti, un mancato riconoscimento dello stress ambientale e contestuale (“la vita di Laura appariva così libera da ostacoli che qualsiasi genere di sofferenza veniva ascritto alla patologia”) ha spinto i dottori a un approccio riduzionistico e a una prescrizione scriteriata di farmaci, minando la capacità affettiva della paziente. A incorniciare queste storie è la vita di Hava, doppio dell’autrice, e da lei incontrata nel 1988 nel reparto di un ospedale nei pressi di Detroit. Rachel Aviv ha sei anni, mentre Hava, una sorta di modello, dodici – entrambe soffrono di anoressia. Se Aviv riesce a svincolarsi dalla malattia è anche perché, vista l’età, è ancora esclusa dalle storie. Non sa bene perché si trova là, sta attenta a seguire le indicazioni dei medici (ciò che le avrebbe permesso di ricevere visite e di rivedere la madre), e in breve tempo viene dimessa. Hava, invece, farà dell’anoressia una “carriera”.
Quello che hanno in comune i vari personaggi è il loro perenne disorientamento, l’incapacità di capire dove risieda la loro identità, il loro vero sé – risucchiato dalle cure farmacologie e da un isolamento (che è una cosa diversa dalla solitudine) sempre più spesso che è insieme causa e conseguenza della malattia. Certo, come riconosciuto già da Lacan (via Kojève) l’identità è per sua natura alienata, e disponibile solo in una dimensione relazionale. Ma nelle pagine di Stranieri a noi stessi seguiamo in modo ondivago le oscillazioni di persone che non capiscono se i farmaci gli abbiano salvato la vita o gliel’abbiano compromessa, offrendo loro una personalità surrogata. Tra questi due poli si increspano decine di sfumature, nessuna delle quali capace di offrire un vero conforto o di dare risposte. Una delle tesi forti di Aviv (in direzione opposta va Rovelli) è che per i disturbi mentali non si possa quasi mai davvero parlare di guarigione, ossia tornare a uno stadio del sé precedente alla malattia. Molto spesso, tanto una terapia farmacologica che una psicanalitica, non portano alla salute, ma a una parodia della salute. Avere un buon insight, guadagnare una buona consapevolezza dei motivi psicologici e sociali che hanno condotto alla malattia non fa smettere di soffrire. Il dolore e il disagio permangono anche una volta scovate le cause. Scrive la psicologa Pat Deegan, a cui è stata diagnosticata la schizofrenia a diciassette anni: “Per quelli di noi che lottano da anni, la storia della restituzione a se stessi non è reale. La guarigione non si riferisce a un risultato [ma] è contrassegnata da un’accettazione sempre più profonda dei nostri limiti […] il cammino diventa la trasformazione, invece del ripristino di ciò che c’era prima” (cito da Aviv). La malattia è un orizzonte di senso difficilmente superabile. La cura è un fondamentale strumento di gestione e riduzione del danno, che può permettere di vivere una vita appagante, di rompere l’isolamento, ma funziona meglio quando è ripulito da qualsiasi aspirazione palingenetica, dalla coazione seriale del redemption arc.
Il libro di Aviv fotografa un quadro frastagliato e complesso senza mai arrivare a risposte univoche e rassicuranti (per es. come spesso accade gli psicofarmaci non sono demonizzati, ma è messo in risalto il meccanismo nocivo e autotelico che sta alla base della loro distribuzione; la psichiatria non è confusa con la cattiva psichiatria, ecc.), mantenendo un atteggiamento di fondo che chiama, rifacendosi a William James e a Keats, “capacità negativa”: “stare nelle incertezze, nei misteri, nei dubbi, senza essere impaziente di pervenire a fatti e ragioni”. (fabrizio maria spinelli)


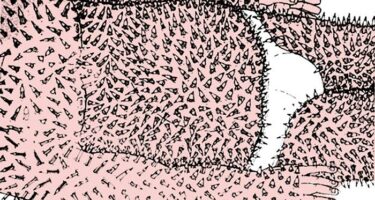


Leave a Reply