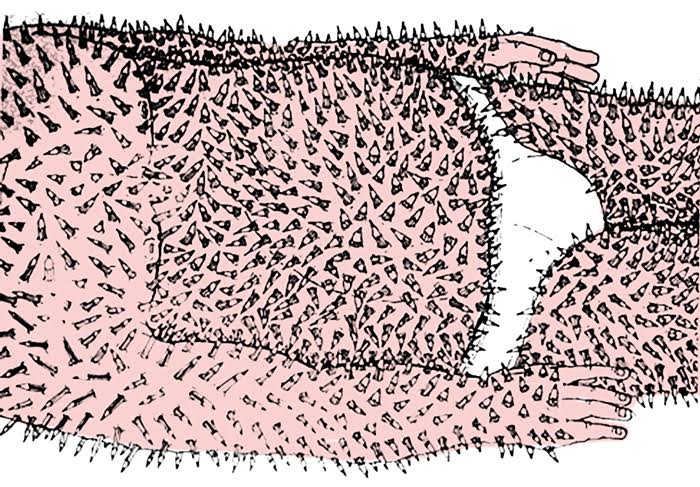
Quella dell’arte pubblica è una categoria molto ampia che da decenni costringe gli addetti ai lavori a interrogarsi più o meno sempre sulle stesse questioni di fondo: cosa si deve intendere per spazio pubblico e per uso pubblico dello spazio; quale relazione intercorre tra l’artista e gli altri attori della progettazione urbana; quali sono i margini di libertà e autonomia dell’artista e dei fruitori; chi sono i veri destinatari dell’opera. A queste domande si è risposto in modo diverso in base ai contesti, alle geografie, al clima politico; e in base ai periodi si è scelto a quale domanda dare più o meno importanza. Se per arte pubblica intendiamo quelle opere che occupano lo spazio pubblico per volere delle istituzioni, osservare queste espressioni del potere ufficiale ci aiuta a comprendere più a fondo i suoi discorsi, interessi e obiettivi, e a formulare le nostre risposte. Oggi, dalla prospettiva di chi è interessato a inquadrare il ruolo dell’arte nei processi di riqualificazione urbana, vale la pena chiedersi cosa sta producendo la convergenza di interessi pubblici e privati, se esistono caratteri di novità rispetto al passato e in che modo la società civile percepisce queste eventuali svolte. Due casi osservati di recente a Napoli e Torino, per esempio, fanno pensare che l’arte pubblica di oggi, oltre alla tradizionale funzione celebrativa delle istituzioni committenti, sta svolgendo una più peculiare funzione di supporto al controllo e disciplinamento sociale.
Penso al progetto Open. L’arte in centro, parte del programma Napoli contemporanea, voluto dal sindaco Manfredi e curato dal suo consigliere per l’arte contemporanea e i musei Vincenzo Trione, storico dell’arte, critico e curatore. L’iniziativa si propone l’intento (inafferrabile) di “rafforzare la vocazione al contemporaneo della città” di Napoli attraverso una serie di iniziative pensate per gli spazi pubblici e i siti museali. Tra le installazioni previste dal progetto, una in particolare ha acceso il dibattito a livello locale e nazionale: la Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto (riproduzione in scala monumentale della prima versione del 1967), realizzata apposta per piazza del Municipio, dove è stata collocata lo scorso giugno. La Venere è considerata “una delle opere più iconiche dell’arte del Novecento” e la sua esposizione in piazza è raccontata dai suoi promotori come “un gesto dal grande significato culturale e sociale, un invito aperto a cittadini e visitatori a vivere la piazza come un luogo di relazione e di dialogo quotidiano e uno stimolo alla riflessione e alla partecipazione, consentendo a tutti di riscoprire e di riappropriarsi della città”. Per il sindaco è “il segno di una Napoli che è fiera della propria storia e tradizione, ma che è anche proiettata verso il futuro, che sa che i luoghi si devono trasformare, che ci vogliono segni di contemporaneità…”. Per Pistoletto è un omaggio al suo “lunghissimo” rapporto con Napoli.
La presenza della Venere in piazza ha provocato commenti critici sul suo essere “calata dall’alto”, estranea a qualsiasi relazione con gli abitanti. Quando questa osservazione è stata rivolta all’artista, egli ha glissato la domanda rispondendo che “la Venere rappresenta la bellezza che non finirà mai di esistere e che trasforma gli stracci in qualcosa di nuovo, di meraviglioso”, e via dicendo. Il rapporto che Pistoletto vuole omaggiare, così, sembra più quello con le istituzioni che gli permettono di usare Napoli come vetrina personale che quello con gli abitanti. In ogni caso, più che l’opera in sé, a creare scandalo è stato l’incendio appiccato poco dopo il suo allestimento. Tra politici, critici e artisti l’accaduto ha scatenato un misto di giustizialismo e perbenismo, paternalismo e classismo. Si tratta di un gesto vandalico che “va stigmatizzato” senza se e senza ma (Trione), un atto talmente brutale e insensato che può trovare giustificazione solo nella “follia” del suo autore – un trentaduenne senza fissa dimora che, secondo le indagini e la stampa, soffre di “problemi psichiatrici”. Allo stesso tempo, l’episodio diventa il pretesto ideale per riproporre l’antica narrazione che vede i napoletani come un popolo di ignoranti e barbari che non è ancora pronto a ricevere il dono salvifico dell’arte. Politici e critici non perdono occasione per ribadire la natura indisciplinata e selvaggia di una società che va educata alla bellezza e, in definitiva, civilizzata attraverso di essa.
Gli oppositori politici del sindaco, poi, approfittano per invocare maggiori dispositivi di sicurezza: gli stracci che fanno parte dell’installazione dovevano essere ignifughi e si doveva prevedere un sistema di videosorveglianza della piazza. Incassate le critiche, i promotori della Venere non si arrendono e ricevono la solidarietà dei benpensanti. Un’associazione locale lancia una campagna di crowdfunding per la ricostruzione dell’opera e, dopo mesi, il 6 marzo questa torna in strada. Il sindaco spiega che la sua ricollocazione serve a “ribadire il fondamentale principio dell’arte pubblica e gratuita come strumento di bellezza e inclusione”. Il curatore afferma che “la nuova Venere ha valenza storico-artistica, ma soprattutto civile e politica”. L’artista si fa benefattore: finanzia di tasca sua la “nuova Venere” e devolve i fondi raccolti a due associazioni che operano nel sociale. “Nel mio lavoro non c’è difesa. La Venere degli stracci deve essere un’opera aperta”, dichiarava Pistoletto subito dopo l’incidente di luglio. Nel frattempo, però, l’autore dell’incendio finisce in carcere con una condanna di quattro anni, e in pochi contestano questa pena sproporzionata. Ma le cronache locali, anziché a queste voci, dedicano spazio alle rimostranze di una consigliera regionale che critica la ricollocazione dell’opera per i costi della guardiania necessaria a garantirne l’incolumità. Dalla reinstallazione della Venere, infatti, la piazza è presidiata da vigilanti pagati dal Comune.
Nella narrazione degli attori della riqualificazione urbana, ancora, l’autore dell’incendio è “una persona che ha un bisogno profondo, e la Venere può offrire la risoluzione a questo sogno”. Nei suoi confronti, il paternalismo assume toni misericordiosi, perché il soggetto deviato “sta collaborando”. Per Pistoletto non dovrebbe stare in carcere, ma andrebbe curato; e a quanto pare la cura che si prospetta per questa persona è un percorso di rieducazione che lo vedrebbe impegnato a fare da guida ai visitatori dell’opera, una volta che questa avrà trovato una sede permanente all’interno di una chiesa del centro storico. Altro motivo di orgoglio, infatti, è che la sua ricollocazione è figlia “di un lavoro collettivo, di comunità, poliautoriale” – dichiara il curatore. Quella di cui parla, però, sembra più che altro una comunità di poteri (del pubblico, dei privati, del clero, della stampa) che si completano, autoriferiscono e autolegittimano.
L’esempio osservato a Torino ha una genesi diversa, ma le ricadute simboliche e materiali dell’opera pubblica in questione sono simili al caso napoletano. Si tratta dell’installazione urbana che occupa una porzione di Largo Regio Parco da fine dicembre 2021, intitolata Flammarion: sette colonne cromate con una fiamma in cima, in tinta blu/viola cangiante come il colore del gas, disposte in cerchio, su una base rialzata che fa da contenitore a dei fari puntati verso il cielo. Anche in questo caso, l’opera è il risultato di una convergenza di interessi pubblici e privati, cioè di una collaborazione tra la Città di Torino e il Gruppo Italgas, la cui sede attuale si trova proprio all’incrocio tra corso Palermo e viale Regio Parco. Flammarion nasce infatti a completamento della ristrutturazione della sede, che ha compreso la ripavimentazione del piazzale antistante gli ingressi principali e dei marciapiedi che circondano il suo lungo perimetro. L’antica relazione tra Torino e l’azienda (Italgas ha ottenuto i natali nel 1837) si inserisce all’interno di una pratica che in città si sta sempre più consolidando e affinando. Il governo locale, infatti, agisce spesso in sinergia con grosse imprese private che, con i loro investimenti sopperiscono alla mancanza di fondi pubblici, o li integrano, partecipando attivamente ai processi di riqualificazione urbana. E in nome di questa sinergia, certe funzioni che sono sempre state esclusiva del pubblico sempre più facilmente vengono condivise con soggetti privati.
Ad aggiudicarsi la commissione dell’opera è stato il “maestro” Oliviero Rainaldi, artista che vanta numerosi interventi pubblici eseguiti per grandi firme come Maserati e il Vaticano. Nel comunicato che annuncia la sua collocazione, essa è descritta come “un cerchio che permette di accogliere e abbracciare idealmente la città in un dialogo continuo tra il passato e presente, tra la storia del Gruppo e quella di Torino”. Come nel caso della Venere, anche qui il movente è autocelebrativo e le premesse sono democratiche e inclusive. A differenza della Venere, l’installazione torinese non è mai stata “vandalizzata”, ma un episodio recente, rimasto nell’ombra, fa presagire quale destino spetterebbe all’eventuale autore della sua violazione. Passando da lì, una domenica pomeriggio, sento partire una voce femminile amplificata ad altissimo volume che dice una cosa tipo “attenzione, è vietato avvicinarsi all’opera… allontanarsi immediatamente o sarà richiesto l’intervento delle autorità”. La voce si ripete una seconda volta e sembra quella di una dipendente dell’azienda. A farla attivare era stata una donna che, mentre passava accanto all’opera, era salita sul suo basamento circolare per giocare con la luce del faro incastonato per terra. Non proprio un gesto vandalico; eppure, tanto è bastato a motivare un rimprovero autoritario e una minaccia di punizione.
Lo slargo su cui insiste l’opera è sorvegliato da un gruppo di tre telecamere, una delle quali è dotata di intelligenza artificiale e fa parte del progetto di videosorveglianza Argo, attivato dalla Città di Torino nel 2020 con lo scopo di “aumentare la percezione di sicurezza degli abitanti”. A questo trio, più recentemente, si è aggiunto un altoparlante che al bisogno, e in maniera del tutto arbitraria, diventa la voce fuori campo che redarguisce chi vìola la barriera invisibile tra pubblico e privato. Ma se lo spazio dell’opera è pubblico, cosa giustifica questa condotta autoritaria? E se questo spazio, invece, è privato e inviolabile, non sarebbe più onesto costruirgli intorno una gabbia metallica, anziché la narrazione fasulla dell’arte pubblica come abbraccio inclusivo nei confronti della città?
Il Gruppo Italgas ha previsto per la città di Torino un investimento di cinquecentotrenta milioni di euro in dieci anni. Trentacinque sono destinati al recupero della sede storica di corso Regina Margherita, dove nascerà un “nuovo polo dell’innovazione”. Nel comunicato che rende pubblica l’approvazione del progetto, risalente allo scorso giugno, si legge che insieme alla ristrutturazione degli edifici l’azienda effettuerà “interventi migliorativi delle aree pubbliche limitrofe alla sede, in particolare in corso Farini, con una nuova viabilità ciclabile e pedonale, estensione degli spazi verdi con aree gioco per i più piccoli e riqualificazione di parcheggi e aiuole”. Il sindaco Lo Russo ribadisce quanto questo investimento “contribuirà alla rigenerazione di un quartiere, rendendolo più verde, vivibile e attrattivo”. Se la vivibilità che questi soggetti hanno in mente corrisponde all’idea di uno spazio disegnato e controllato dall’alto, non è troppo fantasioso ipotizzare che anche queste aree verranno tempestate di dispositivi di sicurezza e che il loro utilizzo sarà normato, magari con la scusa di nuove opere d’arte da dover difendere.
In entrambi i casi, la natura aperta dell’opera pubblica, la sua permeabilità, la sua disponibilità all’incontro col pubblico fruitore vanno in frantumi, e l’opera stessa non rimane altro che un pretesto per sottrarre spazio pubblico all’uso autogestito dagli abitanti, una ragione in più per vigilare sul loro comportamento ed eventualmente sanzionarli moralmente e materialmente. Quelli che la retorica istituzionale vuole far passare come “beni comuni” capaci di arricchire la città contemporanea, nella pratica sono monumenti celebrativi dell’arroganza di politici, investitori privati e specialisti dell’arte; attraverso di essi, le istituzioni decretano e riaffermano costantemente quali contenuti possono essere esposti nello spazio pubblico e quali no, chi ha il diritto di esprimersi in questo spazio e chi no. L’arte pubblica come veicolo di inclusione, dialogo, bellezza, decoro, “qualità” è allora uno slogan utile a mascherare la prepotenza e il narcisismo delle politiche di riqualificazione urbana.
Eppure, in generale, a essere considerati prepotenti o ipocriti sono altri attori ancora dell’arte pubblica in senso esteso: i writer, i graffitisti, gli street artist. Nei loro confronti l’atteggiamento della critica d’arte e della politica è diversificato ma comunque ambiguo e contraddittorio. I primi due sono per lo più considerati “vandali” e il loro intervento sui muri delle città – quando disturba il decoro con messaggi conflittuali – viene criminalizzato, rimosso e, se possibile, sanzionato. Gli street artist – ugualmente “illegali” – sono più tollerati e, anzi, se si piegano alla committenza istituzionale, questa scelta è considerata inaccettabile perché è “la negazione della vocazione profonda della street art”. Di recente questa critica è emersa durante una puntata di Zazà (trasmissione domenicale di Radio3 Rai) dedicata alla street art. Nel corso di una intervista a più voci, a giudicare “la street art che lavora per la committenza di assessorati e potenti di turno” è proprio Trione, il consulente del sindaco di Napoli. In realtà, la street art si è istituzionalizzata da tempo divenendo un’etichetta commerciale e un oggetto da museo al pari di molte altre categorie e forme artistiche. In quest’ottica, gli street artist non si distinguono molto dai loro colleghi che operano nella più ampia scena audio-visuale e performativa. A snaturare la “vocazione profonda” della street art, semmai, è il fatto stesso di sentirsi comodi all’interno di questa categoria funzionale al potere. In altri termini, accusare gli street artist di “tradimento” dovrebbe portarci ad ammonire, per coerenza, tutti gli artisti che intervengono nello spazio pubblico su committenza pur partendo da un intento “sociale”, compreso il Pistoletto di turno. O sono tutti dei venduti, o vanno tutti assolti. Oppure, ancora, ampliamo la prospettiva, guardiamo questo fenomeno di asservimento in relazione al sistema che lo produce e facciamo in modo che ciascun attore di questo sistema – di cui gli street artist sono solo un piccolo tassello – si assuma le proprie responsabilità.
L’argomento comune a molti artisti che dalla clandestinità della strada finiscono per rincorrere il riconoscimento istituzionale suona pressappoco così: fare dell’arte il proprio mestiere, se non si ha le spalle coperte da parenti o altri sostenitori informali, significa vivere una condizione di precarietà economica pressoché perenne. Questa motivazione rende la scelta di mettersi al servizio della propaganda legittima in assoluto? No. Per quanto faticose, le alternative all’asservimento esistono, e l’esperienza longeva di cyop&kaf, citata nell’intervista radiofonica, è una testimonianza vivente di come il ritornello della precarietà sia spesso un alibi a cui molti artisti si aggrappano per evitare lo sforzo di sperimentare modi, vie e spazi alternativi.
Alibi a parte, nell’elaborare il nostro giudizio sugli artisti asserviti potremmo valutare caso per caso e considerare che tipo di commissione si accetta, quali sono le sue ricadute materiali e simboliche, chi la accetta, da quale posizione, con che tipo di approccio, aspettative, ambizioni. Allo stesso tempo, nel formulare un giudizio dovremmo forse misurarci con la posizione da cui noi stessi parliamo, cioè, con il soggetto e il luogo dell’enunciazione. La critica in questione, da questo punto di vista, appare legittima e sensata quando proviene da altri artisti che hanno saputo mantenere la loro posizione tenendosi alla larga dai riflettori dell’arte ufficiale, ma discutibile e sospetta quando proviene dagli stessi rappresentanti delle istituzioni politiche o artistiche che di quell’asservimento approfittano e si nutrono. Non sono proprio questi presunti “rigeneratori sociali” che dovrebbero, prima di altri, interrogare il proprio ruolo all’interno del processo di cattura? Non sono loro i primi a tradire la natura democratica dell’arte pubblica, quando trasformano le opere urbane in santuari del potere da preservare a colpi di telecamere e sanzioni penali? Queste domande sono retoriche, perché il mestiere degli attori istituzionali è quello di confermare, proteggere e rassicurare i poteri che incarnano, e la maschera discorsiva che fa apparire le loro azioni e critiche ipocrite come legittime e credibili si è solidificata e normalizzata. Continuare a porle, allora, significa non volersi rassegnare alle loro menzogne. (alessandra ferlito)


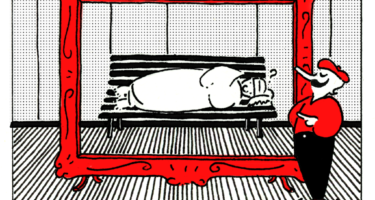


Leave a Reply