
All’inizio dell’estate tornano sempre. Questa era la frase che ripeteva fra sé e sé, quando sentiva bussare alla porta e si rendeva conto che maggio era arrivato.
All’alba si presentavano in cinque o sei davanti a ogni casa, o “modulo abitativo”, e bum, bum, bum: la cartellina stretta fra le braccia, il distintivo bene in vista e un sorriso anomalo sul volto.
Gli interventi per ripristinare l’ordine e la sicurezza avvenivano sempre quando la figlia gli chiedeva di gonfiare la ciambella rossa e nera che ricordava una coccinella. L’avevano comprata al mare, a Tor San Lorenzo, qualche anno prima. E anche allora, come adesso, il sapore di sale era anticipato dall’angoscia di non sapere se tutto ciò che li riguardava, fino a quel momento, fosse davvero in ordine e in sicurezza.
A seconda dell’orario i figli accoglievano i poliziotti con smorfie più o meno lucide. Quando arrivavano intorno alle sei capitava che fossero già svegli, seduti al tavolo intenti a inzuppare il maggior numero possibile di biscotti nel latte.
Come vi chiamate, con chi vivete, andate a scuola, avete i documenti, vi piace il latte, anche a mio figlio piace tanto.
Gli scambi erano raramente reciproci e il più delle volte la sorella maggiore si affrettava a chiarire che loro erano minori e che, se proprio avessero voluto fare domande, avrebbero dovuto parlare con i genitori.
I genitori avevano entrambi quarant’anni e avevano vissuto esattamente metà della loro esistenza tra i campi rom della Capitale. O’ kampo del resto era una certezza, perfino sulla segnaletica stradale potevi scorgerne la presenza: direzione campo nomadi, girare a destra. Quel termine – nomadi – li faceva sorridere, considerando che tutte le volte che si erano spostati era perché qualcuno, manganello da una parte e ruspa dall’altra, gli ricordava che no, quella non era casa loro.
Adesso però la situazione era cambiata. Da molti anni erano fermi lì e tutto era rimasto pressoché identico, solo più povero. Il campo si era svuotato, alcuni della comunità erano stati trasferiti altrove, altri erano tornati in Bosnia o in Romania, altri – pochissimi – erano riusciti a scalare la graduatoria e vivevano in una casa popolare.
Per loro l’unica parentesi dal campo era stato il carcere, ma di quello, un po’ per superstizione un po’ per dolore, evitavano di parlare. Il più piccolo dei figli aveva imparato a camminare lì, nel corridoio che collegava la stanza della socialità al gabbiotto dell’assistente. Ora aveva nove anni, era campione di corsa campestre e gli piaceva raccontare la prima passeggiata della sua vita come un acerbo tentativo d’evasione.
Lui, più degli altri, si era abituato alle irruzioni della polizia e sapeva che la maggior parte delle volte si risolveva con un controllo generico dei documenti, qualche avvertimento e tanti saluti. Ma questa volta gli era sembrata diversa. I poliziotti, centinaia, erano entrati più presto del solito e, mappa alla mano, si erano spartiti meticolosamente le abitazioni.
Il padre era insolitamente turbato. Continuava ad agitare un foglio davanti agli occhi del poliziotto che, inamovibile, lo guardava senza espressioni di sorta. Dopo un’ora di discussione il figlio campione di corsa campestre vede i poliziotti portare via il padre.
Andrà in questura, dicono alla madre, poi in un Cpr a Milano e infine rimpatriato.
In che senso?
E in che senso signo’? Nel senso che le abbiamo detto, i documenti sono scaduti e suo marito qua non ci può più stare.
Ma lui aveva fatto richiesta di rinnovo.
A noi non risulta. Su, faccia il favore, arrivederci.
E fu così che una mattina di maggio, a Roma, duecento poliziotti lasciarono in ordine e in sicurezza quel deserto reputato idoneo dalle autorità per far vivere uomini donne e bambini.
Lì dove manca l’acqua potabile e le fognature non esistono, dove l’unico collegamento con la città è un autobus che a volte non si ferma perché vatti a fidare di chi può salire, dove i rifiuti non vengono raccolti e allora son bruciati e l’aria tossica ti si appiccica addosso finché non ti abitui a respirare anche la merda. Lì dove ormai non puoi più far nulla, fai una qualunque cosa, come portar via un uomo, in una mattina di maggio. (marica fantauzzi)
P.S. Il racconto romano è ispirato a fatti realmente accaduti pochi giorni fa nel campo di Castel Romano: costruito nel 2005 dal Comune lungo la via Pontina, dista venticinque chilometri dal centro città e si estende per 41.750 metri quadrati. Nasce come mega insediamento istituzionale e diventa presto uno dei campi più grandi d’Italia. Oggi ci vivono circa seicento persone di cui la metà minori. L’operazione interforze del 30 maggio scorso è stata definita “un successo” dal prefetto di Roma. L’uomo fermato, si scoprirà poi, era regolarmente soggiornante e in attesa di rinnovo con appuntamento a settembre: non poteva essere trasferito. Il rilascio è avvenuto solo grazie alla determinazione di una giovane donna, che qui chiameremo Rita e che qui, ancora una volta, ringraziamo.




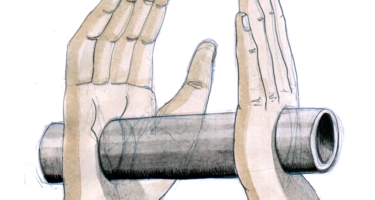
Leave a Reply