
Da un anno i migranti sono scomparsi dal dibattito pubblico. Quello che sembrava essere diventato l’unico argomento di cui parlare, il concentrato di tutti i problemi del paese, è stato cancellato via con un colpo di spugna da un’altra emergenza. Ma gli sbarchi non si sono fermati con la pandemia.
Dhouha parte dalla Tunisia con suo marito per sbarcare a Lampedusa la notte del 27 agosto 2020. Lì restano tre giorni, insieme ad altre persone ammassate una sull’altra, senza dormire né mangiare. Al secondo giorno viene fatto loro il tampone. Non l’avevano mai visto fare, si erano informati su cosa fosse tramite qualche video sui social. Ventiquattr’ore per attendere l’esito. Negativo. Vengono trasferiti in un centro quarantena, che non dovrebbe ospitare più di ottanta persone, ma in realtà ne contiene più di centotrenta. Non ci sono letti a sufficienza e gli uomini dormono per terra, nei corridoi. Al termine dei diciotto giorni di quarantena alcuni migranti risultano positivi al tampone e così viene comunicato loro che tutti devono stare lì per altri diciotto giorni. Un gruppo di ospiti di nazionalità egiziana, appresa la notizia, iniziano una rivolta. Alcuni mettono fuoco al centro e scappano. Tutti gli altri vengono trasferiti in un altro centro a dieci chilometri di distanza, anche questo sovraffollato. Per quattro giorni tutte le persone ospiti del centro dormono nella stessa stanza. «Era sporco – racconta Dhouha –. Ti davano sempre e soltanto riso e pasta, a volte era anche andato a male. Spesso per non mangiare quel cibo mangiavamo soltanto pane. Condividevamo un bagno in nove persone. Spesso mancava l’acqua, l’acqua calda invece non c’era proprio mai. Un giorno ho iniziato a sentirmi male, a vomitare, sono svenuta. Mi hanno portata in ospedale e là il medico mi ha detto che era tutto ok e potevo andarmene, ma io non sapevo la strada per tornare al centro, non sapevo dove andare».
In questo centro Dhouha e suo marito restano per altri venticinque giorni. «Nessuno ti spiega niente. Quando è cominciata la rivolta degli egiziani ho avuto paura che ci riportassero in Tunisia per colpa loro. Non sapevo che era così fare la quarantena. Ti senti in carcere. Non puoi fare niente, non c’è internet. Puoi solo mangiare e dormire. Ma non riesci neanche a dormire, perché la notte c’è chi prova a scappare e arriva la polizia. Io pensavo che magari dopo aver sopportato quel viaggio e dopo che adesso stavo sopportando tutto questo, poi mi avrebbero riportata in Tunisia. La mia paura era questa, perché molti dopo la quarantena li hanno riportati in Tunisia».
Dopo venticinque giorni e un altro tampone con esito negativo, Dhouha e il marito vengono fatti salire su un pullman e trasferiti in un centro di seconda accoglienza in un paesino dell’entroterra campano. Dice del viaggio: «Non sapevo dove stavamo andando, quanto sarebbe durato il viaggio. Nessuno sapeva niente. Sul pullman uno dei ragazzi che viaggiava con noi aveva problemi psichici e ha iniziato a urlare e a denudarsi. Io avevo paura che ci riportassero indietro, paura che mi separassero da mio marito. Da quando sono in Italia io ho paura».
Adesso Dhouha sta meglio, porta da mangiare ai cani e ai gatti del paese, dei quali ha imparato tutti i nomi, coltiva la speranza di far venire in Italia anche il suo cane, che considera come un figlio, frequenta la scuola per adulti e sta per iniziare un corso di formazione professionale. La didattica a distanza risulta particolarmente complicata per chi si trova a dover imparare una nuova lingua e a condividere la connessione internet con altre persone, tutte impegnate nelle lezioni. Nel rapporto Oxfam pubblicato lo scorso gennaio e intitolato “Il virus della disuguaglianza” è stato evidenziato come, per la prima volta da quando viene monitorata, la disuguaglianza aumenterà simultaneamente in quasi tutti i paesi del mondo. La crisi del coronavirus si è abbattuta su un mondo già estremamente disuguale, in cui il crescente divario tra ricchi e poveri alimenta antiche disuguaglianze di genere e di razza. Il Dossier statistico immigrazione 2020, realizzato dal Centro studi e ricerche Idos in partenariato con il Centro studi Confronti, sottolinea come la pandemia abbia aggravato le già difficili condizioni di vita di molti migranti. La sanatoria annunciata dall’allora ministra Bellanova si è rivelata un’occasione mancata, dato che, a fronte di circa 621 mila lavoratori stranieri irregolari, sono state presentate soltanto 207 mila domande. Secondo Gianfranco Schiavone dell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione, la ragione va rintracciata nell’impostazione della norma, basata sulla volontà del datore di lavoro di far emergere il rapporto dall’irregolarità. Secondo Marco Omizzolo di Eurispes, nel settore agricolo l’emergenza Covid ha fatto registrare un incremento del 15-20% di stranieri sfruttati, con un peggioramento delle condizioni di lavoro, un incremento dell’orario lavorativo e un peggioramento della retribuzione. Nella prima fase della pandemia, le restrizioni degli spostamenti, seppur necessarie a contenere il contagio, hanno finito per aumentare le pratiche di respingimento dei migranti. Un documento sottoscritto da più di centosessanta organizzazioni – Medici senza frontiere e Associazione delle organizzazioni italiane di cooperazione e solidarietà internazionale, solo per citarne alcune – ha evidenziato le criticità relative all’utilizzo delle navi quarantena, ricordando i casi di suicidio e autolesionismo verificatisi tra i migranti durante la quarantena. Tra le richieste principali rivolte da queste organizzazioni al governo ci sono quella di dismettere questo tipo di navi e reinvestire la cospicua somma di denaro utilizzata in questa misura per adeguare centri di accoglienza a terra dove le persone possano svolgere, nel rispetto di tutti i propri diritti, il dovuto periodo di isolamento; inoltre, di fornire nell’immediato comunicazioni pubbliche frequenti ed esaustive sulla situazione a bordo delle navi quarantena, oltre a garantire un’adeguata informazione legale e sanitaria a tutte le persone confinate sulle navi.
Le complicazioni dovute alla pandemia non si esauriscono con la fine della quarantena. Le restrizioni alla mobilità costringono molti a dipendere dagli operatori dei centri d’accoglienza, relegandoli in una posizione di passività e rendendo difficili sia i contatti con altri connazionali, che costituiscono la prima rete di supporto informale, sia i contatti con persone del posto per allargare la propria rete di nuove relazioni. Il tempo appare come una sospensione per chi transita da un paese all’altro, da una vita all’altra. Una sospensione fatta di permanenza nei centri d’accoglienza, di attese di responsi da parte delle commissioni territoriali, di esiti di ricorsi. A questa sospensione si aggiunge un altro tempo sospeso, che è quello della pandemia e che rischia di far diventare le attese una bolla gigantesca senza via d’uscita, senza la minima possibilità di progettare il futuro. Eppure tutto questo non esiste in un dibattito pubblico regolato dalla logica dell’emergenza, in cui basta un’emergenza nuova per scaraventare in un cono d’ombra quella precedente. (giulia tesauro)


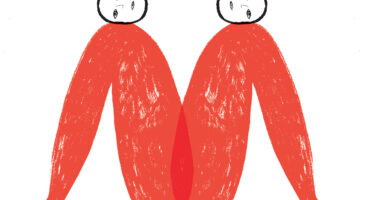


1 Comment