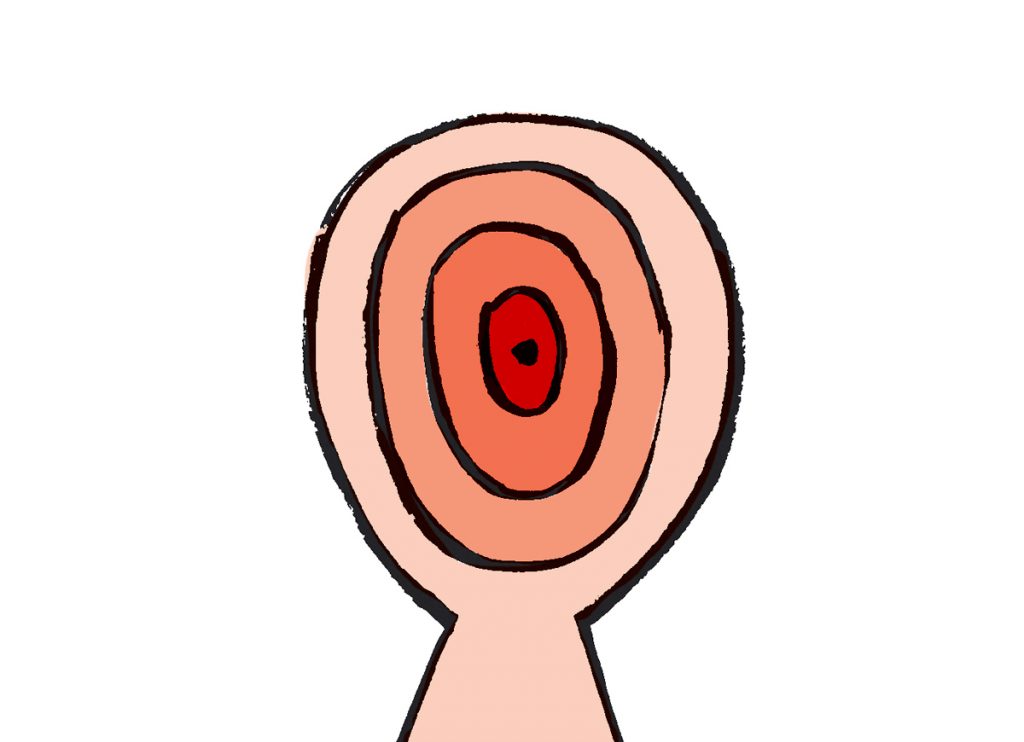
Dal 25 ottobre è in libreria nelle principali città d’Italia (qui indice e distribuzione) il numero uno de Lo stato delle città. Dalla rivista pubblichiamo integralmente l’articolo Arte pubblica e asservimento di Cyop&Kaf.
* * *
Da molti anni ormai, con due tre amici che come me frequentano loro malgrado il sottobosco dell’arte pubblica, abbiamo un fitto scambio di mail. Sono proposte di “lavoro”. Il bestiario dei mittenti è variegato: associazioni dalle idee brillanti, burocrati creativi, attivisti inconsapevoli, politici camuffati. Per i “buoni” questi inviti vertono sulla presunta voglia di “rigenerare con l’arte”, inutile dire che deve esserci la “partecipazione del territorio”, che la cosa deve partire “dal basso” e via via tutto un corollario di parole usurate ripetute ossessivamente, come un rosario.
La maggior parte di queste richieste di collaborazione non viene tanto dalle istituzioni, quanto dai suoi diretti intermediari, figure ambigue che sguazzano in un brodo di parole scivolose e inconcludenti, eppure dal taumaturgico effetto. La rigenerazione urbana, praticata col grimaldello dell’arte, talvolta ha avuto effetti dirompenti – a Napoli penso alla metro dell’arte – nel bene (nuovi servizi) e nel male (affitti alti intorno alle stazioni), ma il più delle volte siamo di fronte a miseri fallimenti che – e qui il vero e sottaciuto risultato – soddisfano solo l’immediata ricerca di consenso dei promotori di turno. Consenso che ovviamente costi poco (o nulla) e sia ben visibile. E allora, cosa c’è di meglio di un bel dipinto sulla facciata muta di un palazzo? Magari in un bel quartiere “difficile”. È la vecchia scorciatoia del massimo profitto col minimo sforzo, secondo un capitalismo rinnovato ma che al nocciolo è sempre sé stesso.
A mo’ di esempio – succede che in occasione del festival di Sky arte (2017) venga dipinta l’intera facciata del Damm, storico centro sociale di Montesanto, mentre contemporaneamente, davanti alla stazione della Cumana nello stesso quartiere, un muscoloso servizio d’ordine venga allestito a protezione dell’intervento pittorico dell’artista Roxy in the box, finendo con il tumulare l’approccio libertario che da sempre contraddistingue chi opera per le strade.
Questa letale commistione di artisti, amministratori d’infimo calibro, associazionismo, banche, centri sociali più o meno condonati, produce – ancor prima di un’estetica consolatoria – estrema confusione tra fini e mezzi. Si prende per buono il prodotto finale mettendo in ultimo piano – o inquinandoli con monetizzazione, burocrazia, asservimento al messaggio – processo e relazioni. La fetta di città che si pretende “rigenerata” viene utilizzata come sfondo, trasformando le persone in fantasmi, come nei render che si vedono ai festival di architettura. Potrebbero dire: stiamo dipingendo una parete, invece no, ci devono aggiungere un carico di retorica insostenibile che, sommato a un utilizzo servile dei nuovi dispositivi digitali, finisce per fomentare quel narcisismo di massa che sta narcotizzando ogni piega del qui e ora. I vicoli sembrano essere diventati il campo semantico privilegiato del marketing, senza sostanziali differenze tra videoclip musicali, dolce&gabbana, cuoredinapoli.
Chi ci scrive queste proposte, continua a farlo con un misto di riverenza figlia di falsa coscienza (grazie per quello che fate) e una disattenzione pressoché totale all’opera. È come se – abituati a scorrere immagini col pollice – di un lavorio articolato e complesso si cogliesse giusto l’apparenza fugace dei pixel in superficie. Deve essere solo per questo che continuiamo a ricevere inviti a fare le cose più lontane dal nostro modo di operare. I “cattivi”, per esempio, ci chiedono di dipingere per quei grandi marchi (ma anche banche, fondi di credito e simili) che, intuito il potenziale di circolazione delle immagini della “street art” provano – trovando sempre qualcuno disposto a prestarsi al gioco – a rendersi cool, colorati ma anche un po’ ribelli.
Quello che accomuna “buoni” e “cattivi” è il linguaggio, che finisce con il livellare tutte le presunte differenze, mischiando le ingenue speranze degli uni all’allegro cinismo degli altri. Entrambi, tanto per fare un esempio, utilizzano il crowdfunding (il finanziamento della folla) come forma di finanziamento. Alcuni per reale esigenza, ma inconsapevoli che lo strumento poi ti costringe a strizzare l’occhio agli eventuali sostenitori, a dimostrare, ecco. Ma perché dover spiegare una passione? Perché sentirsi costretti a raccontarla alla folla? E in una lingua obbligatoriamente entusiasta, zeppa di punti esclamativi. In fin dei conti si normalizza e rende abituale quel linguaggio pubblicitario che qualsiasi cosa va dicendo lo fa come un imperativo che nel farsi “progresso” diventa morale. Quando poi vedi che la “raccolta fondi dal basso” viene usata anche da chi non ne avrebbe alcun bisogno, giusto per costruire attorno a sé un’immagine fasulla di comunità, allora capisci che il cerchio è chiuso, e dentro il cappio c’è il tuo collo.
Per questo e per tanti altri motivi non dipingo più per strada. A dire il vero non dipingo quasi più, e a chi mi scrive di solito rispondo “preferirei di no”, come Bartleby lo scrivano, provando, come lui, a far saltare insieme al linguaggio, la dialettica schiavo-padrone. Agamben mi viene in soccorso, fornendo una teoria alla mia pratica. Stare fermi – potere la propria impotenza – talvolta è necessario, perché “la potenza è definita dalla possibilità del suo non-esercizio: la potenza è una sospensione dell’atto. […] E, tuttavia, la potenza-di-non non può essere a sua volta padroneggiata e trasformata in un principio autonomo che finirebbe con l’impedire ogni opera. Decisivo è che l’opera risulti sempre una dialettica fra questi due principi intimamente congiunti”.
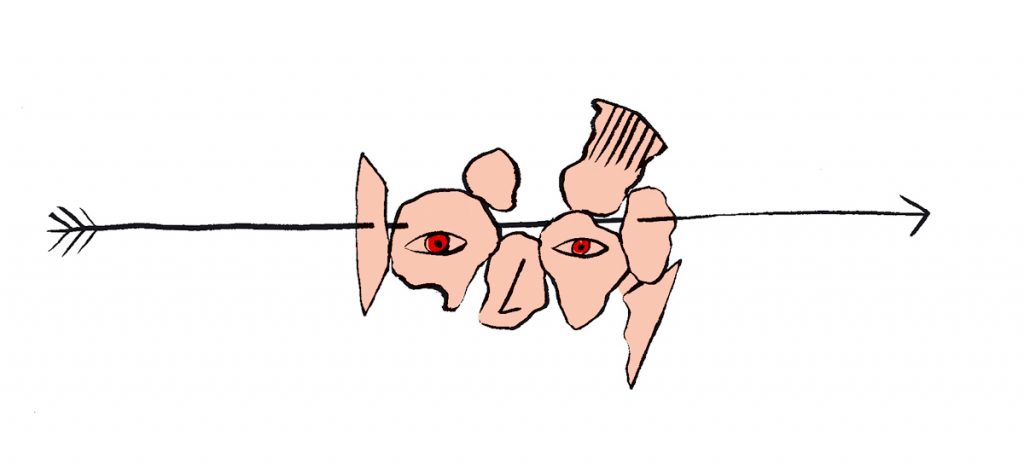
Mi piacerebbe scrivere una biografia al negativo, raccontando tutto quello che non ho fatto. Di sicuro servirebbe a chiarire tutto il resto. All’inizio procedevo a tentoni, e certe cose le ho capite col tempo. Ho praticato il luddismo (una volta per Nike feci un dipinto talmente insostenibile ai loro occhi che spaccarono il pannello davanti al pubblico) ma non funziona: non scalfisce minimamente i giganti e finisce solo col portare acqua al tuo ego di apparente antagonista. Ho provato con l’anonimato, prendere i soldi e scappare. Ferrarelle vuole un murale con degli “scugnizzi” che giocano a calcio, con bottiglia in primo piano. Non cercavano proprio me (il mio stile), ma un writer qualunque “su Napoli”. Cercavano un’esecuzione. Era il periodo in cui si discuteva di globalizzazione, acqua ai privati e via dicendo, quindi scoprii senza sforzo che la concessione all’azienda – risalente a molti anni prima – gli dava il diritto di prendere l’acqua alla fonte per una ridicola cifra annuale. A ogni modo non avevo un soldo e decisi di farlo. Invio la fotografia-prova, mi pagano, e il giorno successivo vado a coprire tutto.
Racconto quest’episodio non per rivendicare un sabotaggio di cui vado fiero, quanto piuttosto per mettere in luce quel meccanismo che ci ha portato dritti alle camere a gas: è il mio lavoro, se non lo faccio io lo farà qualcun altro. Ecco, mi chiedo, come sottrarsi a tutto questo? A noi che dipingiamo in strada viene chiesto di accettare una cornice di regole dalla quale al massimo possiamo sottrarci, finendo con l’alimentare il mito dell’artista ribelle, mito che a sua volta non fa altro che lievitare le quotazioni dalle quali fuggiamo. Mi si dirà: ma perché vendi quadri allora? Per vivere ovviamente, e continuare a farlo creando opere che mettano in discussione gli stessi processi che le rendono possibili. Sei fortunato, mi dicono dei miei amici operai (guadagno meno di loro – questo non lo sanno –, lavoro fisicamente meno ma ho ridotto i bisogni quasi a zero). Mi chiedono come faccio a rifiutare i tanti soldi che mi offrono per fare solo un disegno. Gli rispondo che lo faccio per la salute. Accettare certe proposte mi darebbe uno sconforto maggiore di quello che vivo adesso, mentre sono immerso in un irrefrenabile desiderio d’immobilità.
Forse l’equivoco è nella visibilità, mito fondante dei graffiti – i treni dipinti in qualche modo hanno anticipato il web – che sì, è vero, porta cibo nel tuo piatto, aria nel tuo petto, però nessuna avvertenza ti dice che oltre una certa soglia t’avvelena. Penso spesso a Blu che si è visto costretto, tempo fa, a negare all’intera Bologna le sue opere pur di sottrarle al nemico che avanzava (privati che staccano pezzi di muro per esporli al chiuso), un po’ come i russi che davano fuoco alle loro stesse città per rendere impossibile l’avanzata ai nazisti.
Un meccanismo inesorabile ci vuole famosi o morti di fame. Eppure mi hanno insegnato che “bisogna rifiutare di scegliere tra l’orgia e l’ascesi”. Non mi è chiaro come, per questo resto nell’impotenza. So solo che avrei voluto continuare quanto avevo cominciato a fare tra Napoli e Taranto, che poi altro non era che ricerca sul nel col campo. Avrei voluto, con le dovute differenze, aggiornare le indagini di Levi, Rossi-Doria, Belmonte, Fava. Farlo con i mezzi che stavo imparando a maneggiare, la pittura e la presenza, la storia orale e l’assenza di giudizio. Perché non posso continuare allora? Perché come ogni cosa che minimamente va costruendo uno sguardo nuovo sulle cose, l’arte pubblica è stata ingoiata, digerita e neutralizzata, finendo col rendere pressoché impossibile qualsiasi tentativo di restare ai margini di quella narrazione che scaraventa tutto in un unico calderone.
Nel frattempo soffro, stringo i denti ma pure prendo appunti, studio, ipotizzo tracciati. Penso a certi poeti giapponesi che scrivono a terra con l’acqua, versi brevi e fulminei che evaporano nel giro di pochi secondi; penso a quell’uccello africano che dice: da quando l’uomo ha una mira infallibile ho imparato a volare senza mai posarmi; penso a Cristo, che scrisse una sola volta alcune parole che la sabbia si incaricò di cancellare. Penso che “le libertà concesse sono false libertà”; o, come Voltaire, che le streghe hanno smesso di esistere nell’attimo in cui abbiamo smesso di bruciarle. Per questo ci hanno voluto eroi, e la nostra resistenza, quando c’è stata, è stata troppo flebile.
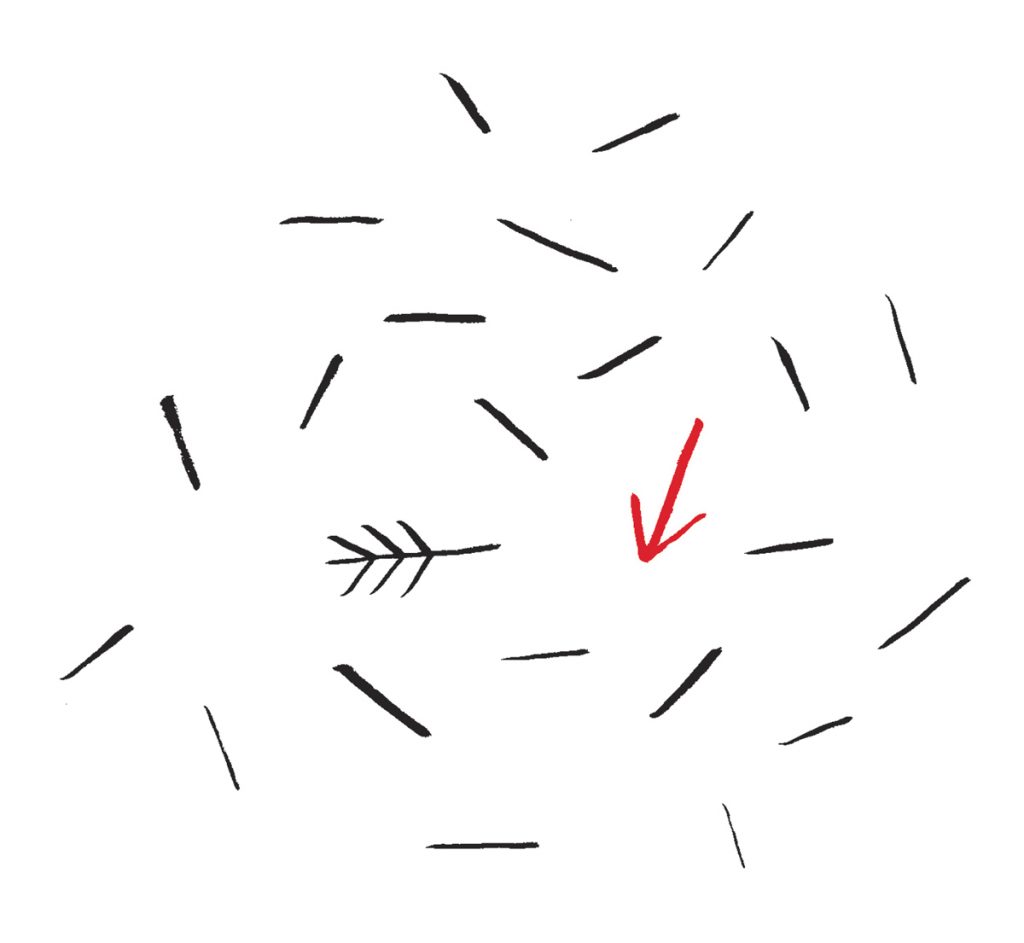
Non è la prima e non sarà l’ultima volta che ci tagliano le gambe. Ciclicamente il che fare? ritorna, e questo può fare solo bene. Dice un mio amico – un fotografo divenuto cieco – che è sempre possibile trovare una soluzione: «Pensa a Solženicyn, non poteva prendere appunti nel gulag, eppure ha scritto nella sua mente più di mille pagine, aiutandosi con uno spago e delle briciole di pane per rammentare le separazioni tra i paragrafi».
Al momento tendo a una disperazione che non è nemmeno più “gravida di speranza”, è una disperazione che si è fatta sterile. Allora penso pure a un vecchio maestro che mi diceva: l’arte è quell’edificio che demolisce le fondamenta sulle quali è costruito. Ecco, la tabula è rasa, pronta ad accogliere parole altre. Come queste, non a caso: “Quando la mia disperazione dice: abbandonati allo sconforto, perché il giorno è racchiuso tra due notti, la falsa consolazione urla: spera, perché la notte è racchiusa tra due giorni. L’uomo non ha però bisogno di una consolazione che sia un gioco di parole, ma di una consolazione che illumini. Se voglio vivere in libertà, dev’essere – per ora – all’interno di queste forme. Il mondo è dunque più forte di me. Al suo potere non ho altro da opporre che me stesso – il che, d’altra parte, non è poco. Finché infatti non mi lascio sopraffare, sono anch’io una potenza. E la mia potenza è temibile finché ho il potere delle mie parole da opporre a quello del mondo, perché chi costruisce prigioni s’esprime meno bene di chi costruisce la libertà. Questa è la mia unica consolazione. So che le ricadute nella disperazione saranno molte e profonde, ma il ricordo del miracolo della liberazione mi sostiene come un’ala verso una meta vertiginosa: una consolazione più bella di una consolazione e più grande di una filosofia, vale a dire una ragione di vita”.
Il corsivo è mio. Le parole di Stig Dagerman, che però – fa male ricordarlo – in una camera a gas, ci si è messo da solo.


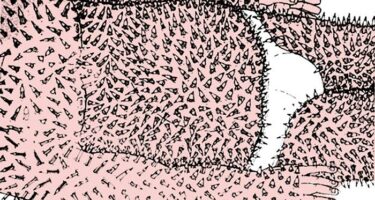


Leave a Reply